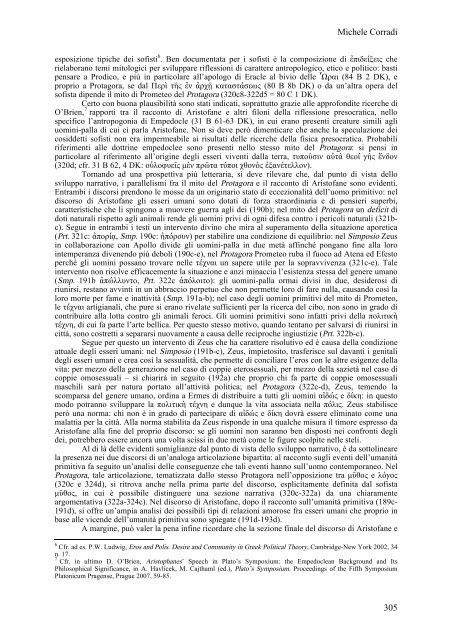You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Michele Corradi<br />
esposizione tipiche dei sofisti 6 . Ben documentata per i sofisti è la composizione di ἐπιδείξεις che<br />
rielaborano temi mitologici per sviluppare riflessioni di carattere antropologico, etico e politico: basti<br />
pensare a Prodico, e più in particolare all’apologo di Eracle al bivio delle Ὧραι (84 B 2 DK), e<br />
proprio a Protagora, se dal Περὶ τῆς ἐν ἀρχῇ καταστάσεως (80 B 8b DK) o da un’altra opera del<br />
sofista dipende il mito di Prometeo del Protagora (320c8-322d5 = 80 C 1 DK).<br />
Certo con buona plausibilità sono stati indicati, soprattutto grazie alle approfondite ricerche di<br />
O’Brien, 7 rapporti tra il racconto di Aristofane e altri filoni della riflessione presocratica, nello<br />
specifico l’antropogonia di Empedocle (31 B 61-63 DK), in cui erano presenti creature simili agli<br />
uomini-palla di cui ci parla Aristofane. Non si deve però dimenticare che anche la speculazione dei<br />
cosiddetti sofisti non era impermeabile ai risultati delle ricerche della fisica presocratica. Probabili<br />
riferimenti alle dottrine empedoclee sono presenti nello stesso mito del Protagora: si pensi in<br />
particolare al riferimento all’origine degli esseri viventi dalla terra, τυποῦσιν αὐτὰ θεοί γῆς ἔνδον<br />
(320d; cfr. 31 B 62, 4 DK: οὐλοφυεῖς µὲν πρῶτα τύποι χθονὸς ἐξανέτελλον).<br />
Tornando ad una prospettiva più letteraria, si deve rilevare che, dal punto di vista dello<br />
sviluppo narrativo, i parallelismi fra il mito del Protagora e il racconto di Aristofane sono evidenti.<br />
Entrambi i discorsi prendono le mosse da un originario stato di eccezionalità dell’uomo primitivo: nel<br />
discorso di Aristofane gli esseri umani sono dotati di forza straordinaria e di pensieri superbi,<br />
caratteristiche che li spingono a muovere guerra agli dei (190b); nel mito del Protagora un deficit di<br />
doti naturali rispetto agli animali rende gli uomini privi di ogni difesa contro i pericoli naturali (321bc).<br />
Segue in entrambi i testi un intervento divino che mira al superamento della situazione aporetica<br />
(Prt. 321c: ἀπορίᾳ, Smp. 190c: ἠπόρουν) per stabilire una condizione di equilibrio: nel Simposio Zeus<br />
in collaborazione con Apollo divide gli uomini-palla in due metà affinché pongano fine alla loro<br />
intemperanza divenendo più deboli (190c-e), nel Protagora Prometeo ruba il fuoco ad Atena ed Efesto<br />
perché gli uomini possano trovare nelle τέχναι un sapere utile per la sopravvivenza (321c-e). Tale<br />
intervento non risolve efficacemente la situazione e anzi minaccia l’esistenza stessa del genere umano<br />
(Smp. 191b ἀπώλλυντο, Prt. 322c ἀπόλοιτο): gli uomini-palla ormai divisi in due, desiderosi di<br />
riunirsi, restano avvinti in un abbraccio perpetuo che non permette loro di fare nulla, causando così la<br />
loro morte per fame e inattività (Smp. 191a-b); nel caso degli uomini primitivi del mito di Prometeo,<br />
le τέχναι artigianali, che pure si erano rivelate sufficienti per la ricerca del cibo, non sono in grado di<br />
contribuire alla lotta contro gli animali feroci. Gli uomini primitivi sono infatti privi della πολιτικὴ<br />
τέχνη, di cui fa parte l’arte bellica. Per questo stesso motivo, quando tentano per salvarsi di riunirsi in<br />
città, sono costretti a separarsi nuovamente a causa delle reciproche ingiustizie (Prt. 322b-c).<br />
Segue per questo un intervento di Zeus che ha carattere risolutivo ed è causa della condizione<br />
attuale degli esseri umani: nel Simposio (191b-c), Zeus, impietosito, trasferisce sul davanti i genitali<br />
degli esseri umani e crea così la sessualità, che permette di conciliare l’eros con le altre esigenze della<br />
vita: per mezzo della generazione nel caso di coppie eterosessuali, per mezzo della sazietà nel caso di<br />
coppie omosessuali – si chiarirà in seguito (192a) che proprio chi fa parte di coppie omosessuali<br />
maschili sarà per natura portato all’attività politica; nel Protagora (322c-d), Zeus, temendo la<br />
scomparsa del genere umano, ordina a Ermes di distribuire a tutti gli uomini αἰδώς e δίκη: in questo<br />
modo potranno sviluppare la πολιτικὴ τέχνη e dunque la vita associata nella πόλις. Zeus stabilisce<br />
però una norma: chi non è in grado di partecipare di αἰδώς e δίκη dovrà essere eliminato come una<br />
malattia per la città. Alla norma stabilita da Zeus risponde in una qualche misura il timore espresso da<br />
Aristofane alla fine del proprio discorso: se gli uomini non saranno ben disposti nei confronti degli<br />
dei, potrebbero essere ancora una volta scissi in due metà come le figure scolpite nelle steli.<br />
Al di là delle evidenti somiglianze dal punto di vista dello sviluppo narrativo, è da sottolineare<br />
la presenza nei due discorsi di un’analoga articolazione bipartita: al racconto sugli eventi dell’umanità<br />
primitiva fa seguito un’analisi delle conseguenze che tali eventi hanno sull’uomo contemporaneo. Nel<br />
Protagora, tale articolazione, tematizzata dallo stesso Protagora nell’opposizione tra µῦθος e λόγος<br />
(320c e 324d), si ritrova anche nella prima parte del discorso, esplicitamente definita dal sofista<br />
µῦθος, in cui è possibile distinguere una sezione narrativa (320c-322a) da una chiaramente<br />
argomentativa (322a-324c). Nel discorso di Aristofane, dopo il racconto sull’umanità primitiva (189c-<br />
191d), si offre un’ampia analisi dei possibili tipi di relazioni amorose fra esseri umani che proprio in<br />
base alle vicende dell’umanità primitiva sono spiegate (191d-193d).<br />
A margine, può valer la pena infine ricordare che la sezione finale del discorso di Aristofane e<br />
6<br />
Cfr. ad es. P.W. Ludwig, Eros and Polis. Desire and Community in Greek Political Theory, Cambridge-New York 2002, 34<br />
n. 17.<br />
7<br />
Cfr. in ultimo D. O’Brien, Aristophanes’ Speech in Plato’s Sympoxium: the Empedoclean Background and Its<br />
Philosophical Significance, in A. Havlícek, M. Cajthaml (ed.), Plato’s <strong>Symposium</strong>. Proceedings of the Fifth <strong>Symposium</strong><br />
Platonicum Pragense, Prague 2007, 59-85.<br />
305