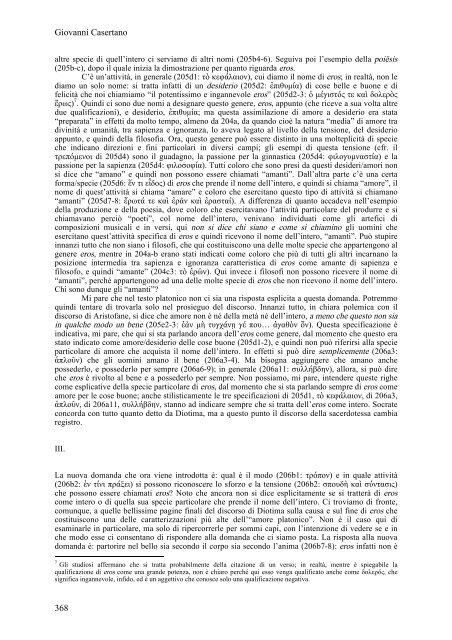You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Giovanni Casertano<br />
altre specie di quell’intero ci serviamo di altri nomi (205b4-6). Seguiva poi l’esempio della poiēsis<br />
(205b-c), dopo il quale inizia la dimostrazione per quanto riguarda eros.<br />
C’è un’attività, in generale (205d1: τὸ κεφάλαιον), cui diamo il nome di eros; in realtà, non le<br />
diamo un solo nome: si tratta infatti di un desiderio (205d2: ἐπιθυµία) di cose belle e buone e di<br />
felicità che noi chiamiamo “il potentissimo e ingannevole eros” (205d2-3: ὁ µέγιστός τε καὶ δολερὸς<br />
ἔρως) 7 . Quindi ci sono due nomi a designare questo genere, eros, appunto (che riceve a sua volta altre<br />
due qualificazioni), e desiderio, ἐπιθυµία; ma questa assimilazione di amore a desiderio era stata<br />
“preparata” in effetti da molto tempo, almeno da 204a, da quando cioè la natura “media” di amore tra<br />
divinità e umanità, tra sapienza e ignoranza, lo aveva legato al livello della tensione, del desiderio<br />
appunto, e quindi della filosofia. Ora, questo genere può essere distinto in una molteplicità di specie<br />
che indicano direzioni e fini particolari in diversi campi; gli esempi di questa tensione (cfr. il<br />
τρεπόµενοι di 205d4) sono il guadagno, la passione per la ginnastica (205d4: φιλογυµναστία) e la<br />
passione per la sapienza (205d4: φιλοσοφία). Tutti coloro che sono presi da questi desideri/amori non<br />
si dice che “amano” e quindi non possono essere chiamati “amanti”. Dall’altra parte c’è una certa<br />
forma/specie (205d6: ἕν τι εἶδος) di eros che prende il nome dell’intero, e quindi si chiama “amore”, il<br />
nome di quest’attività si chiama “amare” e coloro che esercitano questo tipo di attività si chiamano<br />
“amanti” (205d7-8: ἔρωτά τε καὶ ἐρᾶν καὶ ἐρασταί). A differenza di quanto accadeva nell’esempio<br />
della produzione e della poesia, dove coloro che esercitavano l’attività particolare del produrre e si<br />
chiamavano perciò “poeti”, col nome dell’intero, venivano individuati come gli artefici di<br />
composizioni musicali e in versi, qui non si dice chi siano e come si chiamino gli uomini che<br />
esercitano quest’attività specifica di eros e quindi ricevono il nome dell’intero, “amanti”. Può stupire<br />
innanzi tutto che non siano i filosofi, che qui costituiscono una delle molte specie che appartengono al<br />
genere eros, mentre in 204a-b erano stati indicati come coloro che più di tutti gli altri incarnano la<br />
posizione intermedia tra sapienza e ignoranza caratteristica di eros come amante di sapienza e<br />
filosofo, e quindi “amante” (204c3: τὸ ἐρῶν). Qui invece i filosofi non possono ricevere il nome di<br />
“amanti”, perché appartengono ad una delle molte specie di eros che non ricevono il nome dell’intero.<br />
Chi sono dunque gli “amanti”?<br />
Mi pare che nel testo platonico non ci sia una risposta esplicita a questa domanda. Potremmo<br />
quindi tentare di trovarla solo nel prosieguo del discorso. Innanzi tutto, in chiara polemica con il<br />
discorso di Aristofane, si dice che amore non è né della metà né dell’intero, a meno che questo non sia<br />
in qualche modo un bene (205e2-3: ἐὰν µὴ τυγχάνῃ γέ που… ἀγαθὸν ὄν). Questa specificazione è<br />
indicativa, mi pare, che qui si sta parlando ancora dell’eros come genere, dal momento che questo era<br />
stato indicato come amore/desiderio delle cose buone (205d1-2), e quindi non può riferirsi alla specie<br />
particolare di amore che acquista il nome dell’intero. In effetti si può dire semplicemente (206a3:<br />
ἁπλοῦν) che gli uomini amano il bene (206a3-4). Ma bisogna aggiungere che amano anche<br />
possederlo, e possederlo per sempre (206a6-9); in generale (206a11: συλλήβδην), allora, si può dire<br />
che eros è rivolto al bene e a possederlo per sempre. Non possiamo, mi pare, intendere queste righe<br />
come esplicative della specie particolare di eros, dal momento che si sta parlando sempre di eros come<br />
amore per le cose buone; anche stilisticamente le tre specificazioni di 205d1, τὸ κεφάλαιον, di 206a3,<br />
ἁπλοῦν, di 206a11, συλλήβδην, stanno ad indicare sempre che si tratta dell’eros come intero. Socrate<br />
concorda con tutto quanto detto da Diotima, ma a questo punto il discorso della sacerdotessa cambia<br />
registro.<br />
III.<br />
La nuova domanda che ora viene introdotta è: qual è il modo (206b1: τρόπον) e in quale attività<br />
(206b2: ἐν τίνι πράξει) si possono riconoscere lo sforzo e la tensione (206b2: σπουδὴ καὶ σύντασις)<br />
che possono essere chiamati eros? Noto che ancora non si dice esplicitamente se si tratterà di eros<br />
come intero o di quella sua specie particolare che prende il nome dell’intero. Ci troviamo di fronte,<br />
comunque, a quelle bellissime pagine finali del discorso di Diotima sulla causa e sul fine di eros che<br />
costituiscono una delle caratterizzazioni più alte dell’“amore platonico”. Non è il caso qui di<br />
esaminarle in particolare, ma solo di ripercorrerle per sommi capi, con l’intenzione di vedere se e in<br />
che modo esse ci consentano di rispondere alla domanda che ci siamo posta. La risposta alla nuova<br />
domanda è: partorire nel bello sia secondo il corpo sia secondo l’anima (206b7-8): eros infatti non è<br />
7 Gli studiosi affermano che si tratta probabilmente della citazione di un verso; in realtà, mentre è spiegabile la<br />
qualificazione di eros come una grande potenza, non è chiaro perché qui esso venga qualificato anche come δολερός, che<br />
significa ingannevole, infido, ed è un aggettivo che conosce solo una qualificazione negativa.<br />
368