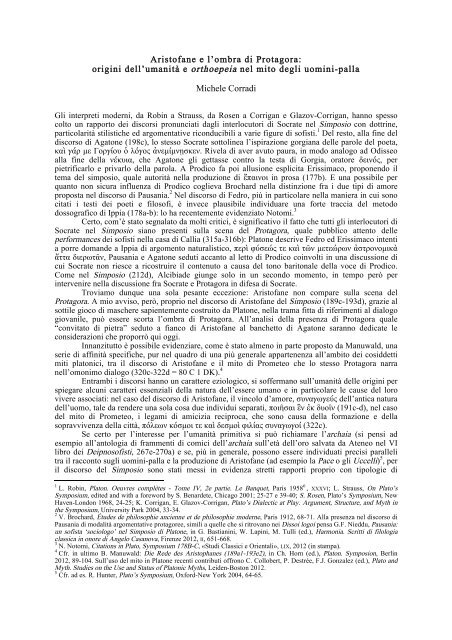Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Aristofane e l’ombra di Protagora:<br />
origini dell’umanità e orthoepeia nel mito degli uomini-palla<br />
Michele Corradi<br />
Gli interpreti moderni, da Robin a Strauss, da Rosen a Corrigan e Glazov-Corrigan, hanno spesso<br />
colto un rapporto dei discorsi pronunciati dagli interlocutori di Socrate nel Simposio con dottrine,<br />
particolarità stilistiche ed argomentative riconducibili a varie figure di sofisti. 1 Del resto, alla fine del<br />
discorso di Agatone (198c), lo stesso Socrate sottolinea l’ispirazione gorgiana delle parole del poeta,<br />
καὶ γάρ µε Γοργίου ὁ λόγος ἀνεµίµνῃσκεν. Rivela di aver avuto paura, in modo analogo ad Odisseo<br />
alla fine della νέκυια, che Agatone gli gettasse contro la testa di Gorgia, oratore δεινός, per<br />
pietrificarlo e privarlo della parola. A Prodico fa poi allusione esplicita Erissimaco, proponendo il<br />
tema del simposio, quale autorità nella produzione di ἔπαινοι in prosa (177b). E una possibile per<br />
quanto non sicura influenza di Prodico coglieva Brochard nella distinzione fra i due tipi di amore<br />
proposta nel discorso di Pausania. 2 Nel discorso di Fedro, più in particolare nella maniera in cui sono<br />
citati i testi dei poeti e filosofi, è invece plausibile individuare una forte traccia del metodo<br />
dossografico di Ippia (178a-b): lo ha recentemente evidenziato Notomi. 3<br />
Certo, com’è stato segnalato da molti critici, è significativo il fatto che tutti gli interlocutori di<br />
Socrate nel Simposio siano presenti sulla scena del Protagora, quale pubblico attento delle<br />
performances dei sofisti nella casa di Callia (315a-316b): Platone descrive Fedro ed Erissimaco intenti<br />
a porre domande a Ippia di argomento naturalistico, περὶ φύσεώς τε καὶ τῶν µετεώρων ἀστρονοµικὰ<br />
ἄττα διερωτᾶν, Pausania e Agatone seduti accanto al letto di Prodico coinvolti in una discussione di<br />
cui Socrate non riesce a ricostruire il contenuto a causa del tono baritonale della voce di Prodico.<br />
Come nel Simposio (212d), Alcibiade giunge solo in un secondo momento, in tempo però per<br />
intervenire nella discussione fra Socrate e Protagora in difesa di Socrate.<br />
Troviamo dunque una sola pesante eccezione: Aristofane non compare sulla scena del<br />
Protagora. A mio avviso, però, proprio nel discorso di Aristofane del Simposio (189c-193d), grazie al<br />
sottile gioco di maschere sapientemente costruito da Platone, nella trama fitta di riferimenti al dialogo<br />
giovanile, può essere scorta l’ombra di Protagora. All’analisi della presenza di Protagora quale<br />
“convitato di pietra” seduto a fianco di Aristofane al banchetto di Agatone saranno dedicate le<br />
considerazioni che proporrò qui oggi.<br />
Innanzitutto è possibile evidenziare, come è stato almeno in parte proposto da Manuwald, una<br />
serie di affinità specifiche, pur nel quadro di una più generale appartenenza all’ambito dei cosiddetti<br />
miti platonici, tra il discorso di Aristofane e il mito di Prometeo che lo stesso Protagora narra<br />
nell’omonimo dialogo (320c-322d = 80 C 1 DK). 4<br />
Entrambi i discorsi hanno un carattere eziologico, si soffermano sull’umanità delle origini per<br />
spiegare alcuni caratteri essenziali della natura dell’essere umano e in particolare le cause del loro<br />
vivere associati: nel caso del discorso di Aristofane, il vincolo d’amore, συναγωγεύς dell’antica natura<br />
dell’uomo, tale da rendere una sola cosa due individui separati, ποιῆσαι ἓν ἐκ δυοῖν (191c-d), nel caso<br />
del mito di Prometeo, i legami di amicizia reciproca, che sono causa della formazione e della<br />
sopravvivenza della città, πόλεων κόσµοι τε καὶ δεσµοὶ φιλίας συναγωγοί (322c).<br />
Se certo per l’interesse per l’umanità primitiva si può richiamare l’archaia (si pensi ad<br />
esempio all’antologia di frammenti di comici dell’archaia sull’età dell’oro salvata da Ateneo nel VI<br />
libro dei Deipnosofisti, 267e-270a) e se, più in generale, possono essere individuati precisi paralleli<br />
tra il racconto sugli uomini-palla e la produzione di Aristofane (ad esempio la Pace o gli Uccelli) 5 , per<br />
il discorso del Simposio sono stati messi in evidenza stretti rapporti proprio con tipologie di<br />
1 L. Robin, Platon. Oeuvres complètes - Tome IV, 2e partie. Le Banquet, Paris 1958 6 , XXXVI; L. Strauss, On Plato’s<br />
<strong>Symposium</strong>, edited and with a foreword by S. Benardete, Chicago 2001; 25-27 e 39-40; S. Rosen, Plato’s <strong>Symposium</strong>, New<br />
Haven-London 1968, 24-25; K. Corrigan, E. Glazov-Corrigan, Plato’s Dialectic at Play. Argument, Structure, and Myth in<br />
the <strong>Symposium</strong>, University Park 2004, 33-34.<br />
2 V. Brochard, Études de philosophie ancienne et de philosophie moderne, Paris 1912, 68-71. Alla presenza nel discorso di<br />
Pausania di modalità argomentative protagoree, simili a quelle che si ritrovano nei Dissoi logoi pensa G.F. Nieddu, Pausania:<br />
un sofista ‘sociologo’ nel Simposio di Platone, in G. Bastianini, W. Lapini, M. Tulli (ed.), Harmonia. Scritti di filologia<br />
classica in onore di Angelo Casanova, Firenze 2012, II, 651-668.<br />
3 N. Notomi, Citations in Plato, <strong>Symposium</strong> 178B-C, «Studi Classici e Orientali», LIX, 2012 (in stampa).<br />
4 Cfr. in ultimo B. Manuwald: Die Rede des Aristophanes (189a1-193e2), in Ch. Horn (ed.), Platon. Symposion, Berlin<br />
2012, 89-104. Sull’uso del mito in Platone recenti contributi offrono C. Collobert, P. Destrée, F.J. Gonzalez (ed.), Plato and<br />
Myth. Studies on the Use and Status of Platonic Myths, Leiden-Boston 2012.<br />
5 Cfr. ad es. R. Hunter, Plato’s <strong>Symposium</strong>, Oxford-New York 2004, 64-65.