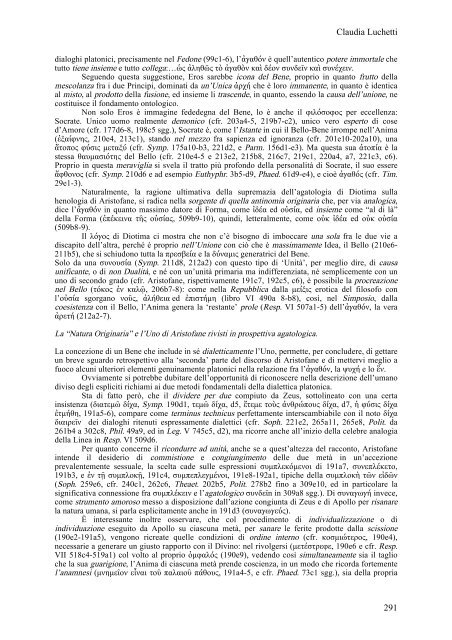Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Claudia Luchetti<br />
dialoghi platonici, precisamente nel Fedone (99c1-6), l’ἀγαθόν è quell’autentico potere immortale che<br />
tutto tiene insieme e tutto collega:…ὡς ἀληθῶς τὸ ἀγαθὸν καὶ δέον συνδεῖν καὶ συνέχειν.<br />
Seguendo questa suggestione, Eros sarebbe icona del Bene, proprio in quanto frutto della<br />
mescolanza fra i due Principi, dominati da un’Unica ἀρχή che è loro immanente, in quanto è identica<br />
al misto, al prodotto della fusione, ed insieme li trascende, in quanto, essendo la causa dell’unione, ne<br />
costituisce il fondamento ontologico.<br />
Non solo Eros è immagine fededegna del Bene, lo è anche il φιλόσοφος per eccellenza:<br />
Socrate. Unico uomo realmente demonico (cfr. 203a4-5, 219b7-c2), unico vero esperto di cose<br />
d’Amore (cfr. 177d6-8, 198c5 sgg.), Socrate è, come l’Istante in cui il Bello-Bene irrompe nell’Anima<br />
(ἐξαίφνης, 210e4, 213c1), stando nel mezzo fra sapienza ed ignoranza (cfr. 201e10-202a10), una<br />
ἄτοπος φύσις µεταξύ (cfr. Symp. 175a10-b3, 221d2, e Parm. 156d1-e3). Ma questa sua ἀτοπία è la<br />
stessa θαυµασιότης del Bello (cfr. 210e4-5 e 213e2, 215b8, 216c7, 219c1, 220a4, a7, 221c3, c6).<br />
Proprio in questa meraviglia si svela il tratto più profondo della personalità di Socrate, il suo essere<br />
ἄφθονος (cfr. Symp. 210d6 e ad esempio Euthyphr. 3b5-d9, Phaed. 61d9-e4), e cioè ἀγαθός (cfr. Tim.<br />
29e1-3).<br />
Naturalmente, la ragione ultimativa della supremazia dell’agatologia di Diotima sulla<br />
henologia di Aristofane, si radica nella sorgente di quella antinomia originaria che, per via analogica,<br />
dice l’ἀγαθόν in quanto massimo datore di Forma, come ἰδέα ed οὐσία, ed insieme come “al di là”<br />
della Forma (ἐπέκεινα τῆς οὐσίας, 509b9-10), quindi, letteralmente, come οὐκ ἰδέα ed οὐκ οὐσία<br />
(509b8-9).<br />
Il λόγος di Diotima ci mostra che non c’è bisogno di imboccare una sola fra le due vie a<br />
discapito dell’altra, perché è proprio nell’Unione con ciò che è massimamente Idea, il Bello (210e6-<br />
211b5), che si schiudono tutta la πρεσβεία e la δύναµις generatrici del Bene.<br />
Solo da una συνουσία (Symp. 211d8, 212a2) con questo tipo di ‘Unità’, per meglio dire, di causa<br />
unificante, o di non Dualità, e né con un’unità primaria ma indifferenziata, né semplicemente con un<br />
uno di secondo grado (cfr. Aristofane, rispettivamente 191c7, 192c5, c6), è possibile la procreazione<br />
nel Bello (τόκος ἐν καλῷ, 206b7-8): come nella Repubblica dalla µείξις erotica del filosofo con<br />
l’οὐσία sgorgano νοῦς, ἀλήθεια ed ἐπιστήµη (libro VI 490a 8-b8), così, nel Simposio, dalla<br />
coesistenza con il Bello, l’Anima genera la ‘restante’ prole (Resp. VI 507a1-5) dell’ἀγαθόν, la vera<br />
ἀρετή (212a2-7).<br />
La “Natura Originaria” e l’Uno di Aristofane rivisti in prospettiva agatologica.<br />
La concezione di un Bene che include in sé dialetticamente l’Uno, permette, per concludere, di gettare<br />
un breve sguardo retrospettivo alla ‘seconda’ parte del discorso di Aristofane e di mettervi meglio a<br />
fuoco alcuni ulteriori elementi genuinamente platonici nella relazione fra l’ἀγαθόν, la ψυχή e lo ἕν.<br />
Ovviamente si potrebbe dubitare dell’opportunità di riconoscere nella descrizione dell’umano<br />
diviso degli espliciti richiami ai due metodi fondamentali della dialettica platonica.<br />
Sta di fatto però, che il dividere per due compiuto da Zeus, sottolineato con una certa<br />
insistenza (διατεµῶ δίχα, Symp. 190d1, τεµῶ δίχα, d5, ἔτεµε τοὺς ἀνθρώπους δίχα, d7, ἡ φύσις δίχα<br />
ἐτµήθη, 191a5-6), compare come terminus technicus perfettamente interscambiabile con il noto δίχα<br />
διαιρεῖν dei dialoghi ritenuti espressamente dialettici (cfr. Soph. 221e2, 265a11, 265e8, Polit. da<br />
261b4 a 302c8, Phil. 49a9, ed in Leg. V 745c5, d2), ma ricorre anche all’inizio della celebre analogia<br />
della Linea in Resp. VI 509d6.<br />
Per quanto concerne il ricondurre ad unità, anche se a quest’altezza del racconto, Aristofane<br />
intende il desiderio di commistione e congiungimento delle due metà in un’accezione<br />
prevalentemente sessuale, la scelta cade sulle espressioni συµπλεκόµενοι di 191a7, συνεπλέκετο,<br />
191b3, e ἐν τῇ συµπλοκῇ, 191c4, συµπεπλεγµένοι, 191e8-192a1, tipiche della συµπλοκὴ τῶν εἰδῶν<br />
(Soph. 259e6, cfr. 240c1, 262c6, Theaet. 202b5, Polit. 278b2 fino a 309e10, ed in particolare la<br />
significativa connessione fra συµπλέκειν e l’agatologico συνδεῖn in 309a8 sgg.). Di συναγωγή invece,<br />
come strumento amoroso messo a disposizione dall’azione congiunta di Zeus e di Apollo per risanare<br />
la natura umana, si parla esplicitamente anche in 191d3 (συναγωγεύς).<br />
È interessante inoltre osservare, che col procedimento di individualizzazione o di<br />
individuazione eseguito da Apollo su ciascuna metà, per sanare le ferite prodotte dalla scissione<br />
(190e2-191a5), vengono ricreate quelle condizioni di ordine interno (cfr. κοσµιώτερος, 190e4),<br />
necessarie a generare un giusto rapporto con il Divino: nel rivolgersi (µετέστρεφε, 190e6 e cfr. Resp.<br />
VII 518c4-519a1) col volto al proprio ὀµφαλός (190e9), vedendo così simultaneamente sia il taglio<br />
che la sua guarigione, l’Anima di ciascuna metà prende coscienza, in un modo che ricorda fortemente<br />
l’anamnesi (µνηµεῖον εἶναι τοῦ παλαιοῦ πάθους, 191a4-5, e cfr. Phaed. 73c1 sgg.), sia della propria<br />
291