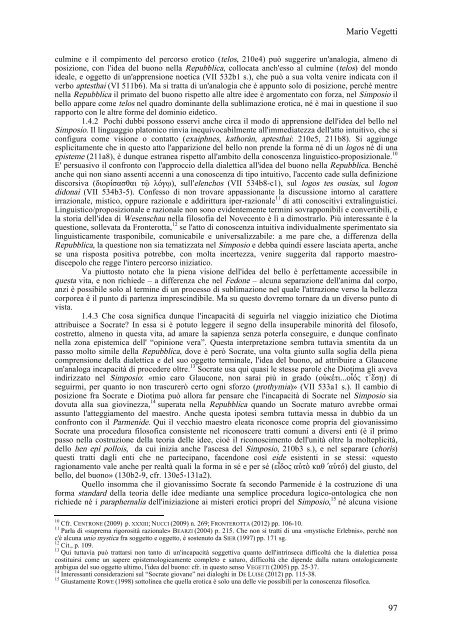You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Mario Vegetti<br />
culmine e il compimento del percorso erotico (telos, 210e4) può suggerire un'analogia, almeno di<br />
posizione, con l'idea del buono nella Repubblica, collocata anch'esso al culmine (telos) del mondo<br />
ideale, e oggetto di un'apprensione noetica (VII 532b1 s.), che può a sua volta venire indicata con il<br />
verbo aptesthai (VI 511b6). Ma si tratta di un'analogia che è appunto solo di posizione, perché mentre<br />
nella Repubblica il primato del buono rispetto alle altre idee è argomentato con forza, nel Simposio il<br />
bello appare come telos nel quadro dominante della sublimazione erotica, né è mai in questione il suo<br />
rapporto con le altre forme del dominio eidetico.<br />
1.4.2 Pochi dubbi possono esservi anche circa il modo di apprensione dell'idea del bello nel<br />
Simposio. Il linguaggio platonico rinvia inequivocabilmente all'immediatezza dell'atto intuitivo, che si<br />
configura come visione o contatto (exaiphnes, kathoràn, aptesthai: 210e5, 211b8). Si aggiunge<br />
esplicitamente che in questo atto l'apparizione del bello non prende la forma né di un logos né di una<br />
episteme (211a8), è dunque estranea rispetto all'ambito della conoscenza linguistico-proposizionale. 10<br />
E' persuasivo il confronto con l'approccio della dialettica all'idea del buono nella Repubblica. Benché<br />
anche qui non siano assenti accenni a una conoscenza di tipo intuitivo, l'accento cade sulla definizione<br />
discorsiva (διορίσασθαι τῷ λόγῳ), sull'elenchos (VII 534b8-c1), sul logos tes ousias, sul logon<br />
didonai (VII 534b3-5). Confesso di non trovare appassionante la discussione intorno al carattere<br />
irrazionale, mistico, oppure razionale e addirittura iper-razionale 11 di atti conoscitivi extralinguistici.<br />
Linguistico/proposizionale e razionale non sono evidentemente termini sovrapponibili e convertibili, e<br />
la storia dell'idea di Wesenschau nella filosofia del Novecento è lì a dimostrarlo. Più interessante è la<br />
questione, sollevata da Fronterotta, 12 se l'atto di conoscenza intuitiva individualmente sperimentato sia<br />
linguisticamente trasponibile, comunicabile e universalizzabile: a me pare che, a differenza della<br />
Repubblica, la questione non sia tematizzata nel Simposio e debba quindi essere lasciata aperta, anche<br />
se una risposta positiva potrebbe, con molta incertezza, venire suggerita dal rapporto maestrodiscepolo<br />
che regge l'intero percorso iniziatico.<br />
Va piuttosto notato che la piena visione dell'idea del bello è perfettamente accessibile in<br />
questa vita, e non richiede – a differenza che nel Fedone – alcuna separazione dell'anima dal corpo,<br />
anzi è possibile solo al termine di un processo di sublimazione nel quale l'attrazione verso la bellezza<br />
corporea è il punto di partenza imprescindibile. Ma su questo dovremo tornare da un diverso punto di<br />
vista.<br />
1.4.3 Che cosa significa dunque l'incapacità di seguirla nel viaggio iniziatico che Diotima<br />
attribuisce a Socrate? In essa si è potuto leggere il segno della insuperabile minorità del filosofo,<br />
costretto, almeno in questa vita, ad amare la sapienza senza poterla conseguire, e dunque confinato<br />
nella zona epistemica dell' “opinione vera”. Questa interpretazione sembra tuttavia smentita da un<br />
passo molto simile della Repubblica, dove è però Socrate, una volta giunto sulla soglia della piena<br />
comprensione della dialettica e del suo oggetto terminale, l'idea del buono, ad attribuire a Glaucone<br />
un'analoga incapacità di procedere oltre. 13 Socrate usa qui quasi le stesse parole che Diotima gli aveva<br />
indirizzato nel Simposio: «mio caro Glaucone, non sarai più in grado (οὐκέτι...οἶός τ´ἔσῃ) di<br />
seguirmi, per quanto io non trascurerò certo ogni sforzo (prothymia)» (VII 533a1 s.). Il cambio di<br />
posizione fra Socrate e Diotima può allora far pensare che l'incapacità di Socrate nel Simposio sia<br />
dovuta alla sua giovinezza, 14 superata nella Repubblica quando un Socrate maturo avrebbe ormai<br />
assunto l'atteggiamento del maestro. Anche questa ipotesi sembra tuttavia messa in dubbio da un<br />
confronto con il Parmenide. Qui il vecchio maestro eleata riconosce come propria del giovanissimo<br />
Socrate una procedura filosofica consistente nel riconoscere tratti comuni a diversi enti (è il primo<br />
passo nella costruzione della teoria delle idee, cioè il riconoscimento dell'unità oltre la molteplicità,<br />
dello hen epì pollois, da cui inizia anche l'ascesa del Simposio, 210b3 s.), e nel separare (chorìs)<br />
questi tratti dagli enti che ne partecipano, facendone così eide esistenti in se stessi: «questo<br />
ragionamento vale anche per realtà quali la forma in sé e per sé (εἶδος αὐτὸ καθ ´αὑτό) del giusto, del<br />
bello, del buono» (130b2-9, cfr. 130e5-131a2).<br />
Quello insomma che il giovanissimo Socrate fa secondo Parmenide è la costruzione di una<br />
forma standard della teoria delle idee mediante una semplice procedura logico-ontologica che non<br />
richiede né i paraphernalia dell'iniziazione ai misteri erotici propri del Simposio, 15 né alcuna visione<br />
10 Cfr. CENTRONE (2009) p. XXXIII; NUCCI (2009) n. 269; FRONTEROTTA (2012) pp. 106-10.<br />
11 Parla di «suprema rigorosità razionale» BEARZI (2004) p. 215. Che non si tratti di una «mystische Erlebnis», perché non<br />
c'è alcuna unio mystica fra soggetto e oggetto, è sostenuto da SIER (1997) pp. 171 sg.<br />
12 Cit., p. 109.<br />
13 Qui tuttavia può trattarsi non tanto di un'incapacità soggettiva quanto dell'intrinseca difficoltà che la dialettica possa<br />
costituirsi come un sapere epistemologicamente completo e saturo, difficoltà che dipende dalla natura ontologicamente<br />
ambigua del suo oggetto ultimo, l'idea del buono: cfr. in questo senso VEGETTI (2005) pp. 25-37.<br />
14 Interessanti considerazioni sul “Socrate giovane” nei dialoghi in DE LUISE (2012) pp. 115-38.<br />
15 Giustamente ROWE (1998) sottolinea che quella erotica è solo una delle vie possibili per la conoscenza filosofica.<br />
97