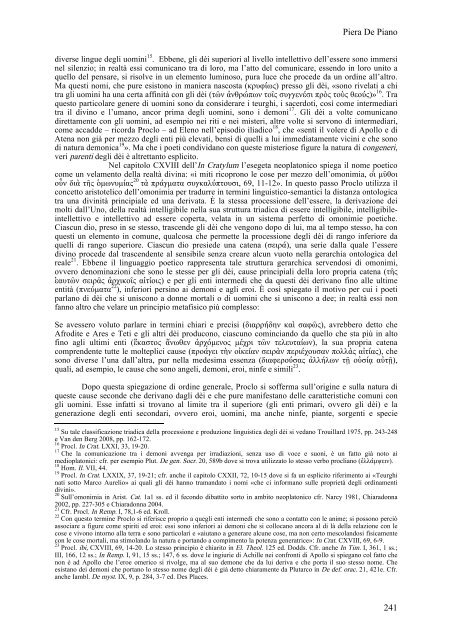Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Piera De Piano<br />
diverse lingue degli uomini 15 . Ebbene, gli dèi superiori al livello intellettivo dell’essere sono immersi<br />
nel silenzio; in realtà essi comunicano tra di loro, ma l’atto del comunicare, essendo in loro unito a<br />
quello del pensare, si risolve in un elemento luminoso, pura luce che procede da un ordine all’altro.<br />
Ma questi nomi, che pure esistono in maniera nascosta (κρυφίως) presso gli dèi, «sono rivelati a chi<br />
tra gli uomini ha una certa affinità con gli dèi (τῶν ἀνθρώπων τοῖς συγγενέσι πρὸς τοὺς θεούς)» 16 . Τra<br />
questo particolare genere di uomini sono da considerare i teurghi, i sacerdoti, così come intermediari<br />
tra il divino e l’umano, ancor prima degli uomini, sono i demoni 17 . Gli dèi a volte comunicano<br />
direttamente con gli uomini, ad esempio nei riti e nei misteri, altre volte si servono di intermediari,<br />
come accadde – ricorda Proclo – ad Eleno nell’episodio iliadico 18 , che «sentì il volere di Apollo e di<br />
Atena non già per mezzo degli enti più elevati, bensì di quelli a lui immediatamente vicini e che sono<br />
di natura demonica 19 ». Ma che i poeti condividano con queste misteriose figure la natura di congeneri,<br />
veri parenti degli dèi è altrettanto esplicito.<br />
Nel capitolo CXVIII dell’In Cratylum l’esegeta neoplatonico spiega il nome poetico<br />
come un velamento della realtà divina: «i miti ricoprono le cose per mezzo dell’omonimia, οἱ µῦθοι<br />
οὖν διὰ τῆς ὁµωνυµίας 20 τὰ πράγµατα συγκαλύπτουσι, 69, 11-12». In questo passo Proclo utilizza il<br />
concetto aristotelico dell’omonimia per tradurre in termini linguistico-semantici la distanza ontologica<br />
tra una divinità principiale ed una derivata. È la stessa processione dell’essere, la derivazione dei<br />
molti dall’Uno, della realtà intelligibile nella sua struttura triadica di essere intelligibile, intelligibileintellettivo<br />
e intellettivo ad essere coperta, velata in un sistema perfetto di omonimie poetiche.<br />
Ciascun dio, preso in se stesso, trascende gli dèi che vengono dopo di lui, ma al tempo stesso, ha con<br />
questi un elemento in comune, qualcosa che permette la processione degli dèi di rango inferiore da<br />
quelli di rango superiore. Ciascun dio presiede una catena (σειρά), una serie dalla quale l’essere<br />
divino procede dal trascendente al sensibile senza creare alcun vuoto nella gerarchia ontologica del<br />
reale 21 . Ebbene il linguaggio poetico rappresenta tale struttura gerarchica servendosi di omonimi,<br />
ovvero denominazioni che sono le stesse per gli dèi, cause principiali della loro propria catena (τῆς<br />
ἑαυτῶν σειρᾶς ἀρχικοῖς αἰτίοις) e per gli enti intermedi che da questi dèi derivano fino alle ultime<br />
entità (πνεύµατα 22 ), inferiori persino ai demoni e agli eroi. È così spiegato il motivo per cui i poeti<br />
parlano di dèi che si uniscono a donne mortali o di uomini che si uniscono a dee; in realtà essi non<br />
fanno altro che velare un principio metafisico più complesso:<br />
Se avessero voluto parlare in termini chiari e precisi (διαρρήδην καὶ σαφῶς), avrebbero detto che<br />
Afrodite e Ares e Teti e gli altri dèi producono, ciascuno cominciando da quello che sta più in alto<br />
fino agli ultimi enti (ἕκαστος ἄνωθεν ἀρχόµενος µέχρι τῶν τελευταίων), la sua propria catena<br />
comprendente tutte le molteplici cause (προάγει τὴν οἰκείαν σειρὰν περιέχουσαν πολλὰς αἰτίας), che<br />
sono diverse l’una dall’altra, pur nella medesima essenza (διαφερούσας ἀλλήλων τῇ οὐσίᾳ αὐτῇ),<br />
quali, ad esempio, le cause che sono angeli, demoni, eroi, ninfe e simili 23 .<br />
Dopo questa spiegazione di ordine generale, Proclo si sofferma sull’origine e sulla natura di<br />
queste cause seconde che derivano dagli dèi e che pure manifestano delle caratteristiche comuni con<br />
gli uomini. Esse infatti si trovano al limite tra il superiore (gli enti primari, ovvero gli dèi) e la<br />
generazione degli enti secondari, ovvero eroi, uomini, ma anche ninfe, piante, sorgenti e specie<br />
15 Su tale classificazione triadica della processione e produzione linguistica degli dèi si vedano Trouillard 1975, pp. 243-248<br />
e Van den Berg 2008, pp. 162-172.<br />
16 Procl. In Crat. LXXI, 33, 19-20.<br />
17 Che la comunicazione tra i demoni avvenga per irradiazioni, senza uso di voce e suoni, è un fatto già noto ai<br />
medioplatonici: cfr. per esempio Plut. De gen. Socr. 20, 589b dove si trova utilizzato lo stesso verbo procliano (ἐλλάµψειν).<br />
18 Hom. Il. VII, 44.<br />
19 Procl. In Crat. LXXIX, 37, 19-21; cfr. anche il capitolo CXXII, 72, 10-15 dove si fa un esplicito riferimento ai «Teurghi<br />
nati sotto Marco Aurelio» ai quali gli dèi hanno tramandato i nomi «che ci informano sulle proprietà degli ordinamenti<br />
divini».<br />
20 Sull’omonimia in Arist. Cat. 1a1 ss. ed il fecondo dibattito sorto in ambito neoplatonico cfr. Narcy 1981, Chiaradonna<br />
2002, pp. 227-305 e Chiaradonna 2004.<br />
21 Cfr. Procl. In Remp. I, 78,1-6 ed. Kroll.<br />
22 Con questo termine Proclo si riferisce proprio a quegli enti intermedi che sono a contatto con le anime; si possono perciò<br />
associare a figure come spiriti ed eroi: essi sono inferiori ai demoni che si collocano ancora al di là della relazione con le<br />
cose e vivono intorno alla terra e sono particolari e «aiutano a generare alcune cose, ma non certo mescolandosi fisicamente<br />
con le cose mortali, ma stimolando la natura e portando a compimento la potenza generatrice»: In Crat. CXVIII, 69, 6-9.<br />
23 Procl. ibi, CXVIII, 69, 14-20. Lo stesso principio è chiarito in El. Theol. 125 ed. Dodds. Cfr. anche In Tim. I, 361, 1 ss.;<br />
III, 166, 12 ss.; In Remp. I, 91, 15 ss.; 147, 6 ss. dove le ingiurie di Achille nei confronti di Apollo si spiegano col fatto che<br />
non è ad Apollo che l’eroe omerico si rivolge, ma al suo demone che da lui deriva e che porta il suo stesso nome. Che<br />
esistano dei demoni che portano lo stesso nome degli dèi è già detto chiaramente da Plutarco in De def. orac. 21, 421e. Cfr.<br />
anche Iambl. De myst. IX, 9, p. 284, 3-7 ed. Des Places.<br />
241