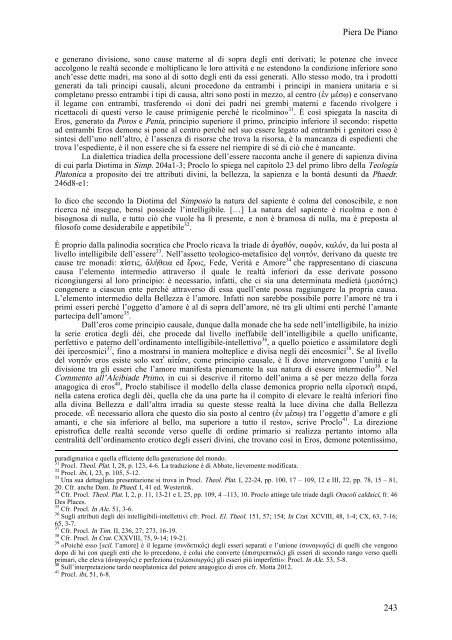You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Piera De Piano<br />
e generano divisione, sono cause materne al di sopra degli enti derivati; le potenze che invece<br />
accolgono le realtà seconde e moltiplicano le loro attività e ne estendono la condizione inferiore sono<br />
anch’esse dette madri, ma sono al di sotto degli enti da essi generati. Allo stesso modo, tra i prodotti<br />
generati da tali principi causali, alcuni procedono da entrambi i principi in maniera unitaria e si<br />
completano presso entrambi i tipi di causa, altri sono posti in mezzo, al centro (ἐν µέσῳ) e conservano<br />
il legame con entrambi, trasferendo «i doni dei padri nei grembi materni e facendo rivolgere i<br />
ricettacoli di questi verso le cause primigenie perché le ricolmino» 31 . È così spiegata la nascita di<br />
Eros, generato da Poros e Penia, principio superiore il primo, principio inferiore il secondo: rispetto<br />
ad entrambi Eros demone si pone al centro perché nel suo essere legato ad entrambi i genitori esso è<br />
sintesi dell’uno nell’altro, è l’assenza di risorse che trova la risorsa, è la mancanza di espedienti che<br />
trova l’espediente, è il non essere che si fa essere nel riempire di sé di ciò che è mancante.<br />
La dialettica triadica della processione dell’essere racconta anche il genere di sapienza divina<br />
di cui parla Diotima in Simp. 204a1-3; Proclo lo spiega nel capitolo 23 del primo libro della Teologia<br />
Platonica a proposito dei tre attributi divini, la bellezza, la sapienza e la bontà desunti da Phaedr.<br />
246d8-e1:<br />
Io dico che secondo la Diotima del Simposio la natura del sapiente è colma del conoscibile, e non<br />
ricerca né insegue, bensì possiede l’intelligibile. […] La natura del sapiente è ricolma e non è<br />
bisognosa di nulla, e tutto ciò che vuole ha lì presente, e non è bramosa di nulla, ma è preposta al<br />
filosofo come desiderabile e appetibile 32 .<br />
È proprio dalla palinodia socratica che Proclo ricava la triade di ἀγαθόν, σοφὀν, καλόν, da lui posta al<br />
livello intelligibile dell’essere 33 . Nell’assetto teologico-metafisico del νοητόν, derivano da queste tre<br />
cause tre monadi: πίστις, ἀλήθεια ed ἔρως, Fede, Verità e Amore 34 che rappresentano di ciascuna<br />
causa l’elemento intermedio attraverso il quale le realtà inferiori da esse derivate possono<br />
ricongiungersi al loro principio: è necessario, infatti, che ci sia una determinata medietà (µεσότης)<br />
congenere a ciascun ente perché attraverso di essa quell’ente possa raggiungere la propria causa.<br />
L’elemento intermedio della Bellezza è l’amore. Infatti non sarebbe possibile porre l’amore né tra i<br />
primi esseri perché l’oggetto d’amore è al di sopra dell’amore, né tra gli ultimi enti perché l’amante<br />
partecipa dell’amore 35 .<br />
Dall’eros come principio causale, dunque dalla monade che ha sede nell’intelligibile, ha inizio<br />
la serie erotica degli dèi, che procede dal livello ineffabile dell’intelligibile a quello unificante,<br />
perfettivo e paterno dell’ordinamento intelligibile-intellettivo 36 , a quello poietico e assimilatore degli<br />
dèi ipercosmici 37 , fino a mostrarsi in maniera molteplice e divisa negli dèi encosmici 38 . Se al livello<br />
del νοητόν eros esiste solo κατ᾽ αἰτίαν, come principio causale, è lì dove intervengono l’unità e la<br />
divisione tra gli esseri che l’amore manifesta pienamente la sua natura di essere intermedio 39 . Nel<br />
Commento all’Alcibiade Primo, in cui si descrive il ritorno dell’anima a sé per mezzo della forza<br />
anagogica di eros 40 , Proclo stabilisce il modello della classe demonica proprio nella εἰροτικὴ σειρά,<br />
nella catena erotica degli dèi, quella che da una parte ha il compito di elevare le realtà inferiori fino<br />
alla divina Bellezza e dall’altra irradia su queste stesse realtà la luce divina che dalla Bellezza<br />
procede. «È necessario allora che questo dio sia posto al centro (ἐν µέσῳ) tra l’oggetto d’amore e gli<br />
amanti, e che sia inferiore al bello, ma superiore a tutto il resto», scrive Proclo 41 . La direzione<br />
epistrofica delle realtà seconde verso quelle di ordine primario si realizza pertanto intorno alla<br />
centralità dell’ordinamento erotico degli esseri divini, che trovano così in Eros, demone potentissimo,<br />
paradigmatica e quella efficiente della generazione del mondo.<br />
31 Procl. Theol. Plat. I, 28, p. 123, 4-6. La traduzione è di Abbate, lievemente modificata.<br />
32 Procl. ibi, I, 23, p. 105, 5-12.<br />
33 Una sua dettagliata presentazione si trova in Procl. Theol. Plat. I, 22-24, pp. 100, 17 – 109, 12 e III, 22, pp. 78, 15 – 81,<br />
20. Cfr. anche Dam. In Phaed. I, 41 ed. Westerink.<br />
34 Cfr. Procl. Theol. Plat. I, 2, p. 11, 13-21 e I, 25, pp. 109, 4 –113, 10. Proclo attinge tale triade dagli Oracoli caldaici, fr. 46<br />
Des Places.<br />
35 Cfr. Procl. In Alc. 51, 3-6.<br />
36 Sugli attributi degli dèi intelligibili-intellettivi cfr. Procl. El. Theol. 151, 57; 154; In Crat. XCVIII, 48, 1-4; CX, 63, 7-16;<br />
65, 3-7.<br />
37 Cfr. Procl. In Tim. II, 236, 27; 273, 16-19.<br />
38 Cfr. Procl. In Crat. CXXVIII, 75, 9-14; 19-21.<br />
39 «Poiché esso [scil. l’amore] è il legame (συνδετικός) degli esseri separati e l’unione (συναγωγός) di quelli che vengono<br />
dopo di lui con quegli enti che lo precedono, è colui che converte (ἐπιστρεπτικός) gli esseri di secondo rango verso quelli<br />
primari, che eleva (ἀναγωγός) e perfeziona (τελεσιουργός) gli esseri più imperfetti»: Procl. In Alc. 53, 5-8.<br />
40 Sull’interpretazione tardo neoplatonica del potere anagogico di eros cfr. Motta 2012.<br />
41 Procl. ibi, 51, 6-8.<br />
243