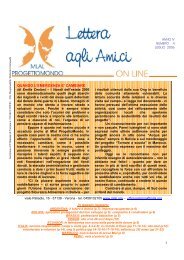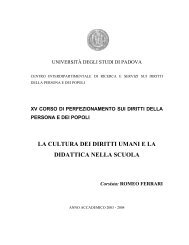cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"
cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"
cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
tegrazione fra gli stessi cittadini dell’Unione e quindi dell’autoconsapevolezza della <strong>cittadinanza</strong><br />
europea, era costituita dalla decisa promozione di cooperazioni transfrontaliere e interregionali, sul<br />
tipo, per esempio, della Comunità di lavoro “Alpe-Adria”, sorta dalla comunanza storico-geografica<br />
delle regioni o degli Stati estesi alle Alpi Orientali.<br />
Nel quadro generale così delineato, il PE sosteneva inoltre che, a maggior ragione, “l’Unione deve<br />
rafforzare le sue politiche esistenti”, sottolineando a tal proposito i seguenti campi d’intervento: la<br />
coesione economica e sociale; la politica sociale (con l’inserimento della Carta Sociale e una fine<br />
della deroga del Regno Unito 193 ); la politica delle pari opportunità; un quadro comune di politica<br />
energetica (comprensivo degli aspetti presenti nella CECA e nell’EURATOM); la politica agricola;<br />
una distinta politica della pesca; la politica ambientale; la politica per il consumatore; la politica dei<br />
trasporti; la politica del turismo; il diritto per ogni cittadino dell’UE al pari accesso ai servizi<br />
d’interesse generale (servizio pubblico); i <strong>diritti</strong> e gli interessi dei bambini e dei giovani; una politica<br />
economica esterna di competenza esclusiva dell’Unione. Inoltre veniva raccomandato l’uso di un<br />
numero illimitato di lingue ufficiali o di lavoro dell’UE. E infine si introduceva un’ulteriore novità<br />
con la seguente affermazione:<br />
“In vista della natura multiculturale della società europea, sarà fatto esplicito riferimento alla necessità di promuovere<br />
un dialogo interculturale teso a migliorare la reciproca comprensione e tolleranza.”<br />
Nella consapevolezza delle conseguenze dell’immigrazione di massa nell’UE, il PE apriva con ciò<br />
un nuovo “fronte” nella strategia dell’integrazione, destinato ad assumere ben altro rilievo dodici<br />
anni dopo.<br />
Infine, per quanto riguarda la “chiarificazione delle competenze”, il PE, nel confermare i principi di<br />
sussidiarietà e di proporzionalità, sosteneva: “La creazione di una lista fissa di competenze dell’UE<br />
e degli Stati membri sarebbe troppo rigida e troppo gravosa da stabilire”, alludendo al carattere dinamico<br />
della sussidiarietà ovvero al fatto che essa avrebbe dovuto entrare, di volta in volta, in azione<br />
per quei settori in cui i singoli Stati membri non fossero riusciti a realizzare adeguate politiche a<br />
livello nazionale.<br />
Per quanto riguarda il secondo punto ovvero “le istituzioni dell’Unione”, il PE poneva coerentemente<br />
al primo posto la necessità di “assicurare l’unità del sistema istituzionale”, proponendo in<br />
merito due punti fondamentali: 1) l’unificazione dei trattati esistenti (con la duplice riduzione degli<br />
elementi essenziali dei trattati CECA ed EURATOM entro il trattato unificato e della PESC e della<br />
CSGAI “entro il sistema comunitario”) e 2) l’attribuzione all’UE della “personalità legale” (giuridica).<br />
In tal modo il PE conservava un altro caposaldo del suo precedente “Progetto di Costituzione<br />
dell’UE” ossia il carattere omogeneo e unitario dell’Unione e la sua trasformazione in un vero e<br />
proprio soggetto politico-istituzionale, pur non parlando minimamente di Costituzione e lasciando<br />
formalmente esistere i diversi trattati costitutivi europei (CECA, CEEA, CE e TUE).<br />
L’autentica preoccupazione crescente del PE era rappresentata piuttosto dalla prospettiva<br />
dell’allargamento dell’UE ovvero dal timore che l’entrata simultanea di un considerevole numero di<br />
Stati membri, provenienti da realtà storiche profondamente diverse da quella comunitaria, avrebbe<br />
indotto alla tentazione di lasciarsi andare a “ulteriori accordi flessibili” e quindi in definitiva a<br />
un’inammissibile ”Europa à la carte” ossia a un’estensione indiscriminata ai futuri Stati membri del<br />
regime delle “deroghe” già concesse o che sarebbero state concesse ai tre Paesi entrati nella Comunità<br />
nel 1973 ossia Regno Unito, Irlanda e Danimarca. 194 Anzi, sempre al fine di garantire una so-<br />
193 In tal modo il PE intendeva porre fine alla situazione anomala, se non paradossale, di un’Unione costretta a condurre<br />
la propria politica sociale (fondata sulla Carta sociale) nei termini di una semplice “cooperazione rafforzata”, in quanto<br />
un unico Stato membro ossia il Regno Unito rifiutava la Carta sociale. L’inserimento di quest’ultima nel trattato avrebbe<br />
invece comportato la natura vincolante di essa, e quindi della politica sociale comune che ne discendeva, per tutti gli<br />
Stati membri, presenti e futuri, dell’UE e perciò l’inammissibilità della concessione di “deroghe” illimitate, su questo<br />
punto cruciale, a qualunque Stato membro, compreso il Regno Unito.<br />
194 A dodici anni di distanza, tale preoccupazione evidenzia la sua sostanziale attualità, in presenza di atteggiamenti che<br />
vanno in tale direzione da parte di nuovi Stati membri, come la Polonia e la Repubblica Ceca.