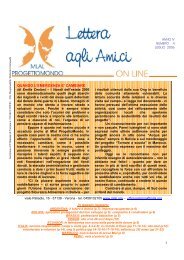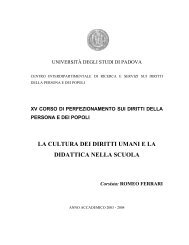cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"
cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"
cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
striale ed economico di entrambi i Paesi e insieme rendere impossibile che la produzione, proprio in<br />
quanto fondata su basi comuni, si orientasse ancora alla “fabbricazione di strumenti bellici”; il risultato<br />
sarebbe stato che “la solidarietà di produzione in tal modo realizzata farà sì che una qualsiasi<br />
guerra tra la Francia e la Germania diventi non solo impensabile, ma materialmente impossibile”. In<br />
questa maniera sarebbero stati di colpo fugati i dubbi non solo francesi, bensì di tutte le Nazioni Unite<br />
su qualsiasi possibilità di riarmo della Germania, consentendo a quest’ultima di accelerare il<br />
proprio sviluppo economico e insieme aprendo le porte a una progressiva riabilitazione internazionale<br />
dello Stato tedesco.<br />
A questo proposito è anzi da sottolineare come la proposta francese, che intendeva collocarsi soprattutto<br />
nell’alveo del quadro di riferimento generale europeo, proprio del Consiglio d’Europa,<br />
contribuisse all’accoglimento da parte di quest’ultimo già pochi mesi dopo, il 13 luglio 1950, della<br />
Germania occidentale come suo nuovo membro, anche se solo associato.<br />
La proposta di Schuman si segnalava inoltre per l’apertura ad eventuali adesioni alla futura “organizzazione”<br />
anche da parte di altri Paesi europei, nonché perché precisava che “questa produzione<br />
sarà offerta al mondo intero, senza distinzione né esclusione, per contribuire al rialzo del livello di<br />
vita e al progresso delle opere di pace”. In tal modo Schuman faceva capire che l’eventuale accordo<br />
franco-tedesco era davvero da intendere come un possibile primo nucleo di un accordo estendibile<br />
idealmente a tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa e che tale unione sarebbe stata comunque<br />
non già contro qualche Stato terzo, bensì a beneficio del mondo intero.<br />
La Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA)<br />
La persuasività della proposta francese venne subito confermata dall’adesione a essa non solo della<br />
Repubblica di Federale di Germania, ma anche del Belgio, dei Paesi Bassi e del Lussemburgo, nonché<br />
dell’Italia 49 ; inoltre essa ricevette il “nulla osta” degli altri quattro membri permanenti del Consiglio<br />
di sicurezza delle Nazioni Unite. Si pervenne così, il 18 aprile 1951, alla firma tra i sei Stati<br />
predetti del Trattato di Parigi istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio<br />
(CECA).<br />
I rappresentanti dei sei Stati membri (tra cui il tedesco Konrad Adenauer) riprendevano nel Preambolo<br />
del trattato i contenuti essenziali della Dichiarazione Schuman e in particolare il fine ultimo di<br />
essa: “Risoluti a sostituire alle rivalità secolari una fusione dei loro interessi nazionali essenziali, a<br />
fondare con l’instaurazione d’una comunità economica le prime assise d’una comunità più vasta e<br />
profonda tra popoli per lungo tempo avversi per divisioni sanguinose, e a porre i fondamenti<br />
d’istituzioni capaci d’indirizzare un destino oramai condiviso,”. In altri termini si confermava che la<br />
49 Dopo la caduta del governo Mussolini e la fine del regime fascista (25 luglio 1943), l’armistizio con resa incondizionata<br />
agli Alleati (3 settembre 1943), l’entrata in guerra contro la Germania nazista (13 ottobre 1943), la resa incondizionata<br />
delle truppe tedesche in Italia (29 aprile 1945), il referendum istituzionale e le elezioni dell’Assemblea Costituente<br />
(2 giugno 1946) con la nascita della Repubblica Italiana, il trattato di pace con le Nazioni Unite (10 febbraio 1947) e<br />
l’entrata in vigore della Costituzione (1 gennaio 1948), l’Italia aveva aderito, come membro fondatore, sia all’OECE,<br />
sia alla NATO, sia al Consiglio d’Europa, ma non aveva ancora ottenuto, a motivo della propria condizione di potenza<br />
sconfitta, un consenso universale ad una sua entrata nell’ONU. Tale perdurante situazione di parziale inferiorità politica,<br />
unitamente alle persistenti scarse prospettive di sviluppo economico, favorirono la decisione di diventare membro<br />
fondatore di un risolutivo processo d’integrazione europea.<br />
Artefice di tale decisione fu peraltro Alcide De Gasperi. Cofondatore dell’Unione Politica Popolare del Trentino<br />
(UPPT) (1904) e del Partito Popolare Trentino (PPT) (1905), consigliere comunale di Trento (1909-’14), membro del<br />
Consiglio Imperiale della Cisleitania ossia della parte austriaca dell’Impero d’Austria-Ungheria (1911-’18), membro<br />
della Dieta del Tirolo (1914-’15), cofondatore del Partito Popolare Italiano (PPI) (1919), membro della Camera dei deputati<br />
del Regno d’Italia (1919-‘26), segretario del PPI (1924-’25), segregato per antifascimo (1927-’28), rifugiato nello<br />
Stato della Città del Vaticano (1929-’44), fondatore della Democrazia Cristiana (1942), cofondatore del Comitato Nazionale<br />
delle Opposizioni (CNO) e quindi del Comitato di Liberazione Nazionale (CLN) (1943), ministro (1944), segretario<br />
della DC (1944-’46), ministro degli esteri (1944-’46), Alcide De Gasperi era dal 1945 il presidente del Consiglio<br />
dei ministri del Regno d’Italia e poi della Repubblica Italiana. Per la sua scelta decisiva a favore della partecipazione<br />
dell’Italia alla CECA, gli sarà assegnato nel 1952 il “Premio Carlo Magno”, istituito ad Aquisgrana nel 1949 quale riconoscimento<br />
per le personalità maggiormente distintesi a favore dell’unificazione europea.