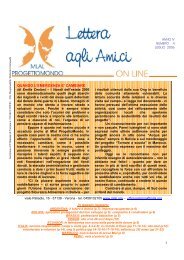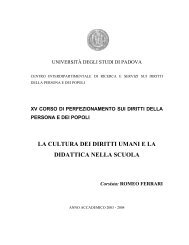cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"
cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"
cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
A. Lo sfondo storico<br />
La dichiarazione evocava in primo luogo lo sfondo storico da cui muoveva. Si ravvisava nel “contrasto<br />
secolare tra la Francia e la Germania” (risalente alla guerra franco-prussiana del 1870-’71) la<br />
causa principale della prima guerra mondiale (1914-’18), che a sua volta comportò, nei successivi<br />
trattati di pace (a partire dal 1919), sia l’affermazione dello Stato come Stato nazionale, sia la creazione<br />
della Società delle Nazioni (SdN), in cui entrò subito la Francia. Ne derivò per l’Europa la<br />
moltiplicazione del numero degli Stati, ognuno dei quali, nel difficile periodo del dopoguerra, tese a<br />
costruirsi un’economia nazionale chiusa, producendo una situazione economica generale<br />
dell’Europa sempre più frammentata e incapace di apportare nuovo sviluppo per qualunque Stato. Il<br />
mancato sviluppo economico poneva serie ipoteche anche alla situazione politica, perché dava ulteriore<br />
esca al nazionalismo ormai emergente dovunque e quindi al rischio di nuove guerre, in particolare<br />
tra la Germania e la Francia. D’altra parte la Società delle Nazioni, che aveva come suo<br />
compito primario quello di mantenere la pace mondiale, favorì il raggiungimento di alcuni accordi<br />
fondamentali, che sembrarono scongiurare proprio quel rischio, ovvero il Patto di Locarno (1925),<br />
con l’entrata della Germania nella SdN (1926), e il Patto Briand-Kellogg (1928). Protagonista di<br />
entrambi gli accordi fu il ministro degli esteri francese Aristide Briand. Egli riteneva tuttavia che il<br />
problema franco-tedesco potesse considerarsi effettivamente concluso solo in quanto si fosse provveduto<br />
a un accordo generale e stabile per tutta l’Europa, che fosse capace di garantire il superamento<br />
delle barriere economiche nazionali e quindi dello sviluppo dei nazionalismi e del rischio<br />
della guerra, attraverso la creazione di un’unione economica europea, da realizzarsi peraltro grazie<br />
all’istituzione di un’”Associazione Europea” a carattere politico tra gli Stati europei aderenti alla<br />
SdN, nella forma dunque di un’organizzazione regionale di quest’ultima. Il suo appello, lanciato a<br />
Ginevra il 5 settembre 1929 nella seduta plenaria dell’Assemblea della SdN, fu raccolto pochi giorni<br />
dopo, il 9 settembre, fra gli altri, dal ministro degli esteri tedesco Gustav Stresemann; l’adesione<br />
generale permise la redazione francese di un “memorandum sull’organizzazione di un regime<br />
d’Unione Federale Europea”, che fu presentato ai 27 Stati europei membri della SdN il 17 maggio<br />
1930 e che prevedeva la creazione di due organismi, uno generale, la “Conferenza europea”, e uno<br />
ristretto, il “Comitato politico permanente”. Nonostante l’adesione generale al memorandum 47 e la<br />
conseguente risoluzione dell’Assemblea della Società delle Nazioni del 17 settembre 1930, con la<br />
quale si decideva, in vista della creazione di un’Unione Federale Europea, l’istituzione di<br />
un’apposita “Commissione d’indagine per l’Unione Europea”, presieduta da Briand, quest’ultima<br />
non riuscì a condurre a termine il proprio compito, in pratica non sopravvivendo allo stesso Briand,<br />
spentosi il 7 marzo 1932.<br />
Infatti in primo luogo l’obiettivo era troppo ambizioso e insieme troppo vago e questa sarà la prima<br />
lezione appresa da Monnet e quindi da Schuman: “L’Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà<br />
costruita tutta insieme; essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto”, e non già alla<br />
fine (come per Briand), “una solidarietà di fatto”. In secondo luogo l’idea giungeva troppo tardi:<br />
appena poche settimane dopo il primo annuncio di Briand, esplodeva la grande crisi economica<br />
mondiale (crollo della borsa di Wall Street, dal 24 ottobre 1929), che di lì a qualche mese investiva<br />
la stessa Europa (rafforzando la tendenza dei singoli Stati al protezionismo doganale e lo sviluppo<br />
del nazionalismo), ma in particolare la Germania, dove il nazionalismo assumeva l’aspetto, sempre<br />
più di successo, di una proposta autoritaria, dittatoriale, totalitaria, fascista, come quella del partito<br />
nazionalsocialista, che, una volta giunto al potere, non esiterà a denunciare i trattati internazionali,<br />
sfidando apertamente la SdN, la quale era del resto già in crisi fin dal 1931 in seguito al fallimento<br />
del tentativo di contenimento della volontà espansionistica del Giappone in Manciuria ai danni della<br />
47 Per il “memorandum”, la serie delle osservazioni a esso da parte di ognuno dei 27 Stati e la sintesi finale francese di<br />
esse vedi (in lingua inglese) il documento SdN 15/9/1930 Documents relating to the Organisation of a system of European<br />
Federal Union, in: http://digital.library.northwestern.edu/league/le00328a.pdf e<br />
http://digital.library.northwestern.edu/league/le00328b.pdf .