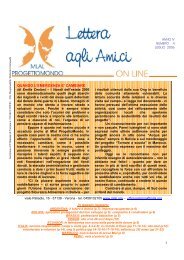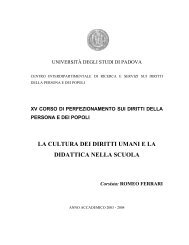cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"
cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"
cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
sa “architettura” di questi ultimi, di una loro codificazione, di una loro fusione (limitata ai due trattati<br />
CE e UE) e anzi di una distinzione fra un trattato di base o fondamentale e le altre disposizioni<br />
dei trattati. Il rapporto si concentrava quindi sulla struttura e sul contenuto del trattato fondamentale.<br />
E finalmente prendeva posizione in merito al problema dell’articolazione del trattato fondamentale<br />
con gli attuali trattati. A questo proposito esso sembrava assumere la scelta di presentare il trattato<br />
fondamentale nell’effettivo contesto di un riordino o di una semplificazione degli attuali trattati. In<br />
particolare sottolineava che il trattato fondamentale avrebbe dovuto sostituire il trattato UE anche<br />
nello stesso ruolo di trattato quadro o di “cappello” a tutte le più diverse politiche dell’Unione, incorporando<br />
le disposizioni essenziali sia del trattato UE, sia del trattato CE. Nell’eventuale permanenza<br />
della struttura a pilastri le disposizioni riguardanti il secondo e il terzo pilastro sarebbero state<br />
rifuse rispettivamente in due protocolli annessi allo stesso trattato fondamentale. Per quanto riguarda<br />
invece il trattato CE, si sarebbe dovuto conferire autenticazione e quindi validità giuridica alla<br />
versione consolidata di esso ossia codificarla, in una versione da cui sarebbero sparite le disposizioni<br />
essenziali trasferite nel trattato fondamentale. Il rapporto a questo punto precisava: “Indubbiamente<br />
è importante, anche solo per motivi simbolici, non abrogare il trattato di Roma.” E concludeva<br />
confermando che una piena ristrutturazione del diritto primario sarebbe stata più giustificata e<br />
più facilmente ottenuta “nel contesto di una fondamentale riforma sostanziale che in un progetto di<br />
consolidamento, che è obbligato al mantenimento della presente situazione giuridica.” In definitiva<br />
il rapporto era sostanzialmente fedele alla proposta del Comitato dei tre saggi di mantenere due testi<br />
distinti o separati per le disposizioni fondamentali e per quelle non fondamentali e lo faceva, prevedendo<br />
per le une un trattato fondamentale e per le altre da un lato due protocolli a quest’ultimo (sulla<br />
PESC e sulla CGMP) e dall’altro soprattutto un distinto e separato trattato CE (concepito come<br />
contenitore di tutte le disposizioni comunitarie non fondamentali).<br />
Pochi mesi dopo il gruppo di ricerca dell’IUE di Firenze consegnava alla Commissione, il 31 luglio<br />
2000, il secondo rapporto sulla riorganizzazione dei trattati dell’UE, dedicato al tema “Riformare le<br />
procedure di revisione dei trattati”. Dopo un’attenta considerazione delle varie tipologie di procedura<br />
di revisione esistenti sia nelle organizzazioni internazionali, sia negli Stati federali, sia nella<br />
stessa UE, il rapporto presentava una serie di proposte di miglioramento di queste ultime, che alla<br />
fine concludeva per una sostanziale conferma della differenziazione prospettata dal gruppo dei tre<br />
saggi tra procedura generale (con le ratifiche nazionali di tutti gli Stati membri) per le disposizioni<br />
del trattato fondamentale e procedura speciale di revisione autonoma (senza ratifiche nazionali) per<br />
le disposizioni non fondamentali, ma con questa decisiva riserva:<br />
“Ciò non toglie che la procedura generale di revisione del diritto primario […] continuerebbe a imporsi per esclusione,<br />
ogni volta e fintanto che non sia stata prevista una procedura speciale. Ciò accadrebbe perché il diritto primario non ripreso<br />
nel Trattato fondamentale comporta delle disposizioni, quali le basi giuridiche operative, che da una parte sono fin<br />
troppo numerose e troppo tecniche per figurare in un Trattato fondamentale, ma che d’altra parte riguardano da vicino i<br />
poteri degli Stati membri, e che a questo titolo si prestano meno a una procedura di revisione autonoma.”<br />
Con questa affermazione il rapporto faceva capire che, in pratica, a meno che si fosse realmente<br />
convenuto, in sede politica, di istituire una procedura di revisione autonoma per tutte le disposizioni<br />
non fondamentali (p.e. attraverso una loro trasformazione in una sorta di unica “legge organica” a<br />
metà strada fra il trattato e la legge ordinaria dell’UE), non era ipotizzabile una differenziazione delle<br />
procedure di ratifica a seconda dei due tipi di disposizioni, con la decisiva conseguenza, in tal caso,<br />
del venir meno di una delle due ragioni che presiedevano alla necessità di mantenere due testi<br />
distinti e separati per i due tipi di disposizioni.<br />
Poco tempo dopo si svolgeva il Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19-20 giugno 2000.<br />
Esso prendeva atto in primo luogo “del nuovo dibattito pubblico sul futuro dell’Unione Europea e<br />
dell’interesse suscitato da quest’ultimo”. Confermava la sua volontà che la CIG pervenisse alla conclusione<br />
dei suoi lavori nel dicembre 2000 e invitava la Convenzione a presentare il suo progetto di<br />
Carta nell’ottobre 2000. Ma soprattutto precisava ulteriormente il quadro gerarchico della conduzione<br />
della politica economica comune. Alla base di essa dovevano essere sviluppati ulteriormente i