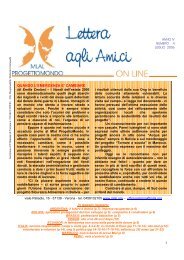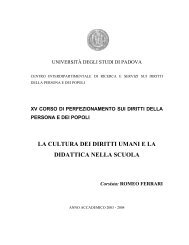cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"
cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"
cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
- una “più chiara delimitazione delle competenze tra livello europeo e livello nazionale”;<br />
- l’espresso invito alla CIG “a iscrivere nel suo ordine del giorno l’inserimento nel trattato della Carta dei <strong>diritti</strong> fondamentali<br />
per darle un carattere giuridico cogente […]”, nonché “a fare in modo che l’Unione aderisca alla Convenzione<br />
europea per la salvaguardia dei <strong>diritti</strong> dell’uomo […]”, e infine “a migliorare l’accesso delle persone fisiche e giuridiche<br />
alla Corte di giustizia […]”;<br />
- la procedura di revisione dei trattati doveva “riflettere la duplice legittimità dell’Unione in quanto unione di popoli e<br />
unione di Stati”;<br />
- “la struttura a pilastri e la cooperazione intergovernativa […] dovrebbero essere gradualmente abbandonate”;<br />
- l’<strong>attiva</strong>zione della cooperazione rafforzata “solo in casi di effettiva impossibilità dell’Unione Europea ad agire collettivamente”;<br />
l’applicazione delle disposizioni sulla cooperazione rafforzata a tutti e tre i pilastri (CE, PESC e CPGMP);<br />
la presenza di almeno un terzo degli Stati membri per l’<strong>attiva</strong>zione di una cooperazione rafforzata; la sua autorizzazione<br />
dietro proposta della Commissione, voto a maggioranza qualificata del Consiglio e parere conforme del PE.<br />
Dallo stesso modo di formulazione di tali proposte “costituzionali” emergeva che in realtà il PE sapeva<br />
benissimo che tali richieste non avrebbero potuto essere recepite dalla CIG e infatti riservava<br />
espressamente a quest’ultima solo quelle, primarie, inerenti all’inserimento nel trattato della Carta<br />
dei <strong>diritti</strong> fondamentali con valore giuridico cogente, all’adesione dell’UE alla Convenzione europea<br />
e all’accesso universale alla Corte di giustizia. Una volta avesse ottenuto questo, sarebbe scattato<br />
pressoché automaticamente il processo di costituzionalizzazione dell’UE e quindi l’esigenza di<br />
soddisfare a tutte le altre richieste specificate nella risoluzione. Queste coincidevano sostanzialmente<br />
con i contenuti che saranno propri del futuro TCE e, anche dopo il suo abbandono, del futuro<br />
“trattato di riforma” in discussione nell’attuale CIG. La vera novità, a questo proposito, era data<br />
dall’introduzione di “una gerarchia delle norme”, che comportava in particolare diversi tipi di procedura<br />
di revisione per la parte A e per la parte B del trattato unificato, ossia la previsione solo per<br />
la parte A di una procedura di ratifica da parte degli Stati membri, mentre la parte B avrebbe potuto<br />
essere emendata attraverso un procedimento di codecisione a maggioranza del Consiglio e del PE,<br />
senza CIG né processi di ratifica nazionali e perciò senza il requisito dell’unanimità. 312<br />
Al terzo punto della risoluzione figurava il tema “per un rafforzamento del ruolo esterno<br />
dell’Unione Europea”.<br />
A proposito delle relazioni economiche esterne il PE si pronunciava per la necessità che, “una volta<br />
conclusi i negoziati […] il Parlamento esprime il suo parere conforme sullo strumento normativo<br />
internazionale e codecide in merito alla necessaria legislazione in seno alla Comunità europea.”<br />
Quanto alla PESC, invece, si avanzavano le seguenti proposte:<br />
- “la distinzione tra il primo e il secondo pilastro del trattato va progressivamente ridotta e va potenziata la competenza<br />
comunitaria, in particolare attribuendo alla Commissione un ruolo maggiore nel coordinamento degli strumenti comunitari<br />
e nazionali non militari per quanto attiene alla gestione internazionale delle crisi”;<br />
- la creazione di “un Consiglio dei ministri della difesa, che si occupi delle questioni tecnico-operative della politica europea<br />
in materia di sicurezza e di difesa, mentre tutte le decisioni riguardanti la PESC dovrebbero essere proposte al<br />
Consiglio “Affari generali” e da esso adottate”;<br />
- la soppressione della possibilità di veto circa le decisioni a maggioranza qualificata e del rinvio al Consiglio europeo e<br />
la loro sostituzione con la possibilità “di derogare dall’obbligo di appoggiare la posizione comune o partecipare<br />
all’azione comune”;<br />
- la previsione del finanziamento a carico del bilancio comunitario anche per le azioni comuni nel quadro dei compiti di<br />
Petersberg (detratto il finanziamento nazionale delle truppe e della relativa dotazione nella gestione delle crisi);<br />
312 In tal modo il PE riconosceva finalmente il principio della differenziazione dei procedimenti di revisione a seconda<br />
delle disposizioni di natura costituzionale e di quelle di altra natura e di conseguenza anche il principio di una gerarchizzazione<br />
dei due tipi di disposizioni. E ciononostante continuava a ignorare la precisa proposta del gruppo di Dehaene<br />
sulla necessità di redigere, anche a tale scopo, due testi ben distinti tra loro, insistendo invece sul fatto che i due<br />
gruppi di disposizioni avrebbero dovuto costituire due parti di un unico testo. C’è da chiedersi invece cosa sarebbe avvenuto<br />
del TCE, se esso fosse stato effettivamente limitato alla “parte A” ossia alle prime due parti dello stesso TCE<br />
(preambolo, parte I e parte II ossia la Carta), all’atto di presentarlo alle ratifiche e soprattutto ai referendum nazionali.<br />
Indubbiamente avrebbe avuto un effetto molto meno “indigesto” e forse molto più “appetibile”.