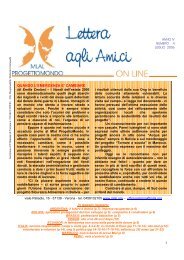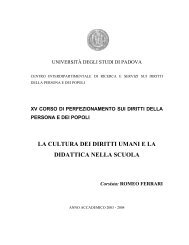cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"
cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"
cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Naturalmente il punto più importante era ancora una volta il primo. Per quanto riguarda l’”Unione<br />
Politica”, il Consiglio europeo prendeva in considerazione: a) i principi; b) la politica estera e di sicurezza<br />
comune; c) la legittimazione democratica; d) la politica sociale; e) la coesione economica e<br />
sociale; f) l’adempimento della legge della Comunità; g) la cooperazione negli affari interni e giudiziaria.<br />
Quanto ai “principi”, il Consiglio europeo enunciava i seguenti: a) pieno mantenimento e sviluppo<br />
dell’acquis communautaire, b) un unico quadro istituzionale con procedure appropriate ai requisiti<br />
delle varie sfere d’azione, c) la natura evolutiva del processo d’integrazione o d’unione, d) il principio<br />
di sussidiarietà, e) il principio della coesione economica e sociale e soprattutto f) la creazione<br />
della <strong>cittadinanza</strong> dell’Unione.<br />
Quanto alla “politica estera e di sicurezza comune” (PESC), il Consiglio europeo auspicava un approccio<br />
autenticamente globale della PESC, esprimendo:<br />
“il desiderio unanime di rafforzare l’identità e il ruolo dell’Unione come un’entità politica sulla scena internazionale,<br />
così come la preoccupazione di assicurare la coerenza di tutte le sue attività esterne. […] La politica estera e di sicurezza<br />
comune si estenderà a tutte le questioni relative alla sicurezza dell’Unione.”<br />
Quanto alla “legittimazione democratica”, il Consiglio europeo confermava la necessità di rafforzare<br />
“il ruolo politico, legislativo e di monitoraggio del Parlamento Europeo, che deve andare di pari<br />
passo con lo sviluppo dell’Unione”, proponendo il riconoscimento del principio della procedura decisionale.<br />
Quanto alla “cooperazione negli affari interni e giudiziaria”, la stessa CIG aveva presentato delle<br />
proposte relative a 1) la politica sull’asilo, sull’immigrazione e sugli stranieri e 2) la lotta contro il<br />
traffico internazionale di droga e il crimine organizzato (con la previsione della piena creazione di<br />
un Ufficio investigativo centrale europeo, “Eurogol”). In tal modo questi temi, altrimenti tipici delle<br />
competenze dei ministri dell’interno o della giustizia dello Stato nazionale, ma, con l’avvento prossimo<br />
di un’Europa senza frontiere interne, affrontabili ormai soltanto a livello comunitario, venivano<br />
proposti come nuovi settori d’azione per l’Unione Europea in quanto tale, prefigurando per<br />
quest’ultima un nuovo ampio campo d’azione comune, la ”politica degli affari interni e giudiziaria”.<br />
Infine il successivo Consiglio europeo di Maastricht del 9-10 dicembre 1991 annunciò la conclusione<br />
delle due CIG e la fusione dei rispettivi risultati in un unico testo ovvero nel progetto di un trattato<br />
sull’Unione Europea, che avrebbe dovuto essere firmato all’inizio del febbraio 1992.<br />
II. Il Trattato di Maastricht<br />
E difatti i ministri degli esteri e delle finanze degli Stati membri firmavano poi a Maastricht il 7<br />
febbraio 1992 il Trattato sull’Unione Europea.<br />
Il trattato confermava le proprie finalità generali già nel suo Preambolo, dove gli Stati membri affermavano<br />
la loro volontà di “segnare una nuova tappa nel processo d’integrazione europea”, dal<br />
momento che con la “fine della divisione del continente europeo” si imponeva “la necessità di creare<br />
solide basi per l’edificazione dell’Europa futura”. Tali solide basi erano da ricercare in primo<br />
luogo nel “proprio attaccamento ai principi della libertà, della democrazia e del rispetto dei <strong>diritti</strong><br />
dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché dello Stato di diritto” e insieme nel desiderio di “intensificare<br />
la solidarietà tra i loro popoli”. La garanzia di tale impegno democratico era la istituzione<br />
di “una <strong>cittadinanza</strong> comune ai cittadini dei loro Paesi”. Coniugando la rinnovata democrazia<br />
delle istituzioni con una loro rafforzata efficienza, sarebbe stato possibile ottenere la loro efficacia<br />
complessiva in ordine al conseguimento dei compiti loro affidati. L’efficienza delle istituzioni era<br />
da individuare a sua volta nella creazione di “un contesto istituzionale unico”, valido per tutti i pur<br />
diversi settori di azione emersi dallo sviluppo dell’integrazione europea. E tale contesto istituzionale<br />
unico doveva essere appunto quello dato dalla creazione dell’”Unione europea”.<br />
Il testo vero e proprio del trattato concentrava la propria attenzione sull’Unione Europea in quanto<br />
tale nella prima parte di esso, dedicata alle cosiddette “Disposizioni comuni”.