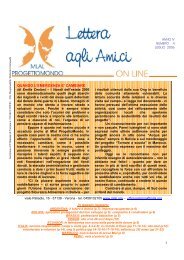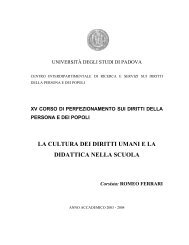cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"
cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"
cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Stabiliti i contenuti delle priorità-chiave del lavoro della prevista CIG, il PE poneva peraltro pure il<br />
problema della “trasparenza nel processo di revisione del trattato”, nei termini di un “coinvolgimento”<br />
sia “del pubblico”, sia “del Parlamento Europeo”.<br />
Per quanto riguarda il “coinvolgimento del pubblico”, il PE riteneva essenziale che “i cittadini europei<br />
e i loro rappresentanti eletti siano direttamente informati, a livello sia nazionale, sia<br />
dell’Unione, del progresso e della sostanza della CIG” e comunicava di aver già iniziato lui stesso<br />
delle “audizioni pubbliche” per un “dialogo con il pubblico” teso a evidenziare una “lista di verifica<br />
delle preoccupazioni dei cittadini che hanno bisogno di venire affrontate dall’Unione Europea”, ma<br />
soprattutto considerava pure che “i <strong>diritti</strong> dei cittadini europei di fondare associazioni transfrontaliere<br />
dovrebbero essere esplicitamente riconosciuti nel trattato. Per realizzare questo obiettivo dovrebbe<br />
essere stabilito un appropriato quadro legale europeo, che dovrebbe abilitare simili associazioni a<br />
essere informate di, e coinvolte in, iniziative e azioni dell’UE” e infine invitava tutti gli Stati membri<br />
a “stimolare un dibattito pubblico sui temi della CIG”. 215<br />
Quanto al “coinvolgimento del Parlamento Europeo”, il PE esigeva la propria partecipazione ai lavori<br />
della CIG fin dal loro inizio, ponendo altrimenti in discussione la legittimità della stessa apertura<br />
della CIG.<br />
Infine il PE poneva precisi “limiti alla flessibilità” nei riguardi di “qualsiasi accordo speciale negoziato<br />
alla CIG”, ovvero che non si pervenisse a un’”Europa à la carte”, né si compromettessero “i<br />
principi chiave del mantenimento dell’acquis communautaire e il quadro istituzionale unico, la solidarietà,<br />
e la coesione economica e sociale, e l’uguaglianza di tutti gli Stati e cittadini dell’Unione<br />
davanti al trattato”. 216<br />
Di fronte a questa chiara, unitaria e articolata presa di posizione del PE, si svolgeva poi, finalmente,<br />
la riunione del Consiglio europeo di Torino del 29 marzo 1996, con l’inaugurazione della prevista<br />
Conferenza intergovernativa (CIG). Nelle conclusioni di tale riunione, il Consiglio europeo stabiliva<br />
l’”agenda della CIG”, dandole un chiaro mandato, basato sulla relazione del Gruppo di riflessione,<br />
ma caratterizzato da una maggiore omogeneità e univocità di direttive (frutto di un’attenta considerazione,<br />
da parte della presidenza italiana, dell’ultima risoluzione del PE) nei tre seguenti settori:<br />
1) “un’Unione più vicina ai cittadini”; 2) “le istituzioni in un’Unione più democratica ed efficiente”;<br />
3) “rafforzare la capacità per un’azione esterna dell’Unione”.<br />
Per quanto riguarda il primo settore, il Consiglio europeo sosteneva:<br />
contribuito non poco al rifiuto di esso, al blocco del processo di ratifica in altri sette Stati membri e alla conseguente decadenza<br />
del TCE. Il futuro “trattato di riforma”, in discussione nell’attuale CIG del 2007, dovrebbe portare, peraltro,<br />
pur nel ritorno alla vecchia e tranquillizzante procedura dei trattati emendativi (come, appunto, il trattato di Amsterdam<br />
del 1997), al mantenimento sostanziale non solo delle disposizioni del TCE, bensì anche della suddivisione di esso in<br />
due parti (“costituzionale” e applicativa) sotto forma stavolta di due trattati e precisamente dei due trattati fondativi,<br />
emendati, dell’Unione Europea e della Comunità Europea, con la conseguente ridenominazione di quest’ultimo appunto<br />
come trattato “sul funzionamento dell’Unione”. Come dire: al di là di questo forsennato rimescolamento di carte, il disegno<br />
originario sussiste ancora, ma alquanto sepolto sotto una dissimulazione, soprattutto formale, tesa a evitare lo<br />
stesso ricorso ai referendum e quindi anche solo il rischio del ripetersi (in tal caso letale) di rovinosi eventi referendari<br />
come quelli francese e olandese del 2005, anche a costo del sacrificio dei valori di trasparenza e apertura, tipici del vero<br />
spirito della Costituzione.<br />
215 In tal modo il PE, in previsione del coinvolgimento non solo di se stesso, ma anche del “pubblico”, nei lavori della<br />
CIG, apriva finalmente anch’esso alla prospettiva di una costante e strutturale partecipazione dei cittadini alla vita politico-istituzionale<br />
dell’UE, nella forma della proposta di inserire nel trattato i <strong>diritti</strong> dei cittadini europei di fondare “associazioni<br />
transfrontaliere”, abilitate, attraverso un apposito quadro legale europeo, a “essere informate di, e coinvolte<br />
in, iniziative e azioni dell’UE”: si trattava del più pieno riconoscimento della nuova dimensione della “democrazia partecipativa”<br />
europea, fatta agire in sinergia con la tradizionale “democrazia rappresentativa” europea (di cui il PE costituiva<br />
la massima espressione) quale volano per lo stesso sviluppo effettivo di quest’ultima.<br />
216 Memore delle “deroghe” già concesse o in via di concessione a taluni Stati membri (Danimarca e Regno Unito),<br />
nell’intento di impedire l’estensione di esse ad altri temi e persino ad altri Stati membri, il PE sosteneva pure: “è essenziale<br />
per l’Unione definire, sulla base dell’acquis communautaire, che deve essere mantenuto in pieno, chiari e precisi<br />
intenti e obiettivi, che siano condivisi da tutti gli Stati membri e che non possano essere messi in discussione in nessuna<br />
occasione.”