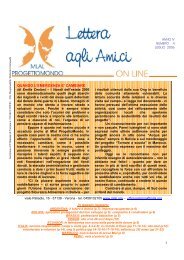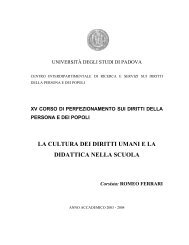cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"
cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"
cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
nenti”. Tale Convenzione avrebbe dovuto essere guidata da un “Praesidium”, composto dal presidente,<br />
dal rappresentante della Commissione, da due membri scelti dai Parlamenti nazionali, da due<br />
rappresentanti del PE e dai rappresentanti della presidenza in carica e della presidenza successiva<br />
del Consiglio. Il presidente della Convenzione avrebbe dovuto essere “una personalità politica di<br />
fama e di prestigio europeo, dotata di esperienza parlamentare” e venire eletto dalla stessa Convenzione.<br />
Inoltre il Praesidium della Convenzione avrebbe dovuto poter “partecipare pienamente e <strong>attiva</strong>mente<br />
in tutte le fasi e a tutti i livelli alla CIG” successiva.<br />
La Convenzione avrebbe dovuto decidere in piena autonomia l’organizzazione dei propri lavori, da<br />
condurre “in piena trasparenza”, istituendo “un dialogo attivo con i cittadini” e anzi un “forum della<br />
società civile”, che le consentisse di “tenere uno stretto contatto con i cittadini”.<br />
La Convenzione, inoltre, doveva essere dotata di una procedura decisionale, che le permettesse di<br />
“elaborare per consenso una proposta unica e coerente”, da presentare alla CIG come “unica base<br />
negoziale e decisionale”. Infine la tabella di marcia avrebbe dovuto essere, a differenza di quella del<br />
Consiglio europeo, la seguente: inizio dei lavori della Convenzione nella prima metà del 2002, loro<br />
conclusione per la metà del 2003, svolgimento della CIG nell’autunno 2003 e firma del “nuovo trattato”<br />
nel dicembre 2003, in modo da consentire alle elezioni europee del giugno 2004 di costituire,<br />
in termini di affluenza alle urne, una sorta di plebiscito a esso, esteso ai nuovi Stati membri nel frattempo<br />
entrati nell’UE.<br />
E finalmente si perveniva alla riunione, tanto attesa, del Consiglio europeo di Laeken del 14-15 dicembre<br />
2001. La sua apertura era allietata dall’inizio della distribuzione, il 14 dicembre 2001, degli<br />
“euro-kits” e quindi della possibilità per i cittadini di acquistare le monete in euro in vista del passaggio<br />
alla moneta unica.<br />
Il primo tema discusso in tale riunione fu naturalmente “il futuro dell’Unione” e in primo luogo il<br />
Consiglio europeo adottava la “Dichiarazione di Laeken sul futuro dell’Unione Europea”.<br />
In essa, con un linguaggio quanto mai piano e aperto, si riassumeva il percorso del processo<br />
d’integrazione europea e le sfide di fronte alle quali era allora posta l’Unione. Quasi come se si esponessero<br />
i risultati di un sondaggio d’opinione fra i cittadini, si descrivevano le loro aspettative e i<br />
loro timori rispetto all’UE. E, partendo da essi, si elencavano poi tutte le questioni avanzate dal PE,<br />
senza eccezione alcuna (compresa l’idea di una Costituzione), esprimendole in forma problematica<br />
con una serie di domande o di punti interrogativi. Le ultime domande ossia le più impegnative riguardavano<br />
“la via verso una Costituzione per i cittadini europei” ed erano le seguenti:<br />
“Attualmente l’Unione europea conta quattro trattati. Gli obiettivi, le competenze e gli strumenti politici dell’Unione<br />
sono sparsi in questi trattati. In un’ottica di maggiore trasparenza, una semplificazione è imprescindibile.<br />
Si possono quindi formulare quattro serie di domande. La prima riguarda la semplificazione degli attuali trattati senza<br />
modificarne il contenuto. Deve essere riveduta la distinzione fra Unione e Comunità? E la suddivisione in tre pilastri?<br />
Seguono poi le domande relative ad una possibile riorganizzazione dei trattati. È necessario operare una distinzione fra<br />
un trattato di base e le altre disposizioni del trattato? Questa distinzione dovrebbe comportare una separazione dei testi?<br />
Ne può derivare una distinzione fra le procedure di modifica e di ratifica per il trattato di base e per le altre<br />
disposizioni del trattato?<br />
Occorre inoltre riflettere sull’opportunità di inserire la Carta dei <strong>diritti</strong> fondamentali nel trattato di base e porre il quesito<br />
dell’adesione della Comunità europea alla Convenzione europea dei <strong>diritti</strong> dell’uomo.<br />
Infine, si pone il quesito se questa semplificazione e questo riordino non debbano portare, a lungo andare, all’adozione<br />
nell’Unione di un testo costituzionale. Quali dovrebbero essere gli elementi di base di tale legge fondamentale? I valori<br />
che l’Unione coltiva, i <strong>diritti</strong> e i doveri fondamentali del cittadino, i rapporti fra gli Stati membri all’interno<br />
dell’Unione?” 356<br />
356 Questo passo cruciale della Dichiarazione di Laeken era stato preceduto dalla Dichiarazione franco-tedesca di Nantes<br />
del novembre 2001, in cui si auspicava “una divisione dei trattati in una parte costituzionale e una parte infracostituzionale<br />
più facile da far evolvere”, ovvero una netta suddivisione funzionale a far sì che la seconda parte, appunto<br />
in quanto non fondamentale, fosse soggetta a un nuovo tipo di procedura di revisione, non più attraverso CIG, ratifiche<br />
nazionali e unanimità, bensì attraverso una decisione istituzionale comunitaria a maggioranza (Commissione, Consiglio<br />
e PE). La Dichiarazione di Laeken aggiungeva poi l’ipotesi di una differenziazione delle procedure della stessa<br />
ratifica per il trattato di base e per le altre disposizioni del trattato.