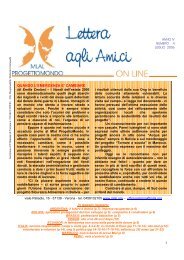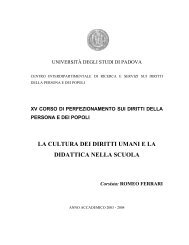cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"
cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"
cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
stanziale omogeneità del processo d’integrazione europea, il PE avocava per se stesso il potere di<br />
controllo “su quelle politiche dell’Unione che sono perseguite da parte di un numero limitato di Stati<br />
membri su una base temporanea” ovvero su eventuali cooperazioni rafforzate.<br />
Anzi, nel timore che qualcuno degli stessi Quindici Stati membri dell’UE si opponesse, già in sede<br />
di CIG, a un accordo sul futuro trattato, il PE non esitava a proporre di “procedere senza la minoranza<br />
e, possibilmente, disporre strumenti per consentire a uno Stato membro di lasciare l’UE […]”.<br />
In tal modo si rafforzava ulteriormente la tendenza del PE a prefigurare l’avanzamento del processo<br />
d’integrazione sulla base anche solo di una larga maggioranza di Stati membri (fin dall’atto della<br />
firma di un nuovo trattato) e persino della fuoriuscita volontaria dall’Unione dello Stato membro interessato.<br />
Tale “precauzione” del PE era tanto più avvalorata dal fatto che il nuovo trattato avrebbe dovuto<br />
rafforzare gli stessi meccanismi comunitari in vista dell’unificazione dei tre “pilastri” e soprattutto<br />
del futuro ingresso massiccio di nuovi Stati membri. Tale rafforzamento doveva procedere peraltro<br />
secondo la necessaria endiadi “più forti e più democratiche istituzioni dell’Unione”. A questo proposito<br />
il PE faceva notare che non si trattava di trasferire nuovi poteri all’UE, bensì di chiarire i ruoli<br />
rispettivi delle sue diverse istituzioni e di garantire un adeguato equilibrio fra loro, nonché di ridefinire<br />
la loro composizione interna a fronte del previsto ingresso massiccio di nuovi Stati membri, in<br />
modo da assicurare insieme l’efficienza complessiva del sistema e gli interessi degli Stati membri<br />
“grandi e piccoli”. Inoltre veniva richiesto un graduale incremento della “rappresentanza e partecipazione<br />
delle donne a tutti i livelli dell’Unione”.<br />
Per quanto riguarda la Commissione, il PE suggeriva un incremento dei poteri del suo presidente,<br />
che in compenso avrebbe dovuto essere eletto direttamente dal Parlamento Europeo tra una lista di<br />
nomi avanzata dal Consiglio europeo, mentre il resto della Commissione, nominato dal suo presidente<br />
(d’accordo con i governi nazionali), avrebbe dovuto essere soggetta a un voto di fiducia del<br />
PE, che avrebbe dovuto avere pure il diritto (come il Consiglio) di richiedere le dimissioni di un<br />
singolo commissario.<br />
Per quanto riguarda il Consiglio, si raccomandava la pubblicità delle sue sedute, se rivolte<br />
all’approvazione di atti legislativi, che avrebbero dovuto essere pubblicizzati al massimo. Inoltre si<br />
esigeva l’ulteriore estensione del voto a maggioranza qualificata. Tuttavia il PE prendeva stranamente<br />
le distanze dal sistema di voto a “doppia maggioranza” (degli Stati e della popolazione), “in<br />
quanto è nel Parlamento che la popolazione è rappresentata. Il Consiglio rappresenta gli Stati. Un<br />
voto ponderato che rifletta la grandezza generale degli Stati non sarà strettamente proporzionato alla<br />
popolazione.” In ogni caso si raccomandava l’abbassamento della soglia della maggioranza qualificata<br />
rispetto all’eccessivo 71% sino ad allora in vigore.<br />
Per quanto riguarda il Parlamento Europeo, la risoluzione esigeva: che il numero massimo dei suoi<br />
membri non superasse mai (a prescindere dal numero degli Stati membri) i 700 seggi; che vi dovesse<br />
essere l’assenso del PE per tutte le nomine per la Corte di giustizia, la Corte di prima istanza, la<br />
Corte dei conti e per i membri del Comitato esecutivo del Sistema europeo delle banche centrali;<br />
che il PE avesse pari dignità rispetto al Consiglio in tutti i campi di competenza legislativa e di bilancio<br />
dell’UE; che il ruolo del PE fosse rafforzato riguardo alla PESC e alla CSGAI, come pure nel<br />
campo dell’UEM; che il PE avesse il diritto di richiedere l’opinione della Corte di giustizia sulla<br />
compatibilità con il trattato (sulla “costituzionalità”) di accordi internazionali, di aprire delle cause<br />
di fronte a essa (a prescindere dalla difesa delle prerogative del PE) e di venire coinvolto nel procedimento<br />
di emissione di ordinanze preliminari; che il PE avesse il diritto di partecipare alla decisione<br />
riguardante la propria sede; che la Commissione avesse l’obbligo di rispondere alle iniziative legislative<br />
del PE. Infine veniva proposto un rafforzamento della collaborazione tra il PE e i Parlamenti<br />
nazionali, per migliorare il controllo democratico in tema di UE.<br />
Per quanto riguarda la Corte di giustizia, il PE proponeva che essa avesse i pieni mezzi per assicurare<br />
il rispetto delle leggi dell’UE e dell’equilibrio istituzionale dell’Unione, ma anche che la sua<br />
competenza si estendesse pure alla PESC e alla CSGAI.