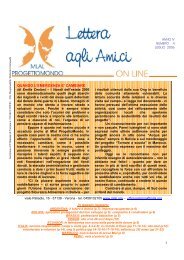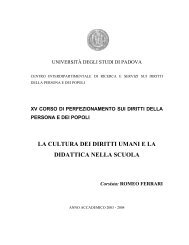cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"
cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"
cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
6. reputa indispensabile, per la preparazione dei lavori della CIG, organizzare una concertazione con i Parlamenti nazionali<br />
degli Stati membri e avviare un dialogo aperto con i Parlamenti dei Paesi candidati e le organizzazioni che<br />
rappresentano la società civile; […]<br />
8. chiede che la CIG sia convocata il più presto possibile dopo il Consiglio europeo di Helsinki del dicembre 1999;<br />
9. ritiene ovvio e legittimo di dover partecipare pienamente a tutte le fasi e a tutti i livelli della CIG per il tramite di due<br />
rappresentanti eletti dall’Aula;<br />
10. ritiene che la decisione finale degli Stati membri gli debba essere sottoposta come nella procedura del parere conforme;<br />
Posto questo metodo, il PE si sentiva a maggior ragione autorizzato a proporre un “contenuto delle<br />
riforme” che fosse all’altezza degli obiettivi della riforma, e lo individuava nei seguenti elementi<br />
portanti: 1) la costituzionalizzazione dell’Unione (per avvicinare l’Europa ai cittadini), 2) riforme<br />
istituzionali sufficientemente ambiziose, 3) una nuova clausola relativa a un rafforzamento<br />
dell’integrazione, 3) il rafforzamento del ruolo esterno dell’UE, 4) lo spazio di libertà, di sicurezza e<br />
di democrazia, 5) il rafforzamento della politica economica, sociale e occupazionale.<br />
Per quanto riguarda la “costituzionalizzazione dell’Unione”, il PE affermava risolutamente:<br />
“13. ritiene che la prospettiva di un’Unione ampliata renda necessario il varo di un processo costituzionale che comprenda<br />
una semplificazione e razionalizzazione dei trattati al fine di assicurarne la trasparenza e l’intelligibilità per i cittadini;<br />
è del parere che l’elaborazione della Carta dei <strong>diritti</strong> fondamentali sia parte integrante di tale processo costituzionale;<br />
14. ritiene che tale processo costituzionale consoliderebbe i <strong>diritti</strong> degli Stati membri e dei cittadini dell’Unione Europea<br />
e chiarirebbe le competenze delle istituzioni comuni;<br />
15. ritiene che la costituzionalizzazione dell’Unione implichi, in particolare, la fusione dei trattati in un testo unico e<br />
la distinzione tra due parti:<br />
a) una parte costituzionale, comprendente il preambolo, gli obiettivi dell’Unione e i <strong>diritti</strong> fondamentali, nonché le disposizioni<br />
concernenti le istituzioni, le procedure decisionali e le varie competenze;<br />
b) una seconda parte che definisce gli altri settori dell’attuale trattato;<br />
16. ritiene che la CIG debba modificare la futura procedura di revisione dei trattati basandola sulla duplice legittimazione<br />
dell’Unione, onde pervenire a una democratizzazione del processo di revisione grazie all’introduzione di un<br />
potere codecisionale dell’istituzione che rappresenta gli Stati [il Consiglio] e di quella che rappresenta i cittadini<br />
dell’Unione [il Parlamento Europeo];<br />
17. è favorevole all’elaborazione di uno statuto dei partiti politici a livello europeo quale passo positivo per facilitare<br />
la partecipazione politica dei cittadini;”<br />
Il PE poneva dunque come primo contenuto delle riforme, da realizzarsi già attraverso l’imminente<br />
CIG, la stessa “costituzionalizzazione” dell’UE, che veniva ormai fatta coincidere con la redazione<br />
di un unico trattato, che, pur senza venir denominato “Costituzione”, né “trattato costituzionale”,<br />
comportasse (proprio nella sua natura di rappresentare il punto di riferimento tra l’UE e i suoi cittadini<br />
e quindi nella necessità di risultare comprensibile a questi ultimi) la rifusione in sé di tutti i trattati<br />
costitutivi preesistenti, secondo un’articolazione logico-giuridica di natura prettamente costituzionale.<br />
La suddivisione, infatti, di quest’unico trattato in due parti ben distinte tra loro, una propriamente<br />
costituzionale, e l’altra per così dire applicativa, mentre consentiva comunque una visione<br />
unitaria di tutta la normativa costitutiva esistente, focalizzava, nella prima parte, gli elementi<br />
portanti dell’UE (preambolo, obiettivi, <strong>diritti</strong> fondamentali (ossia la stessa Carta, incardinata quindi<br />
nel trattato e perciò rivestita di valore legale vincolante), istituzioni, procedure decisionali e competenze),<br />
in una sorta di quadro di immediato utilizzo proprio per i cittadini.<br />
Il carattere in qualche modo definitivo di tale trattato si evidenziava pure dalla nuova procedura di<br />
revisione di esso per i tempi futuri, individuata non più in una CIG, bensì nella stessa procedura codecisionale,<br />
del Consiglio e del PE, che avrebbe dovuto caratterizzare tutta l’attività politica futura<br />
dell’UE. 301 Infine il nuovo ruolo del PE avrebbe dovuto comportare una maggiore vicinanza di esso<br />
301 In tal modo il PE non raccoglieva, di fatto, la chiara indicazione del rapporto del gruppo di Dehaene sulla necessità<br />
di distinguere e anzi di separare i due testi, fondamentale e non, al duplice fine di fornire ai cittadini un trattato fondamentale<br />
(ben separato dal resto) e di permettere invece alle disposizioni presenti nell’altro testo di venire sottoposte a un<br />
procedimento di revisione istituzionale europeo (senza CIG, ratifiche nazionali e unanimità). E infatti la risoluzione del