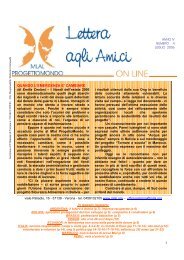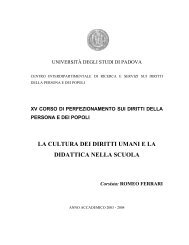cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"
cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"
cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
In tal modo, sotto la nuova espressione, acc<strong>attiva</strong>nte quanto vaga, di “futuro dell’Unione”,<br />
all’insegna comunque della realizzazione di una nuova “legittimità democratica” dell’UE, era lanciato<br />
un “ampio dibattito”, che, a partire dallo stesso anno 2001, avrebbe dovuto coinvolgere “tutte<br />
le parti interessate”, compresi gli “esponenti della società civile”. Il modo di far confluire tale dibattito<br />
in una sede decisionale appropriata sarebbe stato deciso in base a una prevista “dichiarazione”<br />
del Consiglio europeo di Laeken nel dicembre 2001. In ogni caso i punti che avrebbero dovuto essere<br />
comunque presi in considerazione e decisi erano: a) la “delimitazione delle competenze” tra UE e<br />
Stati membri, b) lo “status della Carta dei <strong>diritti</strong> fondamentali” dell’UE, c) la “semplificazione dei<br />
trattati”, d) il “ruolo dei Parlamenti nazionali” nell’Unione. Al termine di tali “lavoratori preparatori”,<br />
si sarebbe svolta, nel 2004, una nuova CIG, che avrebbe condotto a un nuovo trattato emendativo.<br />
Con questa dichiarazione della CIG veniva così accolto, in gran parte, il piano d’azione del PE previsto<br />
nella sua risoluzione del 25 ottobre 2000, salvo una, peraltro decisiva, precisazione: “in vista<br />
delle corrispondenti modifiche dei trattati”. In altri termini: per quanto rivoluzionarie fossero tali<br />
modifiche, esse avrebbero dovuto venire recepite all’interno di un ennesimo trattato emendativo dei<br />
trattati istitutivi, che sarebbero perciò stati mantenuti nella loro pluralità.<br />
Complessivamente, dunque, l’intero dispositivo del trattato di Nizza si segnalava per la sua fondamentale<br />
ambiguità: da un alto vedeva scarse novità e anzi il trionfo di una logica spartitoria tra gli<br />
Stati membri presenti e futuri, e dall’altro lato apriva tuttavia la strada a un processo che avrebbe<br />
rivoluzionato, sia nella forma (l’”ampio dibattito”), sia nei contenuti (il processo di “costituzionalizzazione”),<br />
l’intera storia del processo d’integrazione europea. Ad aggravare tale ambiguità era<br />
inoltre la deliberata scelta di far avanzare il processo dell’enorme allargamento a 27 Stati membri<br />
indipendentemente dai tempi e dai risultati del dibattito “sul futuro dell’Unione Europea”.<br />
L’incrocio finale, in parte fortuito, fra questi tre elementi, ambizioni costituzionali, rivendicazioni<br />
nazionali e allargamento dell’UE, avrebbe comportato perciò il rischio di un infernale corto circuito,<br />
in cui avrebbe potuto smarrirsi il senso stesso della distinzione tra queste dimensioni nel sentimento,<br />
indistinto, ma profondo, della “eccessività” e dunque della “insostenibilità” della stessa<br />
nuova Unione.<br />
III. Verso la Convenzione sul futuro dell’Europa<br />
Subito dopo la firma del trattato di Nizza, veniva lanciato, il 7 marzo 2001, il dibattito sul futuro<br />
sviluppo dell’Unione Europea.<br />
Un mese dopo la firma del trattato di Nizza, si svolgeva poi il Consiglio europeo di Stoccolma del<br />
23-24 marzo 2001. Si trattava della “prima riunione annuale di primavera dedicata ai problemi economici<br />
e sociali”. Il tema principale di essa era la “sfida demografica”, rappresentata<br />
“dall’invecchiamento della popolazione con una quota sempre più ridotta di persone in età lavorativa”,<br />
almeno entro il 2010. Si prevedeva perciò che, a partire da tale data, ciò avrebbe creato “pressioni<br />
considerevoli sui sistemi previdenziali, in particolare sulle pensioni e sui sistemi di assistenza<br />
sanitaria e di assistenza agli anziani.” Pertanto, entro tale data, occorreva intervenire risolutamente,<br />
“aumentando i tassi di occupazione, riducendo il debito pubblico e adeguando i sistemi di protezione<br />
sociale, inclusi i regimi pensionistici.” Per quanto riguarda la prima modalità, si stabiliva<br />
l’obiettivo intermedio di raggiungere per il gennaio 2005 un tasso di occupazione del 67% in generale<br />
e l’obiettivo finale di raggiungere entro il 2010 un tasso medio di occupazione degli anziani<br />
(dai 55 ai 64 anni) del 50%. L’intera strategia di Lisbona (comprensiva degli indirizzi di massima<br />
per le politiche economiche e dei processi di Lussemburgo, Cardiff e Colonia) veniva dunque posta<br />
di fronte a questa nuova sfida: allargare la base lavorativa, compresa quella in età più avanzata, in<br />
misura sufficiente a impedire il collasso dei sistemi previdenziali, che, in ogni caso, avrebbero dovuto<br />
comunque essere rivisti in rapporto ai risultati conseguiti dalla strategia di Lisbona. A questo<br />
scopo il Consiglio europeo dava particolare risalto al processo di Cardiff ossia dell’innovazione,<br />
con contenuti, che, tuttora, mantengono un sapore “futuribile” di sconvolgente attualità. La riunione