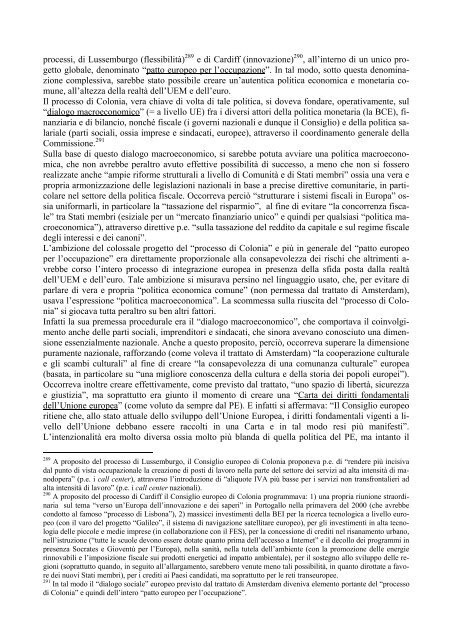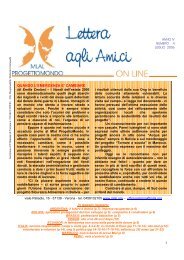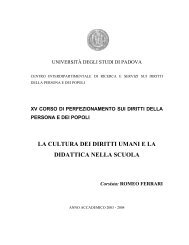cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"
cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"
cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
processi, di Lussemburgo (flessibilità) 289 e di Cardiff (innovazione) 290 , all’interno di un unico progetto<br />
globale, denominato “patto europeo per l’occupazione”. In tal modo, sotto questa denominazione<br />
complessiva, sarebbe stato possibile creare un’autentica politica economica e monetaria comune,<br />
all’altezza della realtà dell’UEM e dell’euro.<br />
Il processo di Colonia, vera chiave di volta di tale politica, si doveva fondare, operativamente, sul<br />
“dialogo macroeconomico” (= a livello UE) fra i diversi attori della politica monetaria (la BCE), finanziaria<br />
e di bilancio, nonché fiscale (i governi nazionali e dunque il Consiglio) e della politica salariale<br />
(parti sociali, ossia imprese e sindacati, europee), attraverso il coordinamento generale della<br />
Commissione. 291<br />
Sulla base di questo dialogo macroeconomico, si sarebbe potuta avviare una politica macroeconomica,<br />
che non avrebbe peraltro avuto effettive possibilità di successo, a meno che non si fossero<br />
realizzate anche “ampie riforme strutturali a livello di Comunità e di Stati membri” ossia una vera e<br />
propria armonizzazione delle legislazioni nazionali in base a precise direttive comunitarie, in particolare<br />
nel settore della politica fiscale. Occorreva perciò “strutturare i sistemi fiscali in Europa” ossia<br />
uniformarli, in particolare la “tassazione del risparmio”, al fine di evitare “la concorrenza fiscale”<br />
tra Stati membri (esiziale per un “mercato finanziario unico” e quindi per qualsiasi “politica macroeconomica”),<br />
attraverso direttive p.e. “sulla tassazione del reddito da capitale e sul regime fiscale<br />
degli interessi e dei canoni”.<br />
L’ambizione del colossale progetto del “processo di Colonia” e più in generale del “patto europeo<br />
per l’occupazione” era direttamente proporzionale alla consapevolezza dei rischi che altrimenti avrebbe<br />
corso l’intero processo di integrazione europea in presenza della sfida posta dalla realtà<br />
dell’UEM e dell’euro. Tale ambizione si misurava persino nel linguaggio usato, che, per evitare di<br />
parlare di vera e propria “politica economica comune” (non permessa dal trattato di Amsterdam),<br />
usava l’espressione “politica macroeconomica”. La scommessa sulla riuscita del “processo di Colonia”<br />
si giocava tutta peraltro su ben altri fattori.<br />
Infatti la sua premessa procedurale era il “dialogo macroeconomico”, che comportava il coinvolgimento<br />
anche delle parti sociali, imprenditori e sindacati, che sinora avevano conosciuto una dimensione<br />
essenzialmente nazionale. Anche a questo proposito, perciò, occorreva superare la dimensione<br />
puramente nazionale, rafforzando (come voleva il trattato di Amsterdam) “la cooperazione culturale<br />
e gli scambi culturali” al fine di creare “la consapevolezza di una comunanza culturale” europea<br />
(basata, in particolare su “una migliore conoscenza della cultura e della storia dei popoli europei”).<br />
Occorreva inoltre creare effettivamente, come previsto dal trattato, “uno spazio di libertà, sicurezza<br />
e giustizia”, ma soprattutto era giunto il momento di creare una “Carta dei <strong>diritti</strong> fondamentali<br />
dell’Unione europea” (come voluto da sempre dal PE). E infatti si affermava: “Il Consiglio europeo<br />
ritiene che, allo stato attuale dello sviluppo dell’Unione Europea, i <strong>diritti</strong> fondamentali vigenti a livello<br />
dell’Unione debbano essere raccolti in una Carta e in tal modo resi più manifesti”.<br />
L’intenzionalità era molto diversa ossia molto più blanda di quella politica del PE, ma intanto il<br />
289 A proposito del processo di Lussemburgo, il Consiglio europeo di Colonia proponeva p.e. di “rendere più incisiva<br />
dal punto di vista occupazionale la creazione di posti di lavoro nella parte del settore dei servizi ad alta intensità di manodopera”<br />
(p.e. i call center), attraverso l’introduzione di “aliquote IVA più basse per i servizi non transfrontalieri ad<br />
alta intensità di lavoro” (p.e. i call center nazionali).<br />
290 A proposito del processo di Cardiff il Consiglio europeo di Colonia programmava: 1) una propria riunione straordinaria<br />
sul tema “verso un’Europa dell’innovazione e dei saperi” in Portogallo nella primavera del 2000 (che avrebbe<br />
condotto al famoso “processo di Lisbona”), 2) massicci investimenti della BEI per la ricerca tecnologica a livello europeo<br />
(con il varo del progetto “Galileo”, il sistema di navigazione satellitare europeo), per gli investimenti in alta tecnologia<br />
delle piccole e medie imprese (in collaborazione con il FES), per la concessione di crediti nel risanamento urbano,<br />
nell’istruzione (“tutte le scuole devono essere dotate quanto prima dell’accesso a Internet” e il decollo dei programmi in<br />
presenza Socrates e Gioventù per l’Europa), nella sanità, nella tutela dell’ambiente (con la promozione delle energie<br />
rinnovabili e l’imposizione fiscale sui prodotti energetici ad impatto ambientale), per il sostegno allo sviluppo delle regioni<br />
(soprattutto quando, in seguito all’allargamento, sarebbero venute meno tali possibilità, in quanto dirottate a favore<br />
dei nuovi Stati membri), per i crediti ai Paesi candidati, ma soprattutto per le reti transeuropee.<br />
291 In tal modo il “dialogo sociale” europeo previsto dal trattato di Amsterdam diveniva elemento portante del “processo<br />
di Colonia” e quindi dell’intero “patto europeo per l’occupazione”.