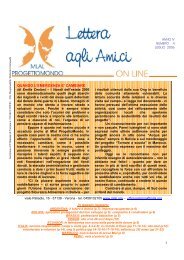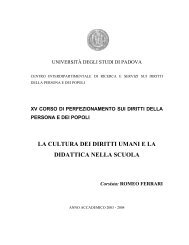cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"
cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"
cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
problema: 1) di stabilire una necessaria politica economica comune attraverso l’unico mezzo concesso<br />
dai trattati ovvero il semplice coordinamento delle politiche economiche nazionali, comprensivo<br />
anche di quelle degli Stati membri “senza” euro, data l’esistenza non solo di un unico quadro di<br />
riferimento comunitario, ma soprattutto di un mercato unico per tutta l’UE; 2) di stabilire una rappresentanza<br />
esterna della Comunità in rapporto all’euro (p.e. al G7, al Fondo monetario internazionale<br />
(FMI), di fronte ai Paesi terzi), in presenza non solo di una divisione della CE tra Stati con e<br />
senza euro, ma anche di una perdurante struttura “a pilastri” dell’UE, che vedeva la CE separata<br />
dalla PESC. E la pur autonoma BCE non poteva far da surrogato di un’unitaria autorità politica assente<br />
persino rispetto a terzi, pena la degenerazione del sistema. Proprio quest’ultimo problema,<br />
fonte di non pochi imbarazzi per tutti sulla scena internazionale, farà sentire, nel modo più scottante,<br />
la necessità di un rapido superamento della struttura a pilastri dell’UE nel senso della loro riduzione<br />
al primo pilastro comunitario. Tuttavia il problema delle due “deroghe” concesse alla Danimarca<br />
e al Regno Unito non sarà invece risolvibile, minacciando di compromettere l’efficacia per la<br />
zona euro di un coordinamento di politiche economiche condizionate da differenti valute e persino<br />
di offrire motivi di ripensamento sull’euro per altri Stati membri, presenti (la Svezia) e futuri (p.e. la<br />
Polonia), nonostante il loro obbligo di adottarlo.<br />
Il lancio ufficiale dell’euro, tuttavia, era di per sé un grande motivo di soddisfazione e di entusiasmo<br />
per l’UE. Tale entusiasmo fu tuttavia turbato, pochi mesi dopo, dall’esito negativo di una vicenda<br />
che, se da un lato gettò una macchia sulla Commissione europea, dall’altro lato diede occasione al<br />
PE di far valere sino alle ultime conseguenze il proprio potere di controllo su di essa.<br />
La stessa nuova moneta dell’Unione, l’euro, dipendeva, quanto alla sua affidabilità, dalla presenza<br />
di finanze sane non solo negli Stati membri, ma anche nella stessa UE. Ciò significava che le spese<br />
dell’UE avrebbero dovuto essere sottoposte a un severo controllo anche per scongiurare versamenti<br />
“a vuoto”, causati dalle frodi ai danni dell’UE. Tali frodi peraltro potevano essere il risultato anche<br />
di una corruzione o persino di una concussione degli organi eroganti, e non solo di quelli degli Stati<br />
membri, bensì anche di quelli della stessa UE ovvero della stessa Commissione europea, non solo a<br />
livello di funzionari, bensì anche a livello politico ossia degli stessi membri della Commissione. E<br />
questo è ciò che era sembrato essere avvenuto.<br />
Sull’onda delle critiche sui metodi di gestione della Commissione Santer, il PE si era rifiutato già il<br />
17 dicembre 1998 di dare il “discarico di bilancio” ossia il proprio benestare all’esercizio di bilancio<br />
del 1996. La reazione del presidente Santer fu quella di chiedere lui stesso al PE il 12 gennaio<br />
1999 un voto di fiducia nei confronti della Commissione.<br />
La situazione, alquanto delicata, spingeva allora il PE ad accelerare i tempi per un pronunciamento<br />
di ordine generale sul tema dei rapporti Commissione-PE, sulla base delle implicazioni politiche<br />
delle nuove disposizioni specifiche del trattato di Amsterdam e in vista dell’avvento della nuova<br />
Commissione per il gennaio 2000. Tale pronunciamento del PE avveniva con l’adozione della<br />
risoluzione del 13 gennaio 1999 “sulle implicazioni istituzionali dell’approvazione da parte del Parlamento<br />
Europeo della designazione del presidente della Commissione e sull’indipendenza dei<br />
membri del collegio”. In essa il PE sottolineava come le nuove disposizioni del trattato di Amsterdam<br />
avevano le seguenti implicazioni:<br />
- il PE avrebbe conferito “alla Commissione un mandato fiduciario che dovrà essere il più possibile riempito di contenuti<br />
politico-programmatici”<br />
- il presidente della Commissione avrebbe assunto “l’importantissimo ruolo istituzionale di stabilire un programma corrispondente<br />
alla durata di un’intera legislatura del Parlamento Europeo” e perciò avrebbe dovuto avere “una maggiore<br />
capacità direttiva” nei confronti della Commissione<br />
nel CLN, dell’ideale di una patria riconciliata e indivisa nella libertà, nella democrazia, nella Repubblica e nella Costituzione<br />
e perciò orgogliosa del proprio tricolore e delle proprie forze armate, ma anche il sostenitore dell’identità europea,<br />
dell’Unione Europea e della Costituzione europea, e a partire da questa identità fautore del dialogo tra le civiltà. In<br />
tale sua nuova veste di capo dello Stato, per la sua personalità e per i grandi meriti acquisiti nei confronti dell’Italia e<br />
dell’Europa, Ciampi riceverà ad Aquisgrana il 5 maggio 2005 il “Premio Carlo Magno”, con la dedica personalizzata<br />
“Europa dei Valori”. Dal 15 maggio 2006 continua il suo servizio in qualità di senatore a vita.