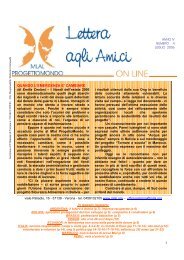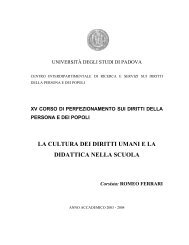cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"
cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"
cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
esito negativo, tale referendum avrebbe rappresentato la definitiva ratifica di un’Unione a carattere<br />
confederale e intergovernativo, ma, nel caso positivo, esso avrebbe costituito la definitiva investitura<br />
democratica di un’Unione politica di tipo federale (a prescindere dal numero degli Stati membri, i<br />
cui popoli avessero espresso effettivamente il loro consenso e che perciò avessero aderito effettivamente<br />
a tale nuova Unione).<br />
Solo in alternativa a tale referendum paneuropeo, il PE proponeva che le ratifiche, referendarie o<br />
parlamentari, nazionali si tenessero comunque nello stesso tempo, proprio per garantire una “campagna<br />
referendaria”, che, in quanto simultanea, avrebbe dovuto conoscere una sostanziale omogeneità<br />
in tutto il territorio dell’UE, impedendo improprie derive “nazionali” del dibattito pubblico e<br />
soprattutto eventuali influenze di un esito negativo di una consultazione referendaria nazionale nel<br />
dibattito pubblico ancora in corso in altri Stati membri. 195<br />
Inoltre il PE proponeva che, all’atto della presentazione del futuro trattato ai Parlamenti nazionali e<br />
allo stesso PE per la ratifica finale, il Consiglio trasmettesse loro “un testo unico consolidato dei<br />
trattati fondativi” (CECA, CEEA, CE e TUE, così come sarebbero risultati emendati dal futuro trattato).<br />
In tal modo i Parlamenti avrebbero avuto a disposizione, già prima del voto di ratifica finale<br />
del futuro trattato, un quadro unitario complessivo dei “trattati costitutivi” in tal modo emendati ossia<br />
una sorta di unico “trattato... costituzionale”! 196<br />
L’eccezionalità ovvero il carattere straordinario, unico e definitivo della procedura di ratifica proposta<br />
era confermato infine dal fatto che il PE suggeriva di inserire nel futuro trattato una norma, in<br />
base alla quale le “future revisioni” di esso dovessero essere “approvate congiuntamente dal Parlamento<br />
e dal Consiglio prima di essere sottoposte ai Parlamenti nazionali per la ratifica”. In tal modo<br />
il PE prefigurava per le successive revisioni del trattato il normale iter di una sorta di “legge di revisione<br />
costituzionale” a carico delle due istituzioni legislative dell’UE, sopprimendo con ciò il ricorso<br />
a un’ennesima CIG e anzi a un ennesimo trattato fra i governi degli Stati membri e mantenendo<br />
solo il principio della ratifica finale di tale sorta di “legge costituzionale” da parte dei Parlamenti<br />
nazionali. Una tale misura avrebbe con ciò significato l’avvio di un sistema procedurale di “revisione<br />
costituzionale”, tipico di un’Unione politica a carattere federale.<br />
Recependo anche questa risoluzione del PE, il Gruppo di riflessione iniziava quindi i suoi lavori il 2<br />
giugno 1995 a Messina, esattamente quarant’anni dopo la conferenza, svoltasi nella stessa città italiana,<br />
che aveva condotto alla stesura dei trattati di Roma.<br />
Mentre erano in corso i lavori del Gruppo di riflessione, ebbe nel frattempo luogo la riunione del<br />
Consiglio europeo di Cannes del 26-27 giugno 1995, che affrontava, fra l’altro, il tema della “preparazione<br />
alla Conferenza intergovernativa del 1996”. A questo proposito il Consiglio di Cannes affermava:<br />
“Alla luce degli insegnamenti che si possono trarre dopo più d'un anno e mezzo dall'entrata in vigore del trattato sull'Unione<br />
europea e tenuto conto delle sfide e delle opportunità connesse in particolare con la prospettiva di un nuovo allargamento,<br />
il Consiglio europeo giudica inoltre che la riflessione debba concentrarsi su alcune priorità, affinché l'Unione<br />
possa rispondere alle aspettative dei suoi cittadini:<br />
195 Dieci anni dopo questi timori e queste precauzioni del PE si riveleranno quanto mai fondati di fronte agli esiti negativi<br />
dei due referendum nazionali, francese e olandese, del 2005 sul TCE e alla sostanziale paralisi del processo di ratifica<br />
di esso che ne sarebbe seguita per i due anni successivi (con l’incredibile blocco della procedura di ratifica in 7 Stati<br />
membri su 25), in presenza del perdurante principio della ratifica del trattato da parte di tutti gli Stati membri (regola<br />
dell’unanimità) e del perdurante rifiuto di un “referendum paneuropeo” su di esso. In tal modo si è innescata la crisi forse<br />
più grave della storia del processo d’integrazione europea, che persino l’eventuale varo di un nuovo trattato (la cui<br />
ratifica poggi sulle medesime regole) non è affatto certo possa risolvere.<br />
196 Risale a questo pronunciamento del PE l’idea di associare al varo di un trattato volto a unificare tutte le politiche<br />
dell’Unione un testo unico dei trattati fondativi. Tale idea avrebbe condotto otto anni dopo alla stesura di un “trattato<br />
costituzionale”, riassorbente in se stesso tutti i trattati fondativi allora esistenti (eccetto quello CEEA). La differenza di<br />
questo esito rispetto all’idea originaria sta nel fatto che quest’ultima si limitava a proporre un semplice strumento di lavoro<br />
(il “testo unico”) per il legislatore ossia per i Parlamenti nazionali ed europeo e non già un “trattato costituzionale”,<br />
che, per l’enorme mole in tal modo acquisita, sarebbe riuscito assolutamente “indigeribile” per i suoi naturali destinatari<br />
ossia per i cittadini dell’Unione.