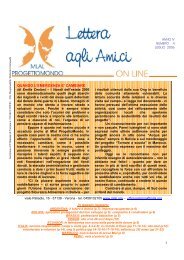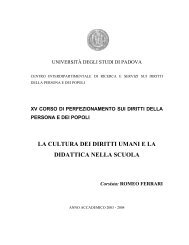cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"
cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"
cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
E finalmente l’Unione Europea perveniva al presente primo decennio del XXI secolo. Il primo suo<br />
atto fu l’adozione da parte del PE della risoluzione del 3 febbraio 2000 “sulla convocazione della<br />
Conferenza intergovernativa” (relatori; Giorgios Dimitrakopoulos e Jo Leinen). Essa affermava<br />
molto semplicemente, ancora una volta in pieno accordo con la Commissione, che le conclusioni<br />
del Consiglio europeo di Helsinki non avevano tenuto conto delle proposte del PE e anzi l’ordine<br />
del giorno definito a Helsinki per la CIG non rispettava nemmeno lo stesso protocollo (del trattato)<br />
di Amsterdam sulle riforme da adottare in vista dell’allargamento (tanto più in quanto esteso a ben<br />
13 Paesi a partire dalla fine del 2000), mettendolo così a rischio. Infine si augurava che la presidenza<br />
portoghese della CIG recepisse comunque le istanze del PE.<br />
In tale clima di ”euforia” dell’UE per l’imminente allargamento e di forte preoccupazione del PE<br />
per le prospettive della riforma istituzionale si apriva poi, il 14 febbraio 2000, la Conferenza intergovernativa<br />
sulle riforme istituzionali in vista dell’allargamento.<br />
Alla vigilia della riunione di primavera del Consiglio europeo, il PE interveniva allora sulle sue ancor<br />
più ambiziose prospettive “costituzionali” con la risoluzione del 16 marzo 2000<br />
“sull’elaborazione di una Carta dei <strong>diritti</strong> fondamentali dell’Unione Europea” (relatori: Andrew<br />
Duff e Johannes Voggenhuber). 306<br />
Collegando l’elaborazione in corso della Carta da parte della Convenzione con i temi apparentemente<br />
irrelati della CIG e dello stesso allargamento dell’UE e riassumendo una volta per tutte la valenza<br />
costituzionale per eccellenza della Carta, la risoluzione faceva presente alla Convenzione i requisiti<br />
a cui doveva soddisfare tale documento:<br />
- “che la Carta sia dotata di carattere giuridicamente vincolante mediante il suo inserimento nel trattato<br />
sull’Unione Europea”;<br />
- “che la Carta includa <strong>diritti</strong> fondamentali quali il diritto di associazione in sindacato e il diritto di sciopero”;<br />
- “che la Carta riconosca l’indivisibilità dei <strong>diritti</strong> fondamentali, estendendo il suo campo di applicazione a tutte le istituzioni<br />
e a tutti gli organi dell’Unione Europea, nonché a tutte le sue politiche, comprese quelle che rientrano nel secondo<br />
e terzo pilastro […]”;<br />
- “che la Carta sia vincolante per gli Stati membri quando attuano o recepiscono disposizioni di diritto comunitario”;<br />
- “che la Carta sia dotata di carattere innovativo, concedendo alle persone presenti nell’Unione Europea una protezione<br />
giuridica anche nei confronti di nuove minacce ai <strong>diritti</strong> fondamentali, come ad esempio nel settore delle tecnologie<br />
dell’informazione e delle biotecnologie e confermi come parte integrante dei <strong>diritti</strong> fondamentali soprattutto i <strong>diritti</strong> della<br />
donna, la clausola generale di non discriminazione e la protezione dell’ambiente”<br />
La risoluzione esigeva altresì “un’ampia discussione sociale negli Stati membri che coinvolga le<br />
parti sociali, le ONG ed altri rappresentanti della società civile”. Auspicava anzi “il riconoscimento<br />
del contributo che possono fornire le organizzazioni della società civile al processo di elaborazione<br />
della Carta”.<br />
Infine la risoluzione coinvolgeva la stessa CIG, che stava discutendo la riforma istituzionale, a:<br />
- “iscrivere nel suo ordine del giorno l’inclusione nel trattato della Carta dei <strong>diritti</strong> fondamentali e ad accordarle il<br />
ruolo che le spetta, vista la sua straordinaria importanza per la realizzazione di un’Unione sempre più stretta tra i popoli<br />
dell’Europa”;<br />
- “consentire all’Unione di aderire alla Convenzione europea per i <strong>diritti</strong> dell’uomo al fine di assicurare una stretta<br />
cooperazione con il Consiglio d’Europa […]”;<br />
- “garantire a tutte le persone che godono della protezione della Carta l’accesso alla Corte di giustizia delle Comunità<br />
europee, ampliando così i meccanismi esistenti di revisione giudiziaria”.<br />
Con tale risoluzione il PE riassumeva proposte maturate in decenni di elaborazione costituzionale<br />
europea, presentandole peraltro in forma semplice, sintetica e al momento giusto. Da allora in poi<br />
di). Elena Paciotti, unico membro italiano del PE, era stata magistrato sino alla Corte di cassazione, membro del CSM e<br />
presidente dell’Associazione nazionale magistrati; lascerà il PE nel 2004.<br />
306 Andrew Duff è dal 1999 membro britannico del PE (nel gruppo dell’ALDE). Johannes Voggenhuber è dal 1999<br />
membro austriaco del PE (nel gruppo dei Verdi), nonché dal 1999 vicepresidente della Commissione “Affari costituzionali”.