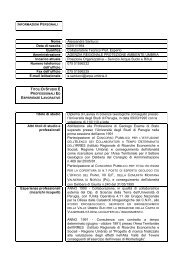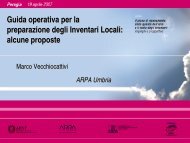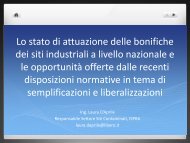Tutela ambientale del Lago Trasimeno - ARPA Umbria
Tutela ambientale del Lago Trasimeno - ARPA Umbria
Tutela ambientale del Lago Trasimeno - ARPA Umbria
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
1 . S t a t o d e l l e c o n o s c e n z e<br />
2 9<br />
sono essere eccellenti e che ogni ulteriore<br />
apporto di inquinanti potrebbe<br />
compromettere le condizioni generali<br />
<strong>del</strong> lago.<br />
Dopo il convegno <strong>del</strong> 1969, l’attenzione<br />
<strong>del</strong>l’opinione pubblica rimane<br />
alta, tanto che nel 1972, nel Convegno<br />
Iniziative per la difesa <strong>del</strong>l’ambiente in <strong>Umbria</strong>,<br />
Perugia 29 ottobre, organizzato dall’Associazione<br />
Italiana per l’Igiene e la Sanità<br />
Pubblica - Sezione <strong>Umbria</strong> e dalle<br />
Amministrazioni Provinciali di Perugia<br />
e Terni (Regione <strong>Umbria</strong>, 1973), c’è un<br />
significativo intervento sul lago (Tiberi<br />
et al.1973), frutto di uno studio effettuato<br />
nei 3 anni precedenti e promosso dall’<br />
Università e LESP, essenzialmente sullo<br />
stato chimico <strong>del</strong>le acque e sugli impatti<br />
generati dalle attività nel bacino.<br />
Lo studio afferma che, nonostante<br />
qualche problema, le acque <strong>del</strong> lago<br />
siano da considerarsi in stato accettabile<br />
adottando un indice globale di inquinamento<br />
<strong>del</strong>l’epoca, basato su pH, ossigeno<br />
disciolto, domanda di ossigeno, specie<br />
azotate, detergenti, olii e grassi.<br />
Un intervento <strong>del</strong> professor Gianotti,<br />
Direttore <strong>del</strong>l’Istituto di Idrobiologia<br />
e Pescicoltura <strong>del</strong>l’Università di Perugia,<br />
traccia un quadro <strong>del</strong> sistema lago<br />
da un punto di vista ecosistemico, che,<br />
seppur parziale e personale, è degno di<br />
essere riproposto nelle sue parti significative<br />
per i tanti elementi citati, dal<br />
titolo Cronistoria trasimenica: passato presente e<br />
futuro (Regione <strong>Umbria</strong>, 1973).<br />
L’intervento, a ricordo <strong>del</strong>le vicissitudini<br />
degli anni ’50 e <strong>del</strong>l’ampliamento<br />
<strong>del</strong> bacino imbrifero, esordisce così:<br />
“La recente storia <strong>del</strong> lago <strong>Trasimeno</strong> emerge<br />
dalle registrazioni <strong>del</strong>le fluttuazioni <strong>del</strong> livelli<br />
idrici. Ad esse sono associate, infatti, le variazioni<br />
fisico-chimiche <strong>del</strong>le acque ed i cambiamenti <strong>del</strong>le<br />
biocenosi.<br />
Alla data 30 settembre 1958 le acque sono a<br />
quota 254,53 m.s.l.m., la più bassa raggiunta dal<br />
lago; al primo gennaio 1960 aumenta di 69 cm.<br />
Nel quadriennio 1960-63 il livello si innalza di<br />
m.1,92. Nel periodo 1964-67 il livello non scende<br />
mai più di cm.40 al di sotto <strong>del</strong>la quota di sfioro<br />
<strong>del</strong>l’emissario artificiale (257,33 m.s.l.m.) […] al<br />
31 dicembre 1971 la quota <strong>del</strong>le acque è 256,78,<br />
come dire 55 cm. al di sotto <strong>del</strong> livello di sfioro …”.<br />
Dai livelli passa poi ad analizzare gli<br />
aspetti vegetazionali e ittici correlati:<br />
“...L’estensione e la densità <strong>del</strong>l’insediamento<br />
macrofitico nel <strong>Trasimeno</strong> seguono le fluttuazioni<br />
<strong>del</strong> livello idrico: si abbassano le acque, aumenta il<br />
popolamento macrofitico.<br />
Il <strong>Trasimeno</strong>, ridotto a 3-4 metri di profondità<br />
massima (NDA: anni ’50), subisce uno dei fenomeni<br />
più temuti per gli stagni artificiali di pescicoltura:<br />
l’eccessivo sviluppo <strong>del</strong>le piante acquatiche,<br />
oltre i limiti considerati ancora tollerabili … negli<br />
stagni artificiali: 10-20% per i vegetali galleggianti<br />
e 30-50% per i vegetali sommersi.<br />
Un popolamento vegetale equilibrato reca notevoli<br />
vantaggi al biotopo in cui è insediato: produce<br />
ossigeno ed aumenta l’autodepurazione <strong>del</strong>l’ambiente;<br />
sintetizza sostanze organiche utilizzando le<br />
inorganiche e può opporsi all’inquinamento <strong>del</strong>le<br />
acque; rappresenta habitat ottimale per moltissimi<br />
esseri viventi e rifugio per l’ittiofauna allo stadio<br />
giovanile; costituisce pabulum ai pesci e ad altri<br />
organismi animali, serve a molte specie ittiche per la<br />
deposizione <strong>del</strong>le uova.<br />
È noto che, a parità di superficie, i laghi poco<br />
profondi sono spesso più produttivi anche dal punto<br />
di vista ittico.<br />
Quando l’invasione idrofitica è massiccia e<br />
rapida, quando interi settori non consentono la<br />
navigazione neppure a remi, neppure alle barche<br />
a fondo piatto ed impediscono di impostare l’attrezzatura<br />
di pesca, quando i fenomeni putrefattivi<br />
diventano abnormemente imponenti, quando si ha<br />
estremo impoverimento <strong>del</strong> tasso di ossigeno disciolto<br />
con settori perennemente asfittici, quando i fanghi<br />
di fondo sono neri per solfuri, quando la temperatura<br />
<strong>del</strong>l’acqua a tutti i livelli segue rapidamente<br />
lo stesso livello di quella <strong>del</strong>l’aria, non si può parlare<br />
di lago eutrofo, ma di impaludimento.<br />
Evidentissimi sono i fenomeni di viraggio alla<br />
facies palustre anche nella fauna e nella flora: fioriture<br />
imponenti di Microcystis aeruginosa, Apha-