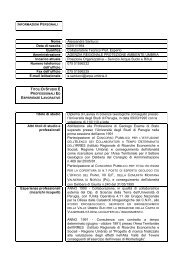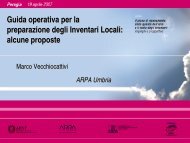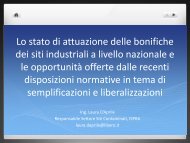Tutela ambientale del Lago Trasimeno - ARPA Umbria
Tutela ambientale del Lago Trasimeno - ARPA Umbria
Tutela ambientale del Lago Trasimeno - ARPA Umbria
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
6 0 A r p a U m b r i a 2 0 1 2<br />
nose per la pesca. In effetti il fenomeno<br />
sembrava aver avuto una ricaduta positiva<br />
sull’andamento <strong>del</strong>le attività di pesca<br />
invernali.<br />
Qualche anno più tardi, nella ricerca<br />
di Taticchi (1963-65), prevalentemente<br />
rivolta a studi specifici sulle comunità<br />
zooplanctoniche e bentoniche, venivano<br />
evidenziati gli effetti tardivi <strong>del</strong>l’adduzione<br />
al lago dei torrenti <strong>del</strong>la Valdichiana<br />
sulla vegetazione macrofitica<br />
<strong>del</strong>la zona litoranea; l’allargamento <strong>del</strong><br />
perimetro lacustre aveva provocato una<br />
progressiva e massiccia colonizzazione<br />
da parte <strong>del</strong>l’hydrophyton (canneto, tifeto,<br />
giuncheto, lamineto, potamogetoneto,<br />
ceratofilleto) <strong>del</strong>le aree rivierasche da<br />
poco sommerse dalle acque apportate.<br />
A partire dal 1965 alcuni degli studi<br />
presi in esame sulla vegetazione idrofitica<br />
hanno focalizzato l’attenzione su censimenti<br />
di specie e fitocenosi, assumendo<br />
un carattere prettamente botanico.<br />
In primis, Granetti (1965) si era<br />
proposto di fotografare lo stato <strong>del</strong>la<br />
vegetazione lacustre e di ricostruire un<br />
quadro sintetico sulle trasformazioni a<br />
cui la flora acquatica era andata incontro<br />
nell’arco di 80 anni. L’autore ha messo<br />
in evidenza come le modificazioni <strong>del</strong>la<br />
vegetazione idrofitica <strong>del</strong> <strong>Trasimeno</strong><br />
fossero fortemente legate alle vicende<br />
idrologiche a cui era andato incontro<br />
il lago dal 1898 al 1964 (anno in cui il<br />
livello <strong>del</strong> lago raggiunse nuovamente<br />
lo sfioratore dopo 40 anni di magra).<br />
L’autore individuava nelle ricorrenti<br />
modificazioni <strong>del</strong>l’estensione <strong>del</strong>lo<br />
specchio lacustre e <strong>del</strong> suo spessore la<br />
causa principale <strong>del</strong>le continue alterazioni<br />
degli habitat. Al momento <strong>del</strong>l’indagine,<br />
in seguito all’aumento di livello<br />
<strong>del</strong>le acque, la vegetazione elofitica<br />
continuava ad espandersi verso le aree<br />
coltivate; la vegetazione idrofitica, invece,<br />
dopo una massiccia espansione negli<br />
anni 1941-1959 fin nella zona pelagica<br />
(periodo siccitoso), era andata incontro<br />
ad un notevole ridimensionamento.<br />
L’autore segnalava l’assenza di circa 30<br />
specie rispetto a quanto osservato da Cicioni<br />
nei rilievi effettuati alla fine <strong>del</strong>l’Ottocento<br />
e da Barsali all’inizio <strong>del</strong> Novecento<br />
(Nuphar luteum, Caltha palustris, Hyppuris vulgaris,<br />
Potamogeton graminea, Sagittaria sagittaefolia,<br />
Zannichellia palustris, Helodea canadensis ecc.).<br />
Veniva, inoltre, evidenziato come altre<br />
specie fossero divenute sempre più rare e<br />
a rischio di estinzione, come Nymphaea alba,<br />
alcune specie di Ranunculus, ecc.<br />
Un altro lavoro importante, finalizzato<br />
a valutare i cambiamenti <strong>del</strong>la<br />
comunità macrofitica <strong>del</strong> <strong>Trasimeno</strong>,<br />
è stato effettuato da Orsomando e<br />
Catorci con la “Carta <strong>del</strong>la Vegetazione<br />
<strong>del</strong> Comprensorio <strong>Trasimeno</strong>” redatta<br />
nel 1991. Per ogni associazione vegetale<br />
veniva fornito un quadro sullo stato<br />
di conservazione, diffusione, composizione<br />
floristica ed eventuali variazioni<br />
subite rispetto agli anni precedenti. Nel<br />
lavoro è stato messo in evidenza come il<br />
progressivo aumento <strong>del</strong>l’impatto antropico<br />
avesse ridotto consistentemente le<br />
aree occupate dalla vegetazione umida<br />
e palustre, rispetto a quanto descritto<br />
nei lavori di Cicioni (1895) e Granetti<br />
(1965). In particolare, la regressione<br />
<strong>del</strong>la vegetazione macrofitica, accompagnata,<br />
spesso, da una semplificazione<br />
<strong>del</strong>le fitocenosi e perdita di biodiversità,<br />
veniva sottolineata per le associazioni<br />
Mentho aquaticae-Caricetum pseudocyperi,<br />
Hydrocharitetum e Riccietum fluitans.<br />
Numerosi erano i fenomeni di<br />
degrado riscontrati: forte squilibrio tra<br />
le aree antropizzate e naturali o seminaturali,<br />
alterazione <strong>del</strong>le zone planiziarie<br />
con riduzione dei boschi e brughiere a<br />
calluna, pratiche silvo-colturali, distruzione<br />
<strong>del</strong>la vegetazione ripariale, apertura<br />
cave, abbandono dei castagneti, estinzione<br />
di specie rare ed introduzione di<br />
specie esotiche attorno al lago ecc.