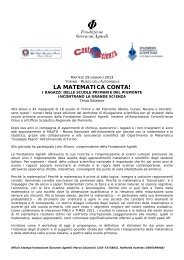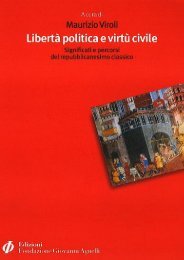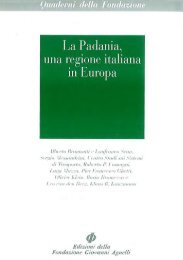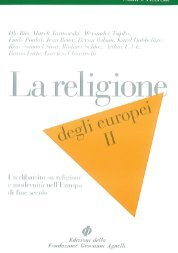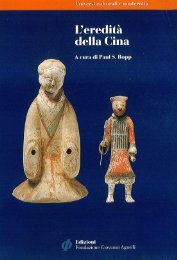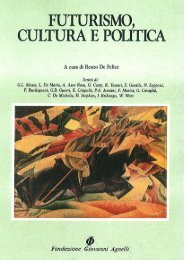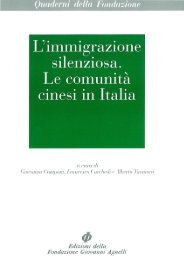- Page 2:
Quaderni della Fondazione Studi e r
- Page 5:
L’immagine dell’Europa nei manu
- Page 8 and 9:
L’Europa nell’insegnamento dell
- Page 10 and 11:
4. I manuali di geografia e la comu
- Page 12 and 13:
volta, Illuminismo e Rivoluzione fr
- Page 15 and 16:
L’Europa nei manuali scolastici:
- Page 17 and 18:
delle istituzioni fanno sempre più
- Page 19 and 20:
Già questi esempi mostrano che tra
- Page 21 and 22:
limita fortemente il valore pratico
- Page 23 and 24:
grammi ministeriali con precise ind
- Page 25 and 26:
so evolutivo nazionale e uno genera
- Page 27 and 28:
chitettoniche o artistiche illustra
- Page 29 and 30:
zione una parte considerevole della
- Page 31 and 32:
iprodotta in un manuale, non è loc
- Page 33 and 34:
opa fino alla seconda guerra mondia
- Page 35 and 36:
di Caocci sono molto più distaccat
- Page 37 and 38:
Cosi ad esempio le crescenti tenden
- Page 39 and 40:
Duroselle, J.-B., L’Europe: histo
- Page 41 and 42:
L’Europa in alcuni manuali scolas
- Page 43 and 44:
L’analisi della rappresentazione
- Page 45 and 46:
Se l’Europa propriamente storica
- Page 47 and 48:
damentali nel loro insieme non tant
- Page 49 and 50:
sati. Di certo è da decidere se al
- Page 51 and 52:
dove si richiama l’attenzione all
- Page 53 and 54:
ca» (Görlitz e Immisch, vol. IV,
- Page 55 and 56:
vorevole. Già ora, afferma il manu
- Page 57 and 58:
Tabella 1. Nuclei tematici in relaz
- Page 59 and 60:
fici, soprattutto nella scelta dell
- Page 61 and 62:
l’epoca attuale, e come vi siano
- Page 63 and 64:
cento sulle strutture interne di qu
- Page 65 and 66:
strategia di Ignazio di Loyola e de
- Page 67 and 68:
digene. Con ciò si presuppone un
- Page 69 and 70:
come precisa il manuale, il comunis
- Page 71 and 72:
1919: una pace persa?». Le rispost
- Page 73 and 74:
durre tutta una serie di informazio
- Page 75:
Soltanto Geschichtsbuch concede sca
- Page 78 and 79:
Si ha l’impressione che nel manua
- Page 80 and 81:
partiene il «Nuovo Mondo»? in Tem
- Page 82 and 83:
come confronto tra cultura europea
- Page 84 and 85:
via all’Europa il ruolo di «terz
- Page 86 and 87:
schichte in vier Bänden (Zuber e H
- Page 88 and 89:
È stata una festa indimenticabile.
- Page 90 and 91:
ture revisioni di contenuto è asso
- Page 92 and 93:
di progetti politici riconosciuti c
- Page 94 and 95:
1 In Germania soltanto a partire da
- Page 96 and 97:
sischen Revolution bis zum Ersten W
- Page 98 and 99:
veda p. 220 e segg.) e il desiderio
- Page 100 and 101:
L’Europa e il mondo 5. Alla richi
- Page 102 and 103:
discorso che le potenze occidentali
- Page 104 and 105:
Analisi formale sui libri di testo
- Page 107 and 108:
Geschichte in vier Bänden - Volume
- Page 110 and 111:
La contrapposizione tra Est e Ovest
- Page 112 and 113:
10. Numero di pagine e quote in per
- Page 114 and 115:
Carlo IV, re della pace 106-12 (7)
- Page 116 and 117:
Geschichtsbuch. Die Menschen und ih
- Page 118 and 119:
La Svizzera: tre lingue, due confes
- Page 120 and 121:
Armamento militare e crisi politica
- Page 122 and 123:
Unsere Geschichte Volume I Volume I
- Page 124 and 125:
Democrazia e stato nazionale: svilu
- Page 126 and 127:
Va. % 13.a) 51 38 13.b) 8 6 13.c) 2
- Page 128 and 129:
tura interna dei capitoli spesso co
- Page 130 and 131:
La sovranità di Carlo Magno L’or
- Page 133 and 134:
L’Europa nell’insegnamento dell
- Page 135 and 136:
quinta e la nona della scuola eleme
- Page 137 and 138:
et al.), Politik im Aufriss, vol. I
- Page 139 and 140:
punti: nel paragrafo Verso la pace
- Page 141 and 142:
verso rapporto fra testo degli auto
- Page 143 and 144:
― «Le donne in Europa», per la
- Page 145 and 146:
un glossario per alcuni termini. I
- Page 147 and 148:
derale per l’istruzione politica
- Page 149 and 150:
verse in un tutto superiore. In pol
- Page 151 and 152:
Questa è l’immagine dell’Europ
- Page 153 and 154:
3. Speranza Europa Come vedono i gi
- Page 155 and 156:
mercato interno comune. Entro quest
- Page 157 and 158:
L’Europa nei manuali scolastici d
- Page 159 and 160:
in questo periodo cosi importante p
- Page 161 and 162:
quota del 17,2 per cento (si vedano
- Page 163 and 164:
Raum). Tali discrepanze richiedono
- Page 165 and 166:
tazione monografica non può mai es
- Page 167 and 168:
deve essere affiancato dall’atlan
- Page 169 and 170:
Certamente va constatato che i test
- Page 171 and 172:
delle opere più recenti fra quelle
- Page 173 and 174:
Solamente la Baviera mediante la su
- Page 175 and 176:
― Seydlitz Mensch und Raum, Hanno
- Page 177 and 178:
Analisi formale sui libri di testo
- Page 179 and 180:
Terra Erdkunde Volume V Volume Volu
- Page 181 and 182:
Erdkunde für Gymnasien in Bayern V
- Page 183 and 184:
Terra Erdkunde für Gymnasien in No
- Page 185 and 186:
La rappresentazione dell’Europa i
- Page 187 and 188:
le. Non vi sarebbe nulla da obietta
- Page 189 and 190:
dell’Europa Infine è introdotto
- Page 191 and 192:
Ci si potrebbe pure domandare che c
- Page 193 and 194:
degli stati cattolici, fenomeno che
- Page 195 and 196:
Si ripropone evidentemente l’inte
- Page 197 and 198:
la costituzione interna non possono
- Page 199 and 200:
1) I libri di storia devono combina
- Page 201 and 202:
Appendice Gli esempi qui riportati
- Page 203 and 204:
Il testo è accompagnato da illustr
- Page 205 and 206:
Analisi formale sui libri di testo
- Page 207 and 208:
traria di pagine illustrate. Bisogn
- Page 209 and 210:
Verso i tempi moderni 20.La crisi d
- Page 211 and 212:
Magnard, Histoire Géographie Volum
- Page 213 and 214:
3. Il regno dei franchi Scontri di
- Page 215 and 216:
essunoN 201
- Page 217 and 218:
quindi probabile che anche nei libr
- Page 219 and 220:
205
- Page 221 and 222:
L’Europa in alcuni manuali scolas
- Page 223 and 224:
collèges, un esame che è composto
- Page 225 and 226:
ne, si incontrano alcuni limiti: me
- Page 227 and 228:
come uno stato federale dell’Euro
- Page 229 and 230:
Soltanto nel volume di Hatier (Mart
- Page 231 and 232:
lo svolgimento di alcuni esercizi c
- Page 233 and 234:
Analisi formale sui libri di testo
- Page 235 and 236:
― l’articolazione delle unità
- Page 237 and 238:
27. La Repubblica democratica d’U
- Page 239 and 240:
Ogni stato trattato è considerato
- Page 241 and 242:
Introduzione 292 1. La Repubblica d
- Page 243 and 244:
l’organizzazione e le istituzioni
- Page 245 and 246:
Hatier, Histoire-Géographie Volume
- Page 247 and 248:
L’immagine dell’Europa nei manu
- Page 249 and 250:
ni e nazionalità (le attuali comun
- Page 251 and 252:
l’uno nel molteplice, il moltepli
- Page 253 and 254:
sca utilizzare il concetto di Europ
- Page 255 and 256:
Per l’epoca contemporanea il proc
- Page 257 and 258:
in latino, che era anche la lingua
- Page 259 and 260:
nuali qui esaminati. La forma gener
- Page 261 and 262:
Riferimenti bibliografici Aa. Vv.,
- Page 263 and 264:
Anaya, Ciencias Sociales Volume I V
- Page 265 and 266:
Volume II Gli inizi del nuovo mondo
- Page 267 and 268:
10. numero di pagine e quote in per
- Page 269 and 270:
14. elencazione dei capitoli e para
- Page 271 and 272:
11. elencazione dei capitoli e para
- Page 273 and 274:
no un’eccezione dal momento che,
- Page 275 and 276:
La descrizione dell’Europa in alc
- Page 277 and 278:
tura del mondo iberico a influenze
- Page 279 and 280:
― La Spagna nel mondo: la comunit
- Page 281 and 282:
ca procede tenendo conto di fattori
- Page 283 and 284:
per la colonizzazione delle aree di
- Page 285 and 286:
particolare la storia delle esplora
- Page 287 and 288:
definitiva, si accenna alle consegu
- Page 289 and 290:
condo capitolo, dedicato all’indu
- Page 291 and 292:
La nascita dei regimi autoritari co
- Page 293 and 294:
si accordava con nessuno dei sistem
- Page 295 and 296:
feudale, ovvero come epoca di trans
- Page 297 and 298: parte i paesi scoperti, dall’altr
- Page 299 and 300: lo V divenendo un centro della poli
- Page 301 and 302: Contemporaneamente però vengono me
- Page 303 and 304: È ricordato il crausianismo, movim
- Page 305 and 306: esempio Belgio, Olanda e Italia). L
- Page 307 and 308: Il manuale caratterizza l’imperia
- Page 309 and 310: La figura di Franco non è soggetta
- Page 311 and 312: Questo manuale offre agli alunni un
- Page 313 and 314: (Geografía e Historia de España,
- Page 315 and 316: I due manuali di Geografía e Histo
- Page 317 and 318: 1 Miguel de Unamuno, caposcuola di
- Page 319 and 320: Appendice Vengono qui riportati alc
- Page 321 and 322: zione ovviamente dei sovrani. La tr
- Page 323 and 324: Analisi dei manuali per l’insegna
- Page 325 and 326: e. del 1991 esso è vincolante per
- Page 327 and 328: pertinente al contesto ed esporla i
- Page 329 and 330: cessario per il superamento degli e
- Page 331 and 332: siva viene dalla comunità economic
- Page 333 and 334: La presentazione separata di storie
- Page 335 and 336: Tabella 2. L’Europa dopo il 1945
- Page 337 and 338: iodo compreso tra le due guerre. Fr
- Page 339 and 340: escludono un peso specifico europeo
- Page 341 and 342: erts (1987 2 ) e Lowe (1988 2 ) sup
- Page 343 and 344: 4. Concetti di Europa: come viene i
- Page 345 and 346: Francia e Germania; la Russia, il p
- Page 347: ad accaparrarsi territori d’oltre
- Page 351 and 352: 4.3. La ricerca di comunità e pace
- Page 353 and 354: zioni Unite, è in buona sostanza l
- Page 355 and 356: tate qui, ma molte delle loro parti
- Page 357 and 358: comunità europea con un estratto d
- Page 359 and 360: to la fondazione della comunità eu
- Page 361 and 362: presentata come una formazione comp
- Page 363 and 364: punto di vista continentale, questa
- Page 365 and 366: agli Stati Uniti e all’Unione Sov
- Page 367 and 368: Tuttavia i manuali esaminati non of
- Page 369 and 370: tagna e della Francia unire l’Eur
- Page 371 and 372: Riferimenti bibliografici Bates, B.
- Page 373 and 374: Analisi formale sui libri di testo
- Page 375 and 376: Teach Yourself Study Aids 1. Gran B
- Page 377 and 378: «The World This Century» 1. Gran
- Page 379 and 380: Twentieth Century World History 1.
- Page 381 and 382: «Our World Today» 1. Gran Bretagn
- Page 383 and 384: L’ascesa e il crollo di Mussolini
- Page 385 and 386: «Blackwell History Project» Volum
- Page 387 and 388: 14. elencazione dei capitoli e para
- Page 389 and 390: 11. elencazione dei capitoli e para
- Page 391 and 392: Mastering Modern World History 1. G
- Page 393 and 394: 14.elencazione dei capitoli e parag
- Page 395 and 396: Nazionalismo e unificazione della G
- Page 397 and 398: Skills in History 1. Gran Bretagna
- Page 399 and 400:
Aspects of Modern World History 1.
- Page 401 and 402:
La campagna mediterranea Il fronte
- Page 403 and 404:
L’immagine dell’Europa nei manu
- Page 405 and 406:
geografia, nella parte dedicata a
- Page 407 and 408:
hanno ancora letto ben poco nei man
- Page 409 and 410:
carattere corsivo, nel corso di una
- Page 411 and 412:
dell’Impero romano: le terre che
- Page 413 and 414:
certo senso più che un continente,
- Page 415 and 416:
tratta, dunque, non solo di stabili
- Page 417 and 418:
dell’Europa non viene minimamente
- Page 419 and 420:
mune agricolo, alla dipendenza ener
- Page 421 and 422:
Anche il manuale di Ardemagni, Mamb
- Page 423 and 424:
luce le notizie su quei popoli ci s
- Page 425 and 426:
sarebbe invece iniziato con la conq
- Page 427 and 428:
listica, non è presentata come un
- Page 429 and 430:
L’inserimento della famiglia come
- Page 431 and 432:
va dell’Europa si ritrova anche n
- Page 433 and 434:
mente esposte le cause del successo
- Page 435 and 436:
che, a vittoria ottenuta, avrebbe d
- Page 437 and 438:
zione del lettore su fatti avvenuti
- Page 439 and 440:
tenze europee aveva una proiezione
- Page 441 and 442:
cordiamo le parole del Mazzini, non
- Page 443 and 444:
Il filoeuropeista Caocci dedica all
- Page 445 and 446:
agli aspetti economici e politici t
- Page 447 and 448:
nazionale, di quella europea e di q
- Page 449 and 450:
1 Per una panoramica delle iniziati
- Page 451 and 452:
zioni locali furono sconvolti, prov
- Page 453 and 454:
Caocci A., Conoscere per capire la
- Page 455 and 456:
Appendice Schede sull’idea di Eur
- Page 457 and 458:
Il Rinascimento e l’«idea di Eur
- Page 459 and 460:
trimonio storico e culturale, si sa
- Page 461 and 462:
una Europa tutta libera e tutta ami
- Page 463 and 464:
poteva chiedere di unificare le eco
- Page 465 and 466:
451
- Page 467 and 468:
Lo sviluppo della dimensione europe
- Page 469 and 470:
1. L’approccio alla dimensione eu
- Page 471 and 472:
Le informazioni fornite su queste u
- Page 473 and 474:
necessità; l’altro mirerà a ind
- Page 475 and 476:
e in ogni caso è spesso trascurata
- Page 477 and 478:
le difficoltà inerenti all’attua
- Page 479 and 480:
essere concepita soltanto come dina
- Page 481 and 482:
nel corso di tale procedimento: ci
- Page 483 and 484:
Nota sugli autori Falk Pingel è vi
- Page 485 and 486:
Quaderni della Fondazione Volumi gi
- Page 487 and 488:
Albert Bastenier e Felice Dassetto,
- Page 489 and 490:
Popolazioni e culture italiane nel