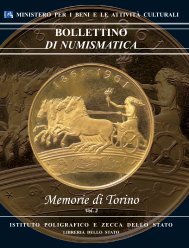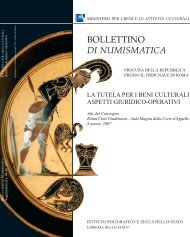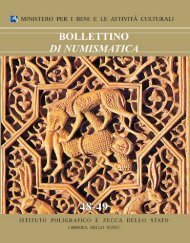Bollettino di Numismatica n. 36-39 - Portale Numismatico dello Stato
Bollettino di Numismatica n. 36-39 - Portale Numismatico dello Stato
Bollettino di Numismatica n. 36-39 - Portale Numismatico dello Stato
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
BdN <strong>36</strong>-<strong>39</strong> (2008)<br />
Fontanamare (Cagliari). Il relitto "A"<br />
l'evoluzione delle forme attraverso i tipi <strong>di</strong> transizione. Se nell'ambito della D sono forse ancora da<br />
identificare non poche varianti ed imitazioni, in un arco cronologico assai ampio, è invece un fatto chiarissimo<br />
che la sigillata chiara C rappresenta una produzione a sé stante. Tale produzione è caratterizzata<br />
da forme chiuse nella fase più antica (prima metà del III secolo) 2) e da poche forme aperte, totalmente<br />
nuove, che appaiono nella seconda metà del III sec. d.C. Queste ultime forme vengono in seguito imitate<br />
dalle fabbriche che producono la sigillata chiara D o da altre officine minori.<br />
Le imitazioni della terra sigillata chiara, specialmente dei tipi C e D, appaiono più numerose <strong>di</strong><br />
quanto si potesse in principio supporre, ed è sicuramente da situarsi in Africa la loro patria <strong>di</strong> origine.<br />
Occorre peraltro essere cauti nell'attribuire in blocco all'Africa tutta la produzione <strong>di</strong> imitazioni <strong>di</strong> sigillata<br />
a vernice arancione, in quanto alcune <strong>di</strong> tali produzioni si situano sicuramente in aree non africane.<br />
Non sembra d'altronde che vi siano dubbi circa una produzione africana occidentale che, nel corso del<br />
IIIV secolo, si estendeva su tutta l'area me<strong>di</strong>terranea seguendo <strong>di</strong> pari passo il processo <strong>di</strong> totale unificazione<br />
del Me<strong>di</strong>terraneo.<br />
Le forme in<strong>di</strong>viduate a Fontanamare, tra il materiale ricuperato nel 1972, sono la Lamboglia 40, la 40<br />
A e la 41 della sigillata chiara A/C e la 52A, in <strong>di</strong>verse varianti, e 54bis della sigillata chiara A/D (tabb. IV).<br />
Per quanto attiene alla composizione dell'argilla, si potrebbe pensare che le analisi mineralogicopetrografiche<br />
possano offrire, 3) in maniera più sicura e geograficamente meno generalizzata, l'in<strong>di</strong>viduazione<br />
dei centri <strong>di</strong> produzione, sia della terra sigillata chiara, sia delle anfore. Indagini <strong>di</strong> questo tipo sono<br />
già state effettuate su ceramiche tra<strong>di</strong>zionali e materiali provenienti da altri contesti tardoantichi 4) con<br />
risultati poco convincenti in quanto il limite delle stesse sta soprattutto nell'uniformità geologica che presenta<br />
l'area nordafricana. Il Mannoni era già giunto a tali risultati quando, negli anni 19731974, effettuò<br />
le analisi mineropetrografiche e geochimiche su quattro campioni <strong>di</strong> materiale proveniente dal relitto<br />
<strong>di</strong> Fontanamare (tre <strong>di</strong> sigillata chiara e uno <strong>di</strong> anfora). Secondo il Mannoni tutti i campioni analizzati<br />
«appartengono al gruppo del quarzo eolico uniforme; nell'impasto dell'anfora, meno depurato, si notano<br />
anche miche bianche e feldespati che derivano probabilmente da una associazione con materiali residuali<br />
<strong>di</strong> rocce a paragenesi granitica» 5) (tab. VI). L'affinità <strong>di</strong> componenti dell'argilla dei campioni <strong>di</strong><br />
sigillata chiara e dell'unico campione <strong>di</strong> anfora in<strong>di</strong>cano con una certa sicurezza la loro provenienza dalla<br />
stessa zona dell'Africa del Nord.<br />
Le ricerche archeologiche effettuate nella me<strong>di</strong>a e alta Tunisia hanno portato alla scoperta <strong>di</strong> una<br />
serie <strong>di</strong> officine <strong>di</strong> sigillata chiara 6) che hanno prodotto, senza alcun dubbio, delle imitazioni locali o<br />
2)<br />
SALOMONSON 1968, p. 113 e segg.<br />
3)<br />
Oggi si cerca <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare, col supporto <strong>di</strong> queste analisi chimiche, le aree ove i componenti delle argille sono presenti. Questo tipo<br />
<strong>di</strong> ricerca va fatta con prudenza in quanto, pur potendo i componenti delle paste confermare le caratteristiche geomorfologiche <strong>di</strong> una determinata<br />
zona e quin<strong>di</strong> la loro provenienza, non sempre tale fatto può <strong>di</strong>mostrare che i centri <strong>di</strong> produzione corrispondano necessariamente alla zona<br />
dalla quale provengono le argille; tanto più che queste venivano esportate, anche per via marittima, verso altri centri <strong>di</strong> produzione. Per poter<br />
avere maggiori certezze appare in<strong>di</strong>spensabile creare dei «gruppi <strong>di</strong> riferimento», all'interno dei singoli giacimenti finora scavati, in modo da<br />
poter delineare i parametri chimici e mineralogici delle varie produzioni.<br />
4)<br />
SCHURING 1988, pp. 168, ha fatto seguire meto<strong>di</strong> archeometrici confortati dalle analisi petrografiche; v., nello stesso articolo,<br />
l'appen<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> H. KARS.<br />
5)<br />
MANNONI 1974, p. 195.<br />
6)<br />
TORTORELLA 1993, pp. 8485.<br />
135<br />
http://www.numismatica<strong>dello</strong>stato.it