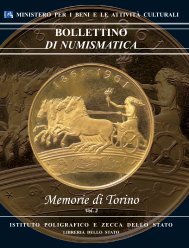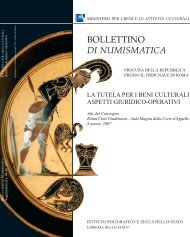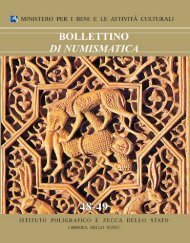Bollettino di Numismatica n. 36-39 - Portale Numismatico dello Stato
Bollettino di Numismatica n. 36-39 - Portale Numismatico dello Stato
Bollettino di Numismatica n. 36-39 - Portale Numismatico dello Stato
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
BdN <strong>36</strong>-<strong>39</strong> (2008)<br />
Tilde De Caro, Gabriel Maria !ngo, Donatella Salvi<br />
riportato in TABELLA I è rappresentato dal tenore relativamente elevato <strong>di</strong> calcio e dalla presenza in alcune scorie<br />
<strong>di</strong> tenori <strong>di</strong>screti <strong>di</strong> fosforo, che lascerebbe ipotizzare un'aggiunta intenzionale <strong>di</strong> tali elementi me<strong>di</strong>ante<br />
ossa <strong>di</strong> animali ricche in fosfato <strong>di</strong> calcio, analogamente a quanto osservato nelle scorie <strong>di</strong> età feniciopunica<br />
rinvenute durante lo scavo archeologico del quartiere industrialemetallurgico <strong>di</strong> Tharros (Sardegna). Tale<br />
aggiunta era effettuata per abbassare il punto <strong>di</strong> fusione delle scorie e facilitare, quin<strong>di</strong>, il processo metallurgico.<br />
Infatti, la presenza <strong>di</strong> metalli alcalini, alcalino terrosi e <strong>di</strong> fosforo può <strong>di</strong>minuire la temperatura <strong>di</strong> fusione<br />
anche <strong>di</strong> circa 150°C e migliorare sia la conduzione del processo sia la qualità dei prodotti. Non è, però, da<br />
escludere che la presenza <strong>di</strong> calcio non fosse intenzionale dal momento che esso si trova sia nei minerali grezzi<br />
sia nei rivestimenti delle fornaci, il che basterebbe a giustificare il tenore trovato nelle scorie.<br />
Ulteriori informazioni si ricavano dall'esame della microstruttura chimica delle scorie. Nella TAVO<br />
LA 2 è mostrata, in alto, una micrografia ottenuta tramite elettroni retro<strong>di</strong>ffusi della sezione della scoria<br />
US 305 e in TABELLA II sono riportate le composizioni chimiche delle principali fasi presenti nella microstruttura.<br />
I risultati rivelano una struttura microchimica complessa tipica <strong>di</strong> scorie <strong>di</strong> trasformazione <strong>di</strong><br />
ossi<strong>di</strong> <strong>di</strong> ferro in ferro metallico. Si nota, infatti, la coesistenza <strong>di</strong> una fase dendritica <strong>di</strong> ossido <strong>di</strong> ferro<br />
(fase bianca, spettro b) circondata da una fase vetrosa interdendritica composta da calcio, alluminio,<br />
potassio e silicio (fondo scuro, spettro c) che Wingrove e Morton, 10) hanno in<strong>di</strong>cato come fase anortitica<br />
e la cui presenza è stata già identificata in scorie ferrose puniche, romane e me<strong>di</strong>oevali. La composizione<br />
della fase vetrosa potrebbe, infatti, essere associata alla composizione dell'anortite<br />
(2SiO 2·CaO·Al 2 O 3 ) in cui si trovano <strong>di</strong>ssolti CaO e K 2 O. Inoltre la micrografia mostra la presenza <strong>di</strong> cristalli<br />
ben formati <strong>di</strong> fayalite (2FeO·SiO 2 ) (fase grigia, spettro a) con modesti tenori <strong>di</strong> calcio e manganese.<br />
La micrografia mostra, inoltre, che la fayalite è ben cristallizzata e tale informazione in<strong>di</strong>ca un<br />
buon controllo termo<strong>di</strong>namico e cinetico del processo. 11) Il <strong>di</strong>ffrattogramma XRD, mostrato nella TAVO<br />
LA 2, in basso, conferma la presenza <strong>di</strong> cristalli <strong>di</strong> fayalite ed identifica l'ossido <strong>di</strong> ferro come wustite<br />
(FeO); al contrario non mostra la presenza <strong>di</strong> ematite (Fe 2 O 3 ), <strong>di</strong> ercinite (FeO·Al 2 O 3 ) o <strong>di</strong> magnetite<br />
(FeO·Fe 2 O 3 ). È importante sottolineare che la wustite è stabile sopra i 560°C, mentre al <strong>di</strong> sotto <strong>di</strong> tale<br />
temperatura, se il raffreddamento è lento e sono mantenute le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> equilibrio, si decompone in<br />
ferro e magnetite (FeO·Fe 2 O 3 ). Quin<strong>di</strong>, la presenza <strong>di</strong> dendriti primarie <strong>di</strong> wustite riflette una deviazione<br />
del processo dall'equilibrio, tale da prevenire la decomposizione <strong>di</strong> una fase stabile ad alta temperatura.<br />
TABELLA II. - Analisi chimiche delle fasi mostrate nella micrografia SEM riportata in tavola II (scoria US 305).<br />
Scoria US 305 Si0 2 AI 20 3 Fe 20 3 Mo0 2 Mg0 Ca0 K 20 P 20 3<br />
Fasi grigie, spettro A 27.80 - 67.35 1.61 2.42 0.69 - -<br />
Fasi bianche, spettro B - 0.83 98.42 0.57 - - - -<br />
Fondo, spettro C <strong>39</strong>.53 18.62 22.32 0.61 0.48 8.35 8.71 1.30<br />
10)<br />
R.F. TYLECOTE, A History of Metallurgy, The Institute of Materials, USA 1992.<br />
11)<br />
G.M. INGOG, G. BULTRINI, G. CHIOZZINI, Microchemical stu<strong>di</strong>es for locating the iron ore sources exploited at Tharros during PhoenicianPunic<br />
period, in Rivista <strong>di</strong> Stu<strong>di</strong> Fenici, XXIII Suppl., 1995, pp. 99107.<br />
326<br />
http://www.numismatica<strong>dello</strong>stato.it