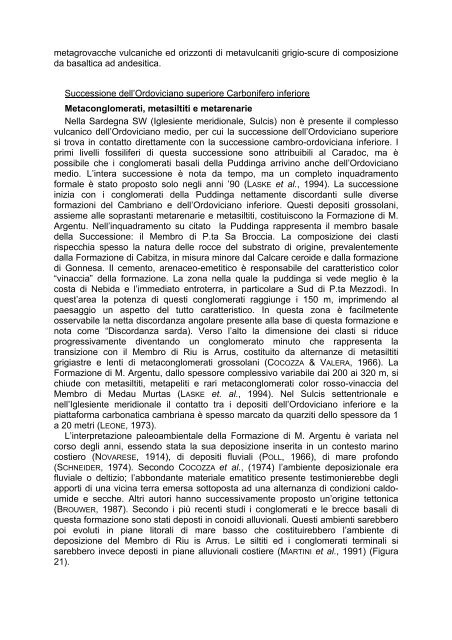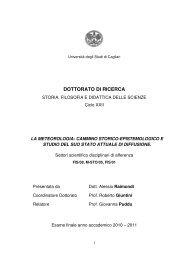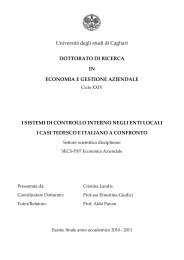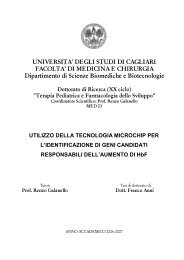- Page 2 and 3: IndiceINTRODUZIONE ................
- Page 4 and 5: L’ESPLORAZIONE FLORISTICA DELL’
- Page 9 and 10: peculiari che mancano in aree o dis
- Page 11 and 12: GeomorfologiaLa regione geografica
- Page 13 and 14: che al loro sbocco nella fossa tett
- Page 15 and 16: alcune cale (Cala Domestica, Canalg
- Page 17 and 18: Figura 6. Sill su Monte Majori, nel
- Page 19 and 20: Figura 10. Versante del Monte Linas
- Page 21 and 22: Figura 14. Area mineraria di Malaca
- Page 23 and 24: Figura 18. Aree cacuminali del Mont
- Page 25 and 26: a falde (dall’Arburese al Sarrabu
- Page 27 and 28: STATO DI CONOSCENZA DEL BASAMENTO E
- Page 29 and 30: Figura 20. Colonna stratigrafica sc
- Page 31 and 32: talora lenti di barite. L’ambient
- Page 33: quarzo-feldspatica da grigio verde
- Page 37 and 38: plutoniti sono state distinte diver
- Page 39 and 40: unitamente al fatto che anche la Pu
- Page 41 and 42: del ciclo vulcanico calcalcalino ol
- Page 43 and 44: centro-settentrionale e la Corsica
- Page 45 and 46: L’età della Formazione del Cixer
- Page 47 and 48: e plateaux basaltici. In due casi q
- Page 49 and 50: I sistemi di faglie presenti in Sar
- Page 51 and 52: dall’andamento dei massicci montu
- Page 53 and 54: Gutturu ‘e Flumini, noto anche co
- Page 55 and 56: di Villamassargia, con 70 l/sec., l
- Page 57 and 58: PedologiaLa carta dei suoli della S
- Page 59 and 60: Classe di capacità d’uso: VII-IV
- Page 61 and 62: strutturalmente simili a quelli del
- Page 63 and 64: Limitazioni d’uso: rocciosità e
- Page 65 and 66: 25. Typic e Lithic Xerorthents; Typ
- Page 67 and 68: 29. Typic, Vertic, Aquic e Mollic X
- Page 69 and 70: ad Arbus. E’ presente un porto, q
- Page 71 and 72: Alcune considerazioni sul rapporto
- Page 73 and 74: Per quanto riguarda l’Anticiclone
- Page 75 and 76: Le temperature medie delle minime m
- Page 77 and 78: venti umidi provenienti dal Mar di
- Page 79 and 80: avviene più precocemente, più tar
- Page 81 and 82: S. GiovanniBacu AbisFluminimaggiore
- Page 83 and 84: Il calcolo dell’irraggiamento sol
- Page 85 and 86:
Il mese dell’anno più soleggiato
- Page 87 and 88:
Per calcolare iSul piano orizzontal
- Page 89 and 90:
di radiazione solare incidente. Si
- Page 91 and 92:
I100,080,060,0P. Incl. ombr.% sulP.
- Page 93 and 94:
BioclimaMATERIALI E METODILa biocli
- Page 95 and 96:
BACU ABIS Altitudine: 90 m s.l.m. L
- Page 97 and 98:
BELLICAI Altitudine: 367 m Latitudi
- Page 100 and 101:
CAPO FRASCA Altitudine: 92 m Latitu
- Page 103 and 104:
FLUMINIMAGGIORE Altitudine: 45 m La
- Page 106 and 107:
GONNOSFANADIGA Altitudine: 190 m La
- Page 109 and 110:
IGLESIAS Altitudine: 193 m Latitudi
- Page 111 and 112:
T = Temperatura mediaER = Evapotras
- Page 113:
150 1105010090408070T medie30206050
- Page 116:
1105010090408070T medie302060504030
- Page 119 and 120:
110 15050100904080T medie3020706050
- Page 121 and 122:
NEBIDA Altitudine: 170 m s.l.m. Lat
- Page 123 and 124:
PUNTA GENNARTA (Diga) Altitudine: 2
- Page 126 and 127:
S.GIOVANNI (Domusnovas) Altitudine:
- Page 128 and 129:
Scheda idricaT = Temperatura mediaE
- Page 130 and 131:
50100459040803570T medie30252060504
- Page 132 and 133:
50100459040803570T medie30252060504
- Page 134 and 135:
SU ZURFURU Altitudine: 105 m Latitu
- Page 136 and 137:
Scheda idricaT = Temperatura mediaE
- Page 138 and 139:
501004080T medie30206040mm precipit
- Page 140 and 141:
VILLACIDRO Altitudine: 213 m Latitu
- Page 142 and 143:
Scheda idricaT = Temperatura mediaE
- Page 144 and 145:
50100459040803570T med302520605040m
- Page 146 and 147:
INQUADRAMENTO BIOCLIMATICO DELL’I
- Page 148 and 149:
9876N° stazioni543210inferiore sup
- Page 150 and 151:
I comuni presenti sul territorio di
- Page 152 and 153:
Fluminimaggiore, ma la sua popolazi
- Page 154 and 155:
Paese situato in una conca a 50 met
- Page 156 and 157:
Sa TurritaLocalità poco distante d
- Page 158 and 159:
GUSPINIGrosso centro situato ai pie
- Page 160 and 161:
d’argento. Un deciso impulso alla
- Page 162 and 163:
infeudato a Pericono de Libià e i
- Page 164 and 165:
costituzione del polo industriale,
- Page 166 and 167:
Lo spopolamento dell’area nel tar
- Page 168 and 169:
CasasCuratoria del Sigerro. Nel 132
- Page 170 and 171:
del fenomeno, basate in particolare
- Page 172 and 173:
quando non si è certi della deriva
- Page 174 and 175:
Per quanto riguarda i riferimenti c
- Page 176 and 177:
Zone rocciose1%Non identificabili,
- Page 178 and 179:
FITOPONIMO NOME VERNACOLARE BINOMIO
- Page 180 and 181:
FITOPONIMO NOME VERNACOLARE BINOMIO
- Page 182 and 183:
FITOPONIMO NOME VERNACOLARE BINOMIO
- Page 184 and 185:
FITOPONIMO NOME VERNACOLARE BINOMIO
- Page 186 and 187:
FITOPONIMO NOME VERNACOLARE BINOMIO
- Page 188 and 189:
FITOPONIMO NOME VERNACOLARE BINOMIO
- Page 190 and 191:
L’ESPLORAZIONE FLORISTICA DELL’
- Page 192 and 193:
escursioni si soffermarono sulle pi
- Page 194 and 195:
L’interesse per la flora dell’a
- Page 196 and 197:
Nel 1694 Tournefort definì le line
- Page 198 and 199:
classificazione delle angiosperme d
- Page 200 and 201:
RELAZIONI FILOGENETICHE NELLE PTERI
- Page 202 and 203:
RELAZIONI FILOGENETICHE NELLE SPERM
- Page 204 and 205:
RAPPORTI FILOGENETICI DELLE ANGIOSP
- Page 206 and 207:
Il clado delle Asteride è ritenuto
- Page 208 and 209:
l’innovazione dei carpelli) e le
- Page 210 and 211:
Le ricerche d’erbario sono state
- Page 212 and 213:
(W)/narrow (N)], ampiezza ecologica
- Page 214 and 215:
Polystichum Roth ..................
- Page 216 and 217:
Simethis Kunth ....................
- Page 218 and 219:
Clematis L. .......................
- Page 220 and 221:
Bryonia L..........................
- Page 222 and 223:
Biscutella L.......................
- Page 224 and 225:
Lamiales Bromhead (1838) ..........
- Page 226 and 227:
Asteraceae Martynov (1820) ........
- Page 228 and 229:
Elenco floristicoLYCOPODIOPHYTA D.H
- Page 230 and 231:
7. Equisetum hyemale L. - G rhiz -
- Page 232 and 233:
POLYPODIALES SCHIMP. (1822)Polypodi
- Page 234 and 235:
Monte Linas, su rocce ombrose a q.
- Page 236 and 237:
BLECHNALES Pic. Serm. ex Reveal (19
- Page 238 and 239:
27. Asplenium ruta-muraria L. ssp.
- Page 240 and 241:
substrato calcari paleozoici. Ponte
- Page 242 and 243:
1993).Fluminese, comune (BALLERO et
- Page 244 and 245:
Piscinas. ASCHERSON & REINHARDT ex
- Page 246 and 247:
MONOCOTYLEDONESALISMATALES Dumort.
- Page 248 and 249:
Domusnovas, dalla grotta di S. Giov
- Page 250 and 251:
Zannichellia L.73. Zannichellia pal
- Page 252 and 253:
inf./subumido inf.; 200 m s.l.m. Ca
- Page 254 and 255:
Ingurtosu. BORNEMANN ex BARBEY (188
- Page 256 and 257:
Capo Frasca, macchia e gariga costi
- Page 258 and 259:
Monte Arcuentu, zone rocciose, prat
- Page 260 and 261:
Ruscus L.115. Ruscus aculeatus L. (
- Page 262 and 263:
Distretto minerario di Montevecchio
- Page 264 and 265:
In maritimis herbidis, martio; Flum
- Page 266 and 267:
Oss. Discariche minerarie di Arenas
- Page 268 and 269:
Sa Duchessa, Domusnovas, 27.IV.1999
- Page 270 and 271:
152. Ophrys chestermanii (J.J. Wood
- Page 272 and 273:
Margini del sentiero in località I
- Page 274 and 275:
Oss. Ingurtosu, Arbus. 34170. Ophry
- Page 276 and 277:
175. Orchis papilionacea L. var. gr
- Page 278 and 279:
183. Serapias nurrica Corrias (*) -
- Page 280 and 281:
190. Asphodelus ramosus L. ssp. ram
- Page 282 and 283:
1983).Massiccio del Marganai, solo
- Page 284 and 285:
POALES Small (1903)Cyperaceae Juss.
- Page 286 and 287:
Oss. Tra Plagemesu e la Palude di S
- Page 288 and 289:
Ingurtosu, Flumini maggiore. Plante
- Page 290 and 291:
Schoenoplectus (Rchb.) Palla232. Sc
- Page 292 and 293:
240. Juncus effusus L. ssp. effusus
- Page 294 and 295:
Case S. Pietro, Iglesias. Casti et
- Page 296 and 297:
Anthoxanthum L.261. Anthoxanthum ar
- Page 298 and 299:
Secus vias (...) Iglesias (MORIS, 1
- Page 300 and 301:
1200; frequente (ANGIOLINO & CHIAPP
- Page 302 and 303:
Monte Arcuentu, margini delle strad
- Page 304 and 305:
CHIAPPINI, 1983).Fluminese, radure;
- Page 306 and 307:
Angius, 17.VI.2005 (CAG).Elytrigia
- Page 308 and 309:
Iglesias a S. Lorenzo. Gennari, (si
- Page 310 and 311:
Lamarckia Moench331. Lamarckia aure
- Page 312 and 313:
Micropyrum (Gaudin) Link341. Microp
- Page 314 and 315:
Piptatherum P. Beauv.353. Piptather
- Page 316 and 317:
Polypogon Desf.364. Polypogon marit
- Page 318 and 319:
m s.l.m. Bacchetta, 09.V.2001 (CAG)
- Page 320 and 321:
Iglesias; (...), junio 1826. Herb.
- Page 322 and 323:
Sparganiaceae Hanin (1811)Sparganiu
- Page 324 and 325:
Hypecoum L.404. Hypecoum procumbens
- Page 326 and 327:
416. Anemone palmata L. - G rhiz -
- Page 328 and 329:
San Nicolò, Buggerru. Substrato: c
- Page 330 and 331:
Massiccio del Marganai, radure e pr
- Page 332 and 333:
Monte Linas, sorgente Gutturu Arrus
- Page 334 and 335:
Paurras. (MAXIA et SARDARA, 1972).M
- Page 336 and 337:
466. Chenopodium ambrosioides L. (*
- Page 338 and 339:
Cactaceae Juss. (1789)Opuntia Mill.
- Page 340 and 341:
488. Cerastium thomasii Ten. 61 - C
- Page 342 and 343:
1993).Moenchia Ehrh.497. Moenchia e
- Page 344 and 345:
Sagina L.506. Sagina apetala Ard. (
- Page 346 and 347:
518. Silene fuscata Brot. - T scap
- Page 348 and 349:
Arene della costa Verde a nord di M
- Page 350 and 351:
Spergularia (Pers.) Presl535. Sperg
- Page 352 and 353:
anche a Punta Cammedda 1100 m; freq
- Page 354 and 355:
Polygonaceae Juss. (1789)Emex Campd
- Page 356 and 357:
Acqua Durci, III.1975; IV.1975; Pis
- Page 358 and 359:
Miniere di S. Giovanni di Bindua, I
- Page 360 and 361:
583. Tamarix hampeana Boiss. et Hel
- Page 362 and 363:
1993).Fluminese, rupi; comune (BALL
- Page 364 and 365:
Fluminese, rupi ombrose e umide; co
- Page 366 and 367:
606. Saxifraga pedemontana All. ssp
- Page 368 and 369:
618. Erodium maritimum (L.) L’Hé
- Page 370 and 371:
Bacino montano del Riu Mannu di Flu
- Page 372 and 373:
Monte Linas, in macchie sparse alle
- Page 374 and 375:
CUCURBITALES Dumort. (1829)Cucurbit
- Page 376 and 377:
Monteponi, Iglesias, 03.VI.2001; S.
- Page 378 and 379:
Calicotome Link665. Calicotome vill
- Page 380 and 381:
674. Genista arbusensis Vals. (*) -
- Page 382 and 383:
Miniera Su Zurfuru, Buggerru. Legit
- Page 384 and 385:
Massiccio del Marganai, radure; com
- Page 386 and 387:
694. Lathyrus sylvestris L. ssp. sy
- Page 388 and 389:
707. Lupinus gussoneanus Agardh. (*
- Page 390 and 391:
Bacino montano del Riu Mannu di Flu
- Page 392 and 393:
Ononis L.731. Ononis biflora Desf.
- Page 394 and 395:
Scorpiurus L. 83744. Scorpiurus mur
- Page 396 and 397:
Miniera di montevecchio, Guspini. M
- Page 398 and 399:
765. Trifolium ligusticum Balb. (*)
- Page 400 and 401:
Sa Frocidda; Tuppa Cerbu. PICCI (19
- Page 402 and 403:
Canale compreso tra Punta Perda de
- Page 404 and 405:
Domusnovas, versante Nord del Monte
- Page 406 and 407:
Strada Guspini-Arbus, Guspini. Quot
- Page 408 and 409:
Oss. Presso il Cannisoni.813. Hyper
- Page 410 and 411:
CHIAPPINI, 1983).Arbus, dentro l’
- Page 412 and 413:
Capo Frasca, prati, radure e princi
- Page 414 and 415:
Rio Sa Duchessa, Domusnovas. 27.IV.
- Page 416 and 417:
S. Giovanni Miniera, Iglesias, 11.V
- Page 418 and 419:
855. Salix pedicellata Desf. - P ca
- Page 420 and 421:
ROSALES Perleb (1826)Moraceae Link
- Page 422 and 423:
Potentilla L.872. Potentilla hirta
- Page 424 and 425:
Rubus L.882. Rubus gr. ulmifolius S
- Page 426 and 427:
Urticaceae Juss. (1789)Parietaria L
- Page 428 and 429:
“EUROSIDS II”BRASSICALES Bromhe
- Page 430 and 431:
2.V.1976 (CAG). Presso l’imboccat
- Page 432 and 433:
Monte Linas, nelle praterie ai bord
- Page 434 and 435:
Eruca Miller924. Eruca vesicaria (L
- Page 436 and 437:
Lobularia Desv.932. Lobularia marit
- Page 438 and 439:
Bacino montano del Riu Mannu di Flu
- Page 440 and 441:
Distretto minerario di Montevecchio
- Page 442 and 443:
Capo Frasca, presente in diversi ti
- Page 444 and 445:
Halimium (Dunal) Spach962. Halimium
- Page 446 and 447:
Capo Frasca, prati e bordi delle st
- Page 448 and 449:
Barraxiutta, Domusnovas, 29.IV.1999
- Page 450 and 451:
Sa Bandieruola, Buggerru, 60 m s.l.
- Page 452 and 453:
Distretto minerario di Montevecchio
- Page 454 and 455:
Asterolinon Hoffmgg. et Link1000.As
- Page 456 and 457:
Monte Linas, dalla base del monte s
- Page 458 and 459:
In pascuis maritimis Sardiniae et i
- Page 460 and 461:
Fluminese, incolti e pascoli; comun
- Page 462 and 463:
Iglesias, ad sepes ad vias. Sommier
- Page 464 and 465:
Monte Linas, nelle praterie di zone
- Page 466 and 467:
Baueddu, Iglesias, 26.IV.1999. ANGI
- Page 468 and 469:
Distretto minerario di Montevecchio
- Page 470 and 471:
Rubia L.1065.Rubia peregrina L. s.l
- Page 472 and 473:
LAMIALES Bromhead (1838)Acanthaceae
- Page 474 and 475:
Is Lisandrus (Buggerru), 170 m - es
- Page 476 and 477:
Melissa L.1087.Melissa officinalis
- Page 478 and 479:
1093.Mentha x piperita L. - H scap
- Page 480 and 481:
Oss. Calcari costieri, diffuso tra
- Page 482 and 483:
Presso Genn ‘e Impi, Gonnosfanadi
- Page 484 and 485:
1113.Thymus catharinae Camarda (*)
- Page 486 and 487:
Phillyrea L. 1381117.Phillyrea angu
- Page 488 and 489:
S. Giovanni di Bindua, Iglesias, 24
- Page 490 and 491:
Monte Linas, tra Genna Urgua e Perd
- Page 492 and 493:
Distretto minerario di Montevecchio
- Page 494 and 495:
Capo Frasca, anfratti e radure; rar
- Page 496 and 497:
).1167.Plantago maritima L. ssp. ma
- Page 498 and 499:
Stagno di Gonnesa, zona parastagnal
- Page 500 and 501:
39°33’19,3 N 8°34’55,1 E Bacc
- Page 502 and 503:
Bacino montano del Riu Mannu di Flu
- Page 504 and 505:
Giovanni Miniera, Iglesias, 06.VI.2
- Page 506 and 507:
Lycium L.1213.Lycium europaeum L. -
- Page 508 and 509:
Capo Frasca, è presente in quasi t
- Page 510 and 511:
Crithmum L.1235.Crithmum maritimum
- Page 512 and 513:
Presso Iglesias (solo le foglie) (F
- Page 514 and 515:
S. Giovanni di Bindua, Iglesias, 24
- Page 516 and 517:
Oss. Sul Monte Linas e Marganai, bo
- Page 518 and 519:
Massiccio del Marganai, luoghi erbo
- Page 520 and 521:
1275.Achillea ligustica All. (*) -
- Page 522 and 523:
Monte Arcuentu, margini delle strad
- Page 524 and 525:
Massiccio del Marganai, solo lungo
- Page 526 and 527:
Sopra Candiazzus, Presso Punta Suec
- Page 528 and 529:
Monte Arcuentu, incolti nei pressi
- Page 530 and 531:
Distretto minerario di Montevecchio
- Page 532 and 533:
1325.Crepis vesicaria L. ssp. hyema
- Page 534 and 535:
Stagno di Gonnesa, zona parastagnal
- Page 536 and 537:
1342.Filago pyramidata L. - T scap
- Page 538 and 539:
Hedypnois Miller1351.Hedypnois cret
- Page 540 and 541:
).1358.Helichrysum montelinasanum E
- Page 542 and 543:
Hypochaeris L.1364.Hypochaeris achy
- Page 544 and 545:
In littoreis maritimis Sardiniae oc
- Page 546 and 547:
Picris L.1383.Picris hieracioides L
- Page 548 and 549:
Reichardia Roth1389.Reichardia picr
- Page 550 and 551:
26.IV.1999; Buggerru, Pranusartu, B
- Page 552 and 553:
Acqua Durci, III.1975; IV.1975; Pis
- Page 554 and 555:
Bacino montano del Riu Mannu di Flu
- Page 556 and 557:
Bacino montano del Riu Mannu di Flu
- Page 558 and 559:
Oss. Monte Marganai.Solenopsis C. P
- Page 560 and 561:
San Nicolò, sine die, Ballero, Car
- Page 562 and 563:
Massiccio del Marganai, luoghi erbo
- Page 564 and 565:
eriocephalus Pontecorvo et Carai, 0
- Page 566 and 567:
25020019215015314913912411610050555
- Page 568 and 569:
Spettro biologicoI dati dello spett
- Page 570 and 571:
Spettro corologicoLo spettro corolo
- Page 572 and 573:
Flora alloctonaL’Iglesiente è un
- Page 574 and 575:
preponderante quella delle terofite
- Page 576 and 577:
181616141312109 99877643211 112 212
- Page 578 and 579:
25212019 19 1915121055 56 6780Genti
- Page 580 and 581:
H30,5%Ch27,2%G19,2%T12,6%I0,7%P2,0%
- Page 582 and 583:
cervicornis Viv., Silene velutinoid
- Page 584 and 585:
1 Anchusa littorea Moris IUCN (EN)2
- Page 586 and 587:
Alcune immagini dell’endemoflora
- Page 588 and 589:
Figura 69. Sesleria insularis Sommi
- Page 590 and 591:
Figura 73. Viola corsica Nyman ssp.
- Page 592 and 593:
Figura 77. Linaria flava (Poir.) De
- Page 594 and 595:
ApprofondimentiANCHUSA MONTELINASAN
- Page 596 and 597:
Figura 81. Iconografia di Anchusa m
- Page 598 and 599:
Figura 82. Fiore di Anchusa monteli
- Page 600 and 601:
CorollaCaliceTipo di misura (mm o g
- Page 602 and 603:
Figura 87. Confronto allo stereosco
- Page 604 and 605:
ANCHUSA LITTOREA MORISAnchusa litto
- Page 606 and 607:
sabbie trasportate dal vento e rima
- Page 608 and 609:
che collegava le Alpi occidentali a
- Page 610 and 611:
localmente può divenire rilevante)
- Page 612 and 613:
le fioriture di Astragalus verrucos
- Page 614 and 615:
“CHARYBDIS TODDEANA”, BACCHETTA
- Page 616 and 617:
N°esemplareLunghezzainfiorescenza
- Page 618 and 619:
Figura 98. Sa Punta de Nascu, locus
- Page 620 and 621:
Figura 101. Galium glaucophyllum su
- Page 622 and 623:
la scomparsa di una specie. E’ il
- Page 624 and 625:
Delphinium pictum Willd. ssp. pictu
- Page 626 and 627:
Figura 104. Cosentinia vellea ssp b
- Page 628:
TAXA ENDEMICI
- Page 644:
ATLANTE COROLOGICO DI ALCUNI TAXA D
- Page 653 and 654:
a) L’elemento ecogeografico, che
- Page 655 and 656:
ssp. bivalens, taxon nuovo per la f
- Page 657 and 658:
Analisi floristica di alcuni territ
- Page 659 and 660:
diminuzione della velocità dell’
- Page 661 and 662:
P8,1%Ch5,0%NP3,4%I0,9%T40,8%G14,7%H
- Page 663 and 664:
Sardegna sono 7, così come le ende
- Page 665 and 666:
3002742502001821501008050012cc c pc
- Page 667 and 668:
appresentare una flora secondo grup
- Page 669 and 670:
Elenco floristico1. Acacia karroo H
- Page 671 and 672:
200.Filago pyramidata L.201.Foenicu
- Page 673 and 674:
415.Ranunculus paludosus Poir.416.R
- Page 675 and 676:
Gli ordini maggiormente rappresenta
- Page 677 and 678:
(NP=5%), inoltre sono dovuti all’
- Page 679 and 680:
In Figura 122 sono rappresentati gl
- Page 681 and 682:
N° Unità Tassonomica COROL. UNIT
- Page 683 and 684:
CALCARI COSTIERI PALEOZOICI DELL’
- Page 685 and 686:
34. Asparagus acutifolius L.35. Asp
- Page 687 and 688:
220.Linum bienne Mill.221.Linum cor
- Page 689 and 690:
425.Verbascum sinuatum L.426.Verben
- Page 691 and 692:
Figura 128. Carta dei SICp dell’I
- Page 693 and 694:
Si riporta di seguito la tabella pr
- Page 695 and 696:
Si riporta di seguito l’elenco di
- Page 697 and 698:
1120: Praterie di posidonie (Posido
- Page 699 and 700:
2240 2 B C C C2110 2 C C C C5430 1
- Page 701 and 702:
91E0: Foreste alluvionali di Alnus
- Page 703 and 704:
imboschimento in genere e soprattut
- Page 705 and 706:
9330: Foreste di Quercus suber9320:
- Page 707 and 708:
CODICE % COPERTA RAPPRESENTATIVITAS
- Page 709 and 710:
Criteri di valutazione del sito per
- Page 711 and 712:
CodiceHabitatNome HabitatCopertura
- Page 713 and 714:
L’attività umana che ha maggiorm
- Page 715 and 716:
Brassica insularis MorisFamigliaBra
- Page 717 and 718:
1. Specie endemiche del Sulcis-Igle
- Page 719 and 720:
Sesleria insularis Sommier ssp. mor
- Page 721 and 722:
2. Specie endemiche di interesse co
- Page 723 and 724:
Helichrysum saxatile Moris ssp. mor
- Page 725 and 726:
Iberis integerrima MorisFamigliaBra
- Page 727 and 728:
Plagius flosculosus (L.) Alavi et H
- Page 729 and 730:
3. Altre specie di interesse fitoge
- Page 731 and 732:
La VegetazioneInquadramento general
- Page 733 and 734:
5430 - Phrygane endemiche dell’Eu
- Page 735 and 736:
Aiton ssp. implexa e Tamus communis
- Page 737 and 738:
maggiormente sviluppata a sud di Ig
- Page 739 and 740:
Helichrysum microphyllum (Willd.) C
- Page 741 and 742:
MASSICCIO DEL MONTE ARCUENTUIl Mass
- Page 743 and 744:
MinacceCascata di Sa Spendula: spin
- Page 745 and 746:
correlazioni con formazioni analogh
- Page 747 and 748:
La discordanza ordoviciana della
- Page 749 and 750:
GROTTELa porzione meridionale dell
- Page 751 and 752:
ASPETTI DEL PAESAGGIO VEGETALEDescr
- Page 753 and 754:
Nelle zone montane del sub-distrett
- Page 755 and 756:
di microboschi o formazioni di macc
- Page 757 and 758:
Aristolochia tyrrhena e Arum pictum
- Page 759 and 760:
Serie di vegetazioneSub-distretti19
- Page 761 and 762:
PATRIARCHISi presentano i rilievi e
- Page 763 and 764:
Pinus pinea L.Località: Riu Sessin
- Page 765 and 766:
Juniperus phoenicea L. ssp. macroca
- Page 767 and 768:
Ficus carica L. var. caprificus Ris
- Page 769 and 770:
Quercus ilex L.Località: Sa CoraCo
- Page 771 and 772:
Quercus suber L.Località: LiurusCo
- Page 773 and 774:
presente in un’unica stazione sul
- Page 775 and 776:
LETTERATURA CITATAA.A.V.V., 1998. "
- Page 777 and 778:
BACCHETTA G., BRULLO S. & TERRASI M
- Page 779 and 780:
BOSELLINI A. & OGNIBEN G., 1968. Ri
- Page 781 and 782:
CHIAPPINI M., 1964. Il Leucojum aes
- Page 783 and 784:
FADDA A.F., 1986. Sardegna, una ter
- Page 785 and 786:
LEONE F., 1973. La serie Paleozoica
- Page 787 and 788:
PICCI V., 1964. Contributo alla con
- Page 789 and 790:
STORCH P. & SERPAGLI E., 1993. Lowe
- Page 791:
RingraziamentiSi desidera ringrazia