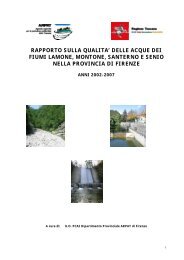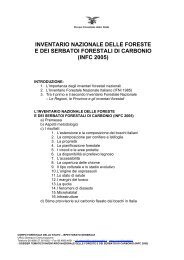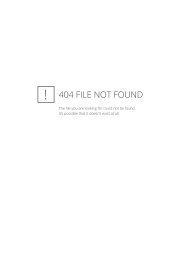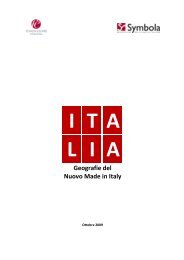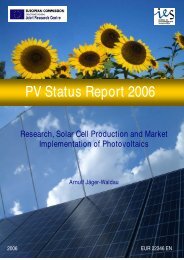Volume - Fondazione toscana sostenibile
Volume - Fondazione toscana sostenibile
Volume - Fondazione toscana sostenibile
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
mentalmente tenuto ad eseguire ordini e seguire istruzioni, all’interno di obblighi contrattuali<br />
abbastanza definiti, nel caso dei beni differenziati e personalizzati, egli deve cercar di<br />
comprendere, nelle numerose situazioni aperte a più soluzioni che gli si presentano, quale<br />
sarà l’effetto di ogni suo comportamento, sul valore di mercato della merce in lavorazione.<br />
Non c’è chi non conosca di persona la difficoltà di coordinare l’intervento di più artigiani<br />
nella rifinitura, ad esempio, di un appartamento: o manca il falegname, o salta l’elettricista,<br />
o latita il fontaniere, e così via. Se questa mancanza di sincronismo, dovuta a tanti piccoli<br />
monopoli spaziali, si verificasse nel distretto, il distretto non potrebbe funzionare. Fortunatamente,<br />
nel distretto: a) ogni fase è coperta da molti fornitori (perlopiù piccoli) in concorrenza<br />
fra loro, talché nessuno di loro può fornire prestazioni molto inferiori al “fornitore<br />
rappresentativo”, senza correre il rischio di essere espulso dal mercato di fase; b) esistono<br />
agenti (io li chiamo “integratori flessibili” 12 ) che operano professionalmente a cavallo del<br />
coordinamento dei fornitori e dell’esplorazione del mercato (nella tradizione pratese<br />
l’“impannatore”). Ogni subfornitore (nella tradizione pratese il “terzista”), per mantenere la<br />
stima di affidabilità presso gli agenti che governano le commesse, si sforza di rispettare gli<br />
impegni presi, per qualità di prestazione, tempo di consegna, ecc..<br />
Il rispetto generalizzato - a parte situazioni eccezionali, riconosciute come tali - degli<br />
impegni reciproci, prevalente nel distretto, contribuisce a crearvi un clima “locale” di fiducia<br />
fra gli agenti, diverso e maggiore, rispetto a quello che prevale fra agenti che vivono in<br />
ambienti sociali diversi. Si crea, cioè, una “strana” congruenza fra il rispetto di sé e la<br />
convenienza economica (honesty is the best policy, dicono gli inglesi) che costituisce un<br />
autentico collante morale fra i membri del distretto industriale. Ciò costituisce la parte essenziale,<br />
più originale e più difficile da cogliere di quello che si chiama il “capitale sociale”<br />
del distretto industriale 13 . Da ciò, un abbassamento del costo dell’”uso del mercato” - cioè<br />
del ricorso al far fare a terzi quello che si potrebbe anche fare, attrezzandosi appositamente,<br />
all’interno dell’impresa 14 - che induce un’accelerazione della spinta alla divisione del<br />
lavoro, ovvero alla specializzazione produttiva. Da questa tendenza alla scomposizione<br />
progressiva delle fasi del processo distrettuale, discende una accelerazione, rispetto ad<br />
altri ambienti industriali, della velocità di crescita della produttività del lavoro 15 .<br />
Un aspetto pure importante del capitale sociale è costituito dalla capacità diffusa degli agenti<br />
produttivi del distretto di coniugare il know how della tradizione locale (io parlo di “sapere contestuale”<br />
che contrappongo al “sapere codificato” 16 ) con gli apporti della tecnica più aggiornata. Il terreno su cui<br />
s’incontrano queste due vene di know how produttivo è spesso il design, contiguo peraltro alla progettazione<br />
tecnica del prodotto. Si può anche dire che una componente essenziale del vantaggio competitivo<br />
distrettuale, è data precisamente dalla diffusa capacità di innestare la tecnica più raffinata in una manualità<br />
artigiana maturata nei secoli. Non si tratta dunque di un patrimonio che si consuma nell’uso, ma di un<br />
12 Per una spiegazione del termine rinvio a: Becattini G. e Rullani E., 1993.<br />
13 Cfr. Per tutti: Coleman, J.S., 2005 e la Rivista Stato e Mercato che gli dedica molta attenzione.<br />
14 Cfr. Per un’applicazione al distretto industriale, di questo schema di ragionamento, si veda, ad es. Dei Ottati G. 1986<br />
15 Su questo processo mi sono espresso più ampiamente in Becattini G. 2000.<br />
16 Anche per questi termini rinvio a Becattini G. e Rullani E. (1993)<br />
265