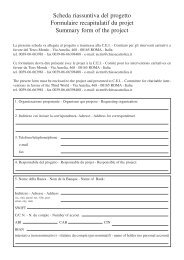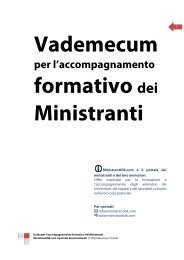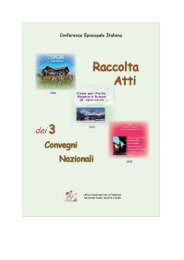- Page 1 and 2:
ARTE E BENI CULTURALI NEGLI INSEGNA
- Page 3 and 4:
PREFAZIONE Volentieri, anzi con gio
- Page 5 and 6:
nello spirito della «nuova evangel
- Page 7 and 8:
INTRODUZIONE Sono certo che ai post
- Page 9 and 10:
centenario del Concilio Niceno II,
- Page 11 and 12:
uon diritto come arbitra, scegliend
- Page 13 and 14:
In maniera non dissimile, ha bisogn
- Page 15 and 16:
L’evangelizzazione della cultura,
- Page 17 and 18:
vero e il bene, più immediatamente
- Page 19 and 20:
gere il concetto di « oggetto di c
- Page 21 and 22:
nuova Commissione era membro ex off
- Page 23 and 24:
Dio ha, dunque, chiamato all’esis
- Page 25 and 26:
papa si proietta verso il futuro, r
- Page 27 and 28:
nuti per l’Angelus - incontrò gl
- Page 29 and 30:
Il gusto estetico fa inclinare l’
- Page 31 and 32:
porti l’impronta dell’arte e de
- Page 33 and 34:
Il linguaggio musicale viene spesso
- Page 35 and 36:
Paolo II ha dedicato tanta parte de
- Page 37 and 38:
dalla rinuncia della ricerca immedi
- Page 39:
pur importante esperienza della sua
- Page 42 and 43:
Martin James Alfred, Beauty and Hol
- Page 45 and 46:
NOTA EDITORIALE I testi qui raccolt
- Page 47:
ARTE E BENI CULTURALI NEGLI INSEGNA
- Page 50 and 51:
ichiede, e coestensivamente deve te
- Page 52 and 53:
universale, che valica i confini na
- Page 55 and 56:
1979 Discorso per l’udienza gener
- Page 57 and 58:
La salvaguardia, promozione, santif
- Page 59 and 60:
che questo frutto della creatività
- Page 61 and 62:
Discorso a una rappresentanza di mi
- Page 63 and 64:
prendi per credere; credi per capir
- Page 65 and 66:
Omelia nella parrocchia di San Gius
- Page 67 and 68:
Questo vale particolarmente per chi
- Page 69 and 70:
Parte Seconda Titolo IV - ALTRE FAC
- Page 71 and 72:
Con felice espressione, nella prese
- Page 73 and 74:
partecipare alla celebrazione dei d
- Page 75 and 76:
non assomiglia forse, in qualche mo
- Page 77 and 78:
profonde esigenze dell’uomo, che
- Page 79 and 80:
storico. È il documento della vita
- Page 81 and 82:
Ciò è richiesto, anzitutto, dalla
- Page 83 and 84:
attraverso i secoli ». Grazie a Di
- Page 85 and 86:
chiamata a un servizio internaziona
- Page 87 and 88:
Catechesi tradendae. Esortazione ap
- Page 89 and 90:
diamo i nostri propositi e i nostri
- Page 91 and 92:
1980 Discorso alla Giunta e al Cons
- Page 93 and 94:
La lettura dei brani della Sacra Sc
- Page 95 and 96:
vita che san Benedetto ha inculcato
- Page 97 and 98:
che vi abitano. Bisognerebbe trovar
- Page 99 and 100:
Infine ci sono le Orazioni, raccolt
- Page 101 and 102:
È indubbio, per altro, che gli str
- Page 103 and 104:
e di pensiero cristiani. 3 Voi desi
- Page 105 and 106:
Per questo motivo il Concilio ha ri
- Page 107 and 108:
Vescovi della Chiesa in Italia, voi
- Page 109 and 110:
aree meno favorite. Durante i miei
- Page 111 and 112:
musica, arte, organizzando fondazio
- Page 113 and 114:
medesimo tempo nella sfera dei valo
- Page 115 and 116:
stituisce bene una chiave, e anche
- Page 117 and 118:
Signore e signori, mi vorrete perdo
- Page 119 and 120:
14. Se, in nome dell’avvenire del
- Page 121 and 122:
poco numerosa, moltitudini di citta
- Page 123 and 124:
Due considerazioni mi guidano a sot
- Page 125 and 126:
Discorso per l’udienza generale (
- Page 127 and 128: Anche san Benedetto viveva in una s
- Page 129 and 130: semplice distribuzione materiale. C
- Page 131 and 132: Non s’insisterà mai abbastanza s
- Page 133 and 134: Fratelli e sorelle carissimi! In qu
- Page 135 and 136: mente evocativo e denso di memorie,
- Page 137 and 138: Discorso per l’inaugurazione dell
- Page 139 and 140: dell’antica pinacoteca donandoli
- Page 141 and 142: piano usufruire con opportune inizi
- Page 143 and 144: di apertura verso nuovi orizzonti,
- Page 145 and 146: mera rappresentazione o alla descri
- Page 147 and 148: soltanto il grido e l’esortazione
- Page 149 and 150: sorta una stampa pluralistica. A pr
- Page 151 and 152: concretamente nelle situazioni prop
- Page 153: veniva lodato e raccomandato l’us
- Page 156 and 157: piace molto cantare. Molte ore (sop
- Page 158 and 159: vicende storiche del passato, relat
- Page 160 and 161: zazione, così come l’artigiano c
- Page 162 and 163: Tessalonicesi, in cui l’autore es
- Page 164 and 165: Discorso ai cantori della Cappella
- Page 166 and 167: speranza di vittoria: la meditazion
- Page 168 and 169: del cuore umano sia in tutto il cli
- Page 170 and 171: 3. Questa esortazione, amici artist
- Page 172 and 173: terra ha rivelato i suoi segreti ai
- Page 174 and 175: esortati o ammessi a vedere, a cont
- Page 176 and 177: 3. Ponendo la precedente domanda ci
- Page 180 and 181: per questo che intendo parlare dell
- Page 182 and 183: A subirne le conseguenze sono propr
- Page 184 and 185: particolarmente suggestiva il colon
- Page 186 and 187: poeta cristiano, lo abbia prescelto
- Page 188 and 189: via, a considerarle come trascurabi
- Page 190 and 191: offuscata, o addirittura spenta, la
- Page 192 and 193: In questo senso desidero esprimere,
- Page 194 and 195: La cultura traccia le strade dell
- Page 196 and 197: ienza umana e permette di conoscerl
- Page 198 and 199: Con tali voti, a suggello del lavor
- Page 200 and 201: ispondendo con ciò a una precisa i
- Page 202 and 203: stituibile. Proprio gli strumenti d
- Page 204 and 205: impegno di difendere la dottrina de
- Page 206 and 207: 4. Così, l’uomo, come essere cul
- Page 208 and 209: zare delle scienze naturali, umane
- Page 210 and 211: Cultura di meglio rispondere ai com
- Page 212 and 213: quanti più possibile, l’annuncio
- Page 214 and 215: canto ma anche le altre forme artis
- Page 216 and 217: Non è mia intenzione, a questo pro
- Page 218 and 219: stile - grazie anche alla collabora
- Page 220 and 221: eligiosa, ancora adolescente chiese
- Page 222 and 223: Per la verità, fra Giovanni, figur
- Page 224 and 225: Discorso per l’incontro con i rap
- Page 226 and 227: nazione e anche fuori di essa. Dal
- Page 228 and 229:
Discorso al termine di un concerto
- Page 230 and 231:
per la Cultura. La vostra presenza
- Page 232 and 233:
Chiesa stessa, nella sua vita, nell
- Page 234 and 235:
non si riconoscono di nessuna relig
- Page 236 and 237:
In tal modo, se emerge, da una part
- Page 238 and 239:
gno a favore dell’umanità, diret
- Page 240 and 241:
incomprensioni reciproche, bisogna
- Page 242 and 243:
decisa e generosa risposta da parte
- Page 244 and 245:
comunicazione e l’informazione ra
- Page 246 and 247:
Mentre invoco su di voi e sugli ope
- Page 248 and 249:
che mi ha fatto conoscere tante com
- Page 250 and 251:
come il compendio dell’universo e
- Page 252 and 253:
Discorso al gruppo artistico teatra
- Page 254 and 255:
5. Vi prego di interpretare in ques
- Page 256 and 257:
seria dell’uomo. Ha bisogno dell
- Page 258 and 259:
A questo canto di lode siete, in mo
- Page 260 and 261:
che, alla competenza nell’arte mu
- Page 262 and 263:
sare, la esige e corrobora. Grande
- Page 264 and 265:
manifestarvi il mio grato apprezzam
- Page 266 and 267:
nica e conosciuta. Il vostro Consig
- Page 268 and 269:
cultura, imploro la benedizione del
- Page 270 and 271:
e la diffusione della cultura e la
- Page 272 and 273:
cui egli attese il tramonto della s
- Page 274 and 275:
« Così ogni albero buono produce
- Page 276 and 277:
Lettera apostolica a conferma del b
- Page 278 and 279:
una testimonianza della fede che pr
- Page 280 and 281:
Oggi, nell’era dell’elettronica
- Page 282 and 283:
questo dialogo tra la Chiesa e la c
- Page 284 and 285:
5. La vostra, poi, è una duplice m
- Page 286 and 287:
Messaggio per la XVIII Giornata Mon
- Page 288 and 289:
sempre a una determinata concezione
- Page 290 and 291:
strumenti rispetto alla comunicazio
- Page 292 and 293:
Discorso ai partecipanti alla secon
- Page 294 and 295:
Noi cristiani crediamo che, come ha
- Page 296 and 297:
attraversato e analizzato il gran m
- Page 298 and 299:
abbatte misteriosamente su di lui e
- Page 301 and 302:
1985 Discorso ai vescovi dell’Uru
- Page 303 and 304:
alla promozione dell’uomo. Il vos
- Page 305 and 306:
della cultura ecuadoriana e del Cen
- Page 307 and 308:
La Chiesa è convinta che il suo di
- Page 309 and 310:
elazioni di mutua fiducia, nella vi
- Page 311 and 312:
2. La conservazione di tanti sigill
- Page 313 and 314:
In questo momento voi siete sommame
- Page 315 and 316:
Messaggio per la XIX Giornata Mondi
- Page 317 and 318:
giovane entra in contatto con la re
- Page 319 and 320:
integralità: preoccupandosi cioè
- Page 321 and 322:
2. La fede accoglie il Dio vivente
- Page 323 and 324:
l’arte, essa è scoperta ed espre
- Page 325 and 326:
hanno oggi difficoltà ad accoglier
- Page 327 and 328:
2. Vedrò tra poco, cari artisti, q
- Page 329 and 330:
che confluiscono entrambe nell’un
- Page 331 and 332:
Discorso agli artisti nel Teatro La
- Page 333 and 334:
prende autocoscienza critica di sé
- Page 335 and 336:
Discorso al termine di un concerto
- Page 337 and 338:
derata come mezzo destinato a nobil
- Page 339 and 340:
Costruire la Chiesa è un’opera c
- Page 341 and 342:
chiesa del vescovo, quella in cui e
- Page 343 and 344:
La presenza di Dio, che è Spirito,
- Page 345 and 346:
sione fondamentale dell’esistenza
- Page 347 and 348:
lavoro, cui viene negata la dignit
- Page 349 and 350:
Tuttavia - nemmeno questo va diment
- Page 351 and 352:
lizzazione delle persone, dei grupp
- Page 353 and 354:
cheglisimettaunamacinagiratadaasino
- Page 355 and 356:
menti dell’uomo in canto di adora
- Page 357 and 358:
anche coloro che hanno assicurato l
- Page 359 and 360:
Essi avevano un senso acuto dell’
- Page 361 and 362:
quando riproduce e illustra monumen
- Page 363 and 364:
di opere di musica sacra esige uno
- Page 365 and 366:
Discorso ai partecipanti al Festiva
- Page 367 and 368:
nazioni il togliere il diritto alla
- Page 369 and 370:
Senza dubbio si tratta di un proble
- Page 371 and 372:
1986 Discorso all’assemblea plena
- Page 373 and 374:
Io mi rallegro di tutto cuore dell
- Page 375 and 376:
Fra le iniziative suscitate dalle d
- Page 377 and 378:
Infine, è necessaria la formazione
- Page 379 and 380:
1. In voi saluto la vitalità spiri
- Page 381 and 382:
Ciò infatti è un’eco di quanto
- Page 383 and 384:
La Chiesa cattolica a sua volta gua
- Page 385 and 386:
materiale, ma specialmente a quello
- Page 387 and 388:
fondò il « Romanum S. Bonaventura
- Page 389 and 390:
dente deve essere consapevole che i
- Page 391 and 392:
questo l’ho constatato prima, in
- Page 393 and 394:
all’inizio del secolo, considerav
- Page 395 and 396:
Seguite l’esempio e le consegne d
- Page 397 and 398:
amici artisti che brevemente hanno
- Page 399 and 400:
trova ancor oggi una palpitante esp
- Page 401 and 402:
ma anche, nel suo genere, di quel p
- Page 403 and 404:
l’assonanza di più note si crea
- Page 405 and 406:
versi famosi: « Considerate la vos
- Page 407 and 408:
Augustinum Hipponensem. Lettera apo
- Page 409 and 410:
tuoi / fan sacrificio a te, cantand
- Page 411 and 412:
L’arte vera aiuta a cogliere il m
- Page 413 and 414:
elezione, e il poeta Mario Luzi ne
- Page 415 and 416:
la cultura, oggi, qui, in questa ci
- Page 417 and 418:
presentato come la stessa verità:
- Page 419 and 420:
appresentanza così eletta e così
- Page 421 and 422:
L’antica cattedrale romanica, col
- Page 423:
gliesi. Si faccia in modo di favori
- Page 426 and 427:
privati o pubblici, e organismi int
- Page 428 and 429:
questo processo vitale si compia a
- Page 430 and 431:
terrore a una strategia della fiduc
- Page 432 and 433:
piuttosto « agire per e con » gli
- Page 434 and 435:
mendo la mia riconoscenza all’arc
- Page 436 and 437:
388 Testo originale in lingua ingle
- Page 438 and 439:
Il motivo della vostra visita odier
- Page 440 and 441:
da essa per dare una risposta a mol
- Page 442 and 443:
proiettato nel futuro e assimilato
- Page 444 and 445:
principio dell’immanenza o dell
- Page 446 and 447:
3. « Conoscerete la verità, e la
- Page 448 and 449:
6. Quest’ultimo punto mi porta a
- Page 450 and 451:
vi ringrazio e a tutti porgo il mio
- Page 452 and 453:
grandi valori, che hanno reso glori
- Page 454 and 455:
Nello stesso tempo, però, questo v
- Page 456 and 457:
L’eucaristia costituisce il centr
- Page 458 and 459:
Permettetemi di esprimere qui anche
- Page 460 and 461:
Messaggio al Meeting per l’amiciz
- Page 462 and 463:
Lettera al cardinale Franciszek Mac
- Page 464 and 465:
all’informazione, del quale il Co
- Page 466 and 467:
nella società: gli handicappati pi
- Page 468 and 469:
sione della mente e della conversio
- Page 470 and 471:
piuttosto di esortare il laicato a
- Page 472 and 473:
4. Il Concilio salutò nei legati p
- Page 474 and 475:
Spirito di Dio; la parola di Dio, a
- Page 476 and 477:
altra materia adatta, nelle sante c
- Page 478 and 479:
interessati, ma siete anche profond
- Page 480 and 481:
dignità e allo splendore del culto
- Page 483 and 484:
Discorso per l’Angelus 1988 (Citt
- Page 485 and 486:
mentalità e ispireranno i comporta
- Page 487 and 488:
Messaggio per la XXII Giornata Mond
- Page 489 and 490:
Quale che sia il modo di intervento
- Page 491 and 492:
In tal modo il patrimonio spiritual
- Page 493 and 494:
8. Nell’opera di consolidamento d
- Page 495 and 496:
Importa che il ruolo della schola e
- Page 497 and 498:
Il saluto liturgico ci ricorda un a
- Page 499 and 500:
Questa è davvero una sfida. Ma l
- Page 501 and 502:
l’Istituto Ecumenico e, in genera
- Page 503 and 504:
2. Qualcuno ha detto che il papa am
- Page 505 and 506:
abbiamo qui osservato la famosa tar
- Page 507 and 508:
isalire dalla bellezza di Maria all
- Page 509 and 510:
Basta mettere in evidenza che già
- Page 511 and 512:
isposta a questa domanda, non per i
- Page 513 and 514:
§ 2. Nell’adempimento delle sue
- Page 515 and 516:
viaggio in Alsazia del mio predeces
- Page 517 and 518:
Carissimi, mi compiaccio molto per
- Page 519 and 520:
pastorale liturgica, 89 sostenendo
- Page 521 and 522:
Christifideles laici. Esortazione a
- Page 523 and 524:
1989 Discorso all’assemblea plena
- Page 525 and 526:
Noto con soddisfazione anzitutto lo
- Page 527 and 528:
3. Malgrado ciò, allo stato attual
- Page 529 and 530:
cazione di massa: « Apri le porte
- Page 531 and 532:
ciente mettere in luce certi diritt
- Page 533 and 534:
Discorso ai partecipanti a un collo
- Page 535 and 536:
detta Soubirous, di don Bosco e di
- Page 537 and 538:
tazione naturalistica del mondo: da
- Page 539 and 540:
3. Carissimi, l’augurio che di ve
- Page 541 and 542:
Saluto al Coro Jubilate Deo di Woer
- Page 543 and 544:
4. Questa mostra, inoltre, secondo
- Page 545 and 546:
1990 Discorso all’assemblea plena
- Page 547 and 548:
5. L’America latina si prepara a
- Page 549 and 550:
Lungi dal suggerire che la Chiesa d
- Page 551 and 552:
Discorso all’assemblea plenaria d
- Page 553 and 554:
occasione di riflessione sulla pres
- Page 555 and 556:
volentieri il mio incoraggiamento,
- Page 557 and 558:
Discorso alla Nippon Television Net
- Page 559 and 560:
Discorso per la benedizione della r
- Page 561 and 562:
Siete chiamati a dare vita a una nu
- Page 563 and 564:
della cultura, così come la cultur
- Page 565 and 566:
8. Prima di concludere, vorrei torn
- Page 567 and 568:
Lettera al cardinal Paul Poupard in
- Page 569 and 570:
questa sfida, la cultura europea è
- Page 571 and 572:
isurrezione. È nella costruzione d
- Page 573 and 574:
Discorso agli artisti della Compagn
- Page 575 and 576:
Questo santuario è dedicato a Mari
- Page 577 and 578:
In terra d’Africa, rimettiamo al
- Page 579 and 580:
Insieme, per mezzo « dello spirito
- Page 581 and 582:
Ho accolto volentieri il vostro inv
- Page 583 and 584:
te responsabili, come i discepoli i
- Page 585 and 586:
2. Profitto di questa circostanza p
- Page 587 and 588:
1991 Discorso a un coro italiano e
- Page 589 and 590:
l’altro più intimamente nella fr
- Page 591 and 592:
approfondimento del battesimo, perc
- Page 593 and 594:
essere informati sugli avvenimenti
- Page 595 and 596:
Il mondo abbisogna di uomini e di d
- Page 597 and 598:
Soprattutto suscitate in ogni ambie
- Page 599 and 600:
questa aggiunta molto personale, su
- Page 601 and 602:
accanto: « Chi infatti non ama il
- Page 603 and 604:
sione. Non voglio portarlo via dall
- Page 605 and 606:
Discorso per l’incontro con i rap
- Page 607 and 608:
Discorso per l’udienza generale (
- Page 609 and 610:
Il mio ringraziamento va parimenti
- Page 611:
Discorso per l’udienza generale (
- Page 614 and 615:
3. Da molti anni, una nuova Europa
- Page 616 and 617:
nizzazione ». E un altro, proprio
- Page 618 and 619:
Questa mostra cerca di illustrare s
- Page 620 and 621:
In questo giorno, noi celebriamo i
- Page 622 and 623:
A questo proposito, in occasione de
- Page 624 and 625:
Discorso all’assemblea plenaria d
- Page 626 and 627:
la vita. È importante che gli oper
- Page 628 and 629:
Discorso per l’udienza generale (
- Page 630 and 631:
ecclesiale italiana sarà sempre li
- Page 632 and 633:
annuale circostanza vi sono i doni,
- Page 634 and 635:
compito di proclamare le verità e
- Page 636 and 637:
luppare il dialogo della Chiesa col
- Page 638 and 639:
Tutto quanto è stabilito con il pr
- Page 640 and 641:
mento di multiformi attività pasto
- Page 642 and 643:
Il valore profetico della musica, i
- Page 644 and 645:
materiali; diedero loro forma, cosi
- Page 646 and 647:
Nel corso di questa bella manifesta
- Page 648 and 649:
è proiettata anche in America nell
- Page 650 and 651:
2. Un particolare interesse riveste
- Page 652 and 653:
famiglie fino a modellare i loro at
- Page 654 and 655:
questi temi in maniera responsabile
- Page 656 and 657:
quelle dello Stato, affinché la no
- Page 658 and 659:
un’espressione più soave e favor
- Page 660 and 661:
Solo tre anni dopo la promulgazione
- Page 662 and 663:
Discorso per la visita pastorale ne
- Page 664 and 665:
Discorso all’assemblea plenaria d
- Page 666 and 667:
impulso all’attività dei cristia
- Page 668 and 669:
Discorso ai rappresentanti delle co
- Page 670 and 671:
cappella la sua originale freschezz
- Page 672 and 673:
maestà del Creatore, come quella d
- Page 674 and 675:
Lettera a monsignor Jacques Perrier
- Page 676 and 677:
seguente a Parenzo (Porec), in Istr
- Page 678 and 679:
di santità del fondatore e per cor
- Page 680 and 681:
Incisivo ed esemplare fu il contrib
- Page 682 and 683:
Sono persuaso che il Touring Club,
- Page 684 and 685:
della Chiesa, ha spesso affrontato
- Page 686 and 687:
Mentre non si è ancora spenta l’
- Page 688 and 689:
Discorso all’assemblea plenaria d
- Page 690 and 691:
poiché essi sostengono la sfida qu
- Page 692 and 693:
polare e l’amore alla patria. A q
- Page 694 and 695:
manifestazioni della cultura di un
- Page 696 and 697:
vazione », presente nella qualific
- Page 698 and 699:
fare fin d’ora una qualche esperi
- Page 700 and 701:
prezioso da custodire per tutta la
- Page 703 and 704:
1996 Messaggio per la XXX Giornata
- Page 705 and 706:
propri familiari, a essere consumat
- Page 707 and 708:
Discorso durante la visita alla cat
- Page 709 and 710:
iniziative che lo favoriscano e dan
- Page 711 and 712:
terribili tormenti della flagellazi
- Page 713 and 714:
lizzazione viene rafforzata da una
- Page 715 and 716:
fusione delle scienze tra le giovan
- Page 717 and 718:
Discorso ai dirigenti e alle maestr
- Page 719 and 720:
mondo, i cristiani di oggi possono
- Page 721 and 722:
cultura, che egli ha saputo attuare
- Page 723 and 724:
stamentari affidano Maria alla nost
- Page 725 and 726:
stendo a così assurda imposizione,
- Page 727 and 728:
costruzione. La nascita di un figli
- Page 729 and 730:
E come dimenticare, poi, tra i mass
- Page 731 and 732:
Discorso per l’Angelus (Città de
- Page 733 and 734:
sistematica collaborazione interdis
- Page 735 and 736:
luogo e di ogni cultura - un’inco
- Page 737 and 738:
Sì, la bellezza, incarnazione dell
- Page 739:
Penso in questi giorni anche a tutt
- Page 742 and 743:
Inoltre, nei media sembra diminuire
- Page 744 and 745:
missione della Chiesa di proclamare
- Page 746 and 747:
pastori di anime devono vigilare at
- Page 748 and 749:
due millenni nelle situazioni cultu
- Page 750 and 751:
darietà così radicati nella vostr
- Page 752 and 753:
Discorso ai membri del James Madiso
- Page 754 and 755:
della nuova alleanza. Tale comunit
- Page 756 and 757:
nella chiesa ravennate di San Franc
- Page 758 and 759:
Alle antiche vestigia si aggiungono
- Page 760 and 761:
pubbliche autorità, si stanno prod
- Page 762 and 763:
l’intento fosse felicemente raggi
- Page 764 and 765:
Discorso per l’Angelus (Città de
- Page 766 and 767:
dei modelli di santità proposti ai
- Page 768 and 769:
Accanto a pellicole che hanno un pi
- Page 770 and 771:
invece, da missionari sconosciuti,
- Page 773 and 774:
Discorso alla cittadinanza (Annifo,
- Page 775 and 776:
Discorso alla Pontificia Commission
- Page 777 and 778:
Messaggio per la XXXII Giornata Mon
- Page 779 and 780:
speranza dallo Spirito Santo, « l
- Page 781 and 782:
zione della Chiesa dovrebbe essere
- Page 783 and 784:
da parte della Chiesa del ruolo dei
- Page 785 and 786:
conforme alle disposizioni liturgic
- Page 787 and 788:
Pertanto, con la presente lettera t
- Page 789 and 790:
umana e a non prefiggersi mete trop
- Page 791 and 792:
sentanti del mondo della cultura e
- Page 793 and 794:
Dio ha preparato per ogni essere um
- Page 795 and 796:
Saluto al presidente della Repubbli
- Page 797 and 798:
matografica. Senso estetico, esigen
- Page 799 and 800:
loro fantasia, araldi di civiltà e
- Page 801 and 802:
1999 Discorso agli addetti all’Ar
- Page 803 and 804:
proclamazione, da parte della Chies
- Page 805 and 806:
certi punti il contrasto è molto f
- Page 807 and 808:
la, quando la grazia del grande giu
- Page 809 and 810:
potente. L’artefice, invece, util
- Page 811 and 812:
di scultore, di architetto, di musi
- Page 813 and 814:
sapersi esprimere che con balbettam
- Page 815 and 816:
essere usata, nella logica del segn
- Page 817 and 818:
Verso un rinnovato dialogo 10. È v
- Page 819 and 820:
tropoli, una nuova generazione di a
- Page 821 and 822:
tale da destare in esse lo stupore!
- Page 823 and 824:
in varie nazioni, sapientemente coo
- Page 825 and 826:
santo, tu ci edifichi come tempio v
- Page 827 and 828:
ghiere della celebrazione nove volt
- Page 829 and 830:
di un edificio spirituale » 4 ed
- Page 831 and 832:
2. C’incontriamo tra le mura di u
- Page 833 and 834:
Discorso per la benedizione della B
- Page 835 and 836:
provenienti dal nord Europa e le ri
- Page 837 and 838:
a elevarsi alla contemplazione dell
- Page 839 and 840:
che, a vario titolo, hanno collabor
- Page 841 and 842:
vostri padri e di tutti voi, che ma
- Page 843 and 844:
Deve perseguire una sintesi fra uni
- Page 845 and 846:
Discorso per l’udienza generale (
- Page 847 and 848:
3. L’umanesimo cristiano può ess
- Page 849 and 850:
Auguro di cuore che il vostro lavor
- Page 851 and 852:
Discorso in occasione della cerimon
- Page 853 and 854:
È il volto di chi è ben consapevo
- Page 855 and 856:
Fulvio Vento, e l’amministratore
- Page 857:
Che il vostro canto sia sempre nuov
- Page 860 and 861:
Giudea e la Samaria e fino agli est
- Page 862 and 863:
Proclamare Cristo non è solo un do
- Page 864 and 865:
Cristo è diventato spesso un estra
- Page 866 and 867:
2. Quando, sul finire del XVIII sec
- Page 868 and 869:
lare evidenza nello splendore di qu
- Page 870 and 871:
intera. In esse accolto, ogni membr
- Page 872 and 873:
Dio tra i credenti, ha sostenuto la
- Page 874 and 875:
ano le frontiere, le culture e le g
- Page 876 and 877:
Lettera a monsignor Jorge María Me
- Page 878 and 879:
di Gesù, la Pentecoste hanno forni
- Page 880 and 881:
opera la grande famiglia umana. Abb
- Page 882 and 883:
Chiesa sia davvero un segno levato
- Page 884 and 885:
apostolica, che volentieri estendo
- Page 886 and 887:
Soprattutto coloro, tra voi, che so
- Page 888 and 889:
stanza la mia stima e il mio compia
- Page 890 and 891:
hanno sviluppato un vasto e commove
- Page 892 and 893:
possibile accessibile a un numero m
- Page 894 and 895:
espressioni nei nostri patrimonî c
- Page 896 and 897:
848 Testo originale in lingua itali
- Page 898 and 899:
quando il mio venerato predecessore
- Page 900 and 901:
tutti gli uomini di buona volontà,
- Page 902 and 903:
Discorso all’assemblea plenaria d
- Page 904 and 905:
Discorso di benvenuto nel palazzo p
- Page 906 and 907:
Discorso a una delegazione bulgara
- Page 908 and 909:
Grande, in effetti, è stato il con
- Page 910 and 911:
Saluto, inoltre, con profonda stima
- Page 912 and 913:
va l’uomo, essi ci aiutavano a pe
- Page 914 and 915:
confini dell’essere ». 23 Chi lo
- Page 916 and 917:
Discorso per l’udienza generale (
- Page 918 and 919:
Discorso per l’incontro con i rap
- Page 920 and 921:
dell’Occidente appaiono fascinosi
- Page 922 and 923:
Discorso ai partecipanti al Congres
- Page 924 and 925:
l’inculturazione significò un nu
- Page 926 and 927:
comprensione e una presentazione de
- Page 928 and 929:
Signore, e non prendessimo sul seri
- Page 930 and 931:
Discorso agli artisti che partecipa
- Page 932 and 933:
Messaggio per la XXXVI Giornata Mon
- Page 934 and 935:
La comprensione e la saggezza sono
- Page 936 and 937:
della Madonna della Fiducia sull’
- Page 938 and 939:
i vetusti monumenti della Chiesa si
- Page 940 and 941:
Discorso all’assemblea plenaria d
- Page 942 and 943:
sono impegnati nell’opera del Pon
- Page 944 and 945:
della facciata della basilica, rico
- Page 946 and 947:
Discorso ai rappresentanti delle re
- Page 948 and 949:
Per il tramite dei loro discepoli,
- Page 950 and 951:
Auguro alla Bulgaria, il bel paese
- Page 952 and 953:
guarda con fiducia al futuro, nel q
- Page 954 and 955:
sione ha progressivamente esteso i
- Page 956 and 957:
ne e occasione di gioia e di sereni
- Page 958 and 959:
tanti bei monumenti architettonici
- Page 960 and 961:
vengono condivise e le persone poss
- Page 962 and 963:
questa giornata mondiale delle comu
- Page 964 and 965:
È stato così, ad esempio, per l
- Page 966 and 967:
zione e poi ad altre parti del mond
- Page 968 and 969:
La cattedrale, difatti, è il luogo
- Page 970 and 971:
Chirografo per il centenario del mo
- Page 972 and 973:
questo, « non indistintamente tutt
- Page 974 and 975:
iguardanti la riforma liturgica, il
- Page 976 and 977:
È dunque necessaria una rinnovata
- Page 978 and 979:
Discorso a conclusione di un concer
- Page 980 and 981:
Formulo fervidi auspici affinché p
- Page 982 and 983:
Con tali sentimenti invio a lei, ai
- Page 984 and 985:
gono, che ogni comunicazione ha una
- Page 986 and 987:
molto arricchita. Anche ai bambini
- Page 988 and 989:
Discorso per l’udienza generale (
- Page 990 and 991:
di un’università statale, ero co
- Page 992 and 993:
Discorso al Pontificio Seminario Ro
- Page 994 and 995:
sono testimonianza i fenomeni cultu
- Page 996 and 997:
punto della sua vita ruppe con l’
- Page 998 and 999:
Lettera a monsignor Heinz Josef Alg
- Page 1000 and 1001:
orientamento la propria esperienza
- Page 1002 and 1003:
il cuore ti accompagneremo lungo il
- Page 1004 and 1005:
Sono lieto che, grazie alla vostra
- Page 1006 and 1007:
Lettera a monsignor Carlo Ghidelli,
- Page 1008 and 1009:
Mane nobiscum. Lettera apostolica p
- Page 1010 and 1011:
È quanto chiede Gesù ai suoi disc
- Page 1012 and 1013:
prezioso reso alla comunità cristi
- Page 1015 and 1016:
2005 Discorso ai rappresentanti del
- Page 1017 and 1018:
sostegno possibile. In questo modo
- Page 1019 and 1020:
La nostra è un’epoca di comunica
- Page 1021 and 1022:
della dignità della persona umana
- Page 1023 and 1024:
Il positivo sviluppo dei media a se
- Page 1025 and 1026:
Figlio ». 23 Parola eterna fatta c
- Page 1027 and 1028:
La Vergine Madre di Dio, donna euca
- Page 1029 and 1030:
LEGGE SUGLI ARCHIVI DELLA SANTA SED
- Page 1031 and 1032:
Valorizzazione: ogni attività dire
- Page 1033 and 1034:
proposti, e collabora con gli organ
- Page 1035 and 1036:
Capo III Organi di controllo Art. 1
- Page 1037 and 1038:
Art. 20 - Accesso al protocollo e a
- Page 1039 and 1040:
2. Le modalità operative della dup
- Page 1041 and 1042:
to degli stessi, sono assunti e inq
- Page 1043 and 1044:
zione della non consultabilità di
- Page 1045 and 1046:
ELENCO DELLE CHIESE ELEVATE AL GRAD
- Page 1047 and 1048:
Data Titolo Citazione 18 giugno 198
- Page 1049 and 1050:
Data Titolo Citazione 9 agosto 1982
- Page 1051 and 1052:
Data Titolo Citazione 25 marzo 1985
- Page 1053 and 1054:
Data Titolo Citazione 11 dicembre 1
- Page 1055 and 1056:
Data Titolo Citazione 7 giugno 1989
- Page 1057 and 1058:
Data Titolo Citazione 10 luglio 199
- Page 1059 and 1060:
Data Titolo Citazione 25 aprile 199
- Page 1061 and 1062:
Data Titolo Citazione 15 ottobre 19
- Page 1063 and 1064:
Data Titolo Citazione 18 febbraio 1
- Page 1065 and 1066:
Data Titolo Citazione 24 gennaio 19
- Page 1067 and 1068:
Data Titolo Citazione 8 settembre 1
- Page 1069 and 1070:
ELENCO DELLE IMMAGINI MARIANE INCOR
- Page 1071 and 1072:
Data Titolo Citazione 13 febbraio 1
- Page 1073 and 1074:
Data Titolo Citazione 23 febbraio 1
- Page 1075 and 1076:
Data Titolo Citazione 19 luglio 199
- Page 1077:
Data Titolo Citazione 4 aprile 1998
- Page 1080 and 1081:
Lettere apostoliche Amantissima pro
- Page 1082 and 1083:
Chirografo per il centenario del mo
- Page 1084 and 1085:
Discorso per l’inaugurazione dell
- Page 1086 and 1087:
Discorso al termine di un concerto
- Page 1088 and 1089:
Discorso ai soci del Pio Sodalizio
- Page 1090 and 1091:
Discorso al termine di un concerto
- Page 1092 and 1093:
Messaggio alle Nazioni Unite 26 ago
- Page 1094 and 1095:
Discorso per il Regina Coeli 3 magg
- Page 1096 and 1097:
Discorso per l’incontro con il mo
- Page 1099:
INDICI
- Page 1102 and 1103:
Sof 3,14-15 836 Sof 3,16 791 Sof 3,
- Page 1104 and 1105:
Ef 2,4 783 Ef 2,10 430 Ef 2,14 969
- Page 1106 and 1107:
1058 Dei Verbum, 9 426 Dei Verbum,
- Page 1108 and 1109:
1060 Discorso ai vescovi toscani in
- Page 1110 and 1111:
Slavorum apostoli, 18 901 Slavorum
- Page 1112 and 1113:
Pontificio Consiglio della Cultura
- Page 1114 and 1115:
Cassino 938 Castel Gandolfo 231, 24
- Page 1116 and 1117:
Montecassino 23-24, 59, 103, 237, 7
- Page 1118 and 1119:
Vitebsk 650 Vukovar 563 Washington
- Page 1120 and 1121:
Benedetto XIV 360, 923 Benedetto XV
- Page 1122 and 1123:
Francesco di Sales (s.) 187-189, 64
- Page 1124 and 1125:
Maderno Carlo 250, 386, 768, 789 Ma
- Page 1126 and 1127:
Poupard Paul 217, 254, 437, 478, 49
- Page 1128 and 1129:
Wujek Jakub 31 Wyszynski Stefan 237
- Page 1130 and 1131:
- sacra, 34-35, 55, 120-123, 143, 1
- Page 1132 and 1133:
- di Santa Caterina a Betlemme, 873
- Page 1134 and 1135:
dischi, 39, 52, 268, 381 discografi
- Page 1136 and 1137:
Ministero dei Beni Culturali (Itali
- Page 1138 and 1139:
- Consiglio per il Dialogo con i no
- Page 1140 and 1141:
Unione Cattolica Italiana Insegnant
- Page 1142:
Elenco delle chiese elevate alla di