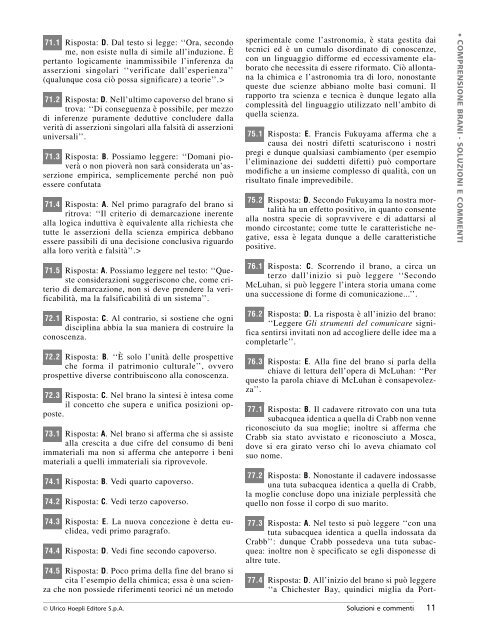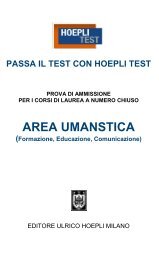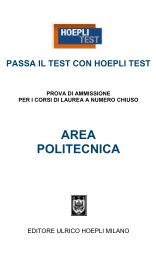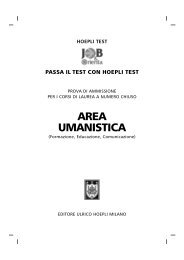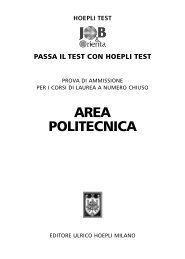Download Commenti (PDF) - HOEPLITest.it
Download Commenti (PDF) - HOEPLITest.it
Download Commenti (PDF) - HOEPLITest.it
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
71.1 Risposta: D. Daltestosilegge:‘‘Ora,secondo<br />
me, non esiste nulla di simile all’induzione. È<br />
pertanto logicamente inammissibile l’inferenza da<br />
asserzioni singolari ‘‘verificate dall’esperienza’’<br />
(qualunque cosa ciò possa significare) a teorie’’.><br />
71.2 Risposta: D. Nell’ultimo capoverso del brano si<br />
trova: ‘‘Di conseguenza è possibile, per mezzo<br />
di inferenze puramente deduttive concludere dalla<br />
ver<strong>it</strong>à di asserzioni singolari alla fals<strong>it</strong>à di asserzioni<br />
universali’’.<br />
71.3 Risposta: B. Possiamo leggere: ‘‘Domani pioverà<br />
ononpioverànon sarà considerata un’asserzione<br />
empirica, semplicemente perché non può<br />
essere confutata<br />
71.4 Risposta: A. Nel primo paragrafo del brano si<br />
r<strong>it</strong>rova: ‘‘Il cr<strong>it</strong>erio di demarcazione inerente<br />
alla logica induttiva è equivalente alla richiesta che<br />
tutte le asserzioni della scienza empirica debbano<br />
essere passibili di una decisione conclusiva riguardo<br />
alla loro ver<strong>it</strong>à e fals<strong>it</strong>à’’.><br />
71.5 Risposta: A. Possiamo leggere nel testo: ‘‘Queste<br />
considerazioni suggeriscono che, come cr<strong>it</strong>erio<br />
di demarcazione, non si deve prendere la verificabil<strong>it</strong>à,<br />
ma la falsificabil<strong>it</strong>à di un sistema’’.<br />
72.1 Risposta: C. Al contrario, si sostiene che ogni<br />
disciplina abbia la sua maniera di costruire la<br />
conoscenza.<br />
72.2 Risposta: B. ‘‘Èsolo l’un<strong>it</strong>à delle prospettive<br />
che forma il patrimonio culturale’’, ovvero<br />
prospettive diverse contribuiscono alla conoscenza.<br />
72.3 Risposta: C. Nel brano la sintesi è intesa come<br />
il concetto che supera e unifica posizioni opposte.<br />
73.1 Risposta: A. Nel brano si afferma che si assiste<br />
alla cresc<strong>it</strong>a a due cifre del consumo di beni<br />
immateriali ma non si afferma che anteporre i beni<br />
materiali a quelli immateriali sia riprovevole.<br />
74.1 Risposta: B. Vedi quarto capoverso.<br />
74.2 Risposta: C. Vedi terzo capoverso.<br />
74.3 Risposta: E. La nuova concezione è detta euclidea,<br />
vedi primo paragrafo.<br />
74.4 Risposta: D. Vedi fine secondo capoverso.<br />
74.5 Risposta: D. Poco prima della fine del brano si<br />
c<strong>it</strong>a l’esempio della chimica; essa è una scienza<br />
che non possiede riferimenti teorici né un metodo<br />
sperimentale come l’astronomia, è stata gest<strong>it</strong>a dai<br />
tecnici ed è un cumulo disordinato di conoscenze,<br />
con un linguaggio difforme ed eccessivamente elaborato<br />
che necess<strong>it</strong>a di essere riformato. Ciò allontana<br />
la chimica e l’astronomia tra di loro, nonostante<br />
queste due scienze abbiano molte basi comuni. Il<br />
rapporto tra scienza e tecnica è dunque legato alla<br />
compless<strong>it</strong>à del linguaggio utilizzato nell’amb<strong>it</strong>o di<br />
quella scienza.<br />
75.1 Risposta: E. Francis Fukuyama afferma che a<br />
causa dei nostri difetti scaturiscono i nostri<br />
pregi e dunque qualsiasi cambiamento (per esempio<br />
l’eliminazione dei suddetti difetti) può comportare<br />
modifiche a un insieme complesso di qual<strong>it</strong>à, conun<br />
risultato finale imprevedibile.<br />
75.2 Risposta: D. Secondo Fukuyama la nostra mortal<strong>it</strong>à<br />
ha un effetto pos<strong>it</strong>ivo, in quanto consente<br />
alla nostra specie di sopravvivere e di adattarsi al<br />
mondo circostante; come tutte le caratteristiche negative,<br />
essa è legata dunque a delle caratteristiche<br />
pos<strong>it</strong>ive.<br />
76.1 Risposta: C. Scorrendo il brano, a circa un<br />
terzo dall’inizio si può leggere ‘‘Secondo<br />
McLuhan, si può leggerel’interastoriaumanacome<br />
una successione di forme di comunicazione...’’.<br />
76.2 Risposta: D. Larispostaèall’inizio del brano:<br />
‘‘Leggere Gli strumenti del comunicare significa<br />
sentirsi inv<strong>it</strong>ati non ad accogliere delle idee ma a<br />
completarle’’.<br />
76.3 Risposta: E. Alla fine del brano si parla della<br />
chiave di lettura dell’opera di McLuhan: ‘‘Per<br />
questo la parola chiave di McLuhan è consapevolezza’’.<br />
77.1 Risposta: B. Il cadavere r<strong>it</strong>rovato con una tuta<br />
subacquea identica a quella di Crabb non venne<br />
riconosciuto da sua moglie; inoltre si afferma che<br />
Crabb sia stato avvistato e riconosciuto a Mosca,<br />
dove si era girato verso chi lo aveva chiamato col<br />
suo nome.<br />
77.2 Risposta: B. Nonostante il cadavere indossasse<br />
una tuta subacquea identica a quella di Crabb,<br />
la moglie concluse dopo una iniziale perpless<strong>it</strong>à che<br />
quello non fosse il corpo di suo mar<strong>it</strong>o.<br />
77.3 Risposta: A. Neltestosipuòleggere ‘‘con una<br />
tuta subacquea identica a quella indossata da<br />
Crabb’’: dunque Crabb possedeva una tuta subacquea:<br />
inoltre non è specificato se egli disponesse di<br />
altre tute.<br />
77.4 Risposta: D. All’inizio del brano si può leggere<br />
‘‘a Chichester Bay, quindici miglia da Port-<br />
§ Ulrico Hoepli Ed<strong>it</strong>ore S.p.A. Soluzioni e commenti 11<br />
« COMPRENSIONE BRANI - SOLUZIONI E COMMENTI