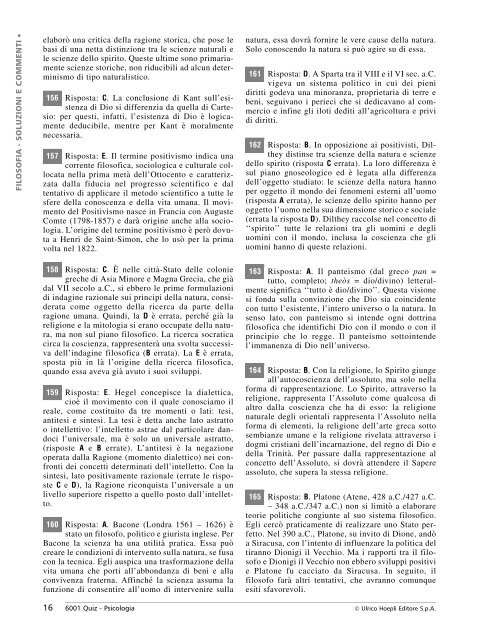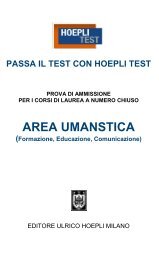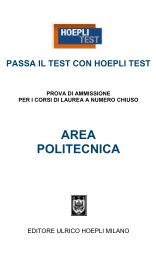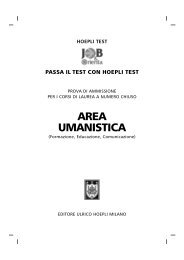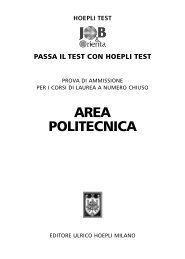Download Commenti (PDF) - HOEPLITest.it
Download Commenti (PDF) - HOEPLITest.it
Download Commenti (PDF) - HOEPLITest.it
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
FILOSOFIA - SOLUZIONI E COMMENTI «<br />
elaborò una cr<strong>it</strong>ica della ragione storica, che pose le<br />
basi di una netta distinzione tra le scienze naturali e<br />
le scienze dello spir<strong>it</strong>o. Queste ultime sono primariamente<br />
scienze storiche, non riducibili ad alcun determinismo<br />
di tipo naturalistico.<br />
156 Risposta: C. La conclusione di Kant sull’esistenza<br />
di Dio si differenzia da quella di Cartesio:<br />
per questi, infatti, l’esistenza di Dio è logicamente<br />
deducibile, mentre per Kant è moralmente<br />
necessaria.<br />
157 Risposta: E. Il termine pos<strong>it</strong>ivismo indica una<br />
corrente filosofica, sociologica e culturale collocata<br />
nella prima metà dell’Ottocento e caratterizzata<br />
dalla fiducia nel progresso scientifico e dal<br />
tentativo di applicare il metodo scientifico a tutte le<br />
sfere della conoscenza e della v<strong>it</strong>a umana. Il movimento<br />
del Pos<strong>it</strong>ivismo nasce in Francia con Auguste<br />
Comte (1798-1857) e darà origine anche alla sociologia.<br />
L’origine del termine pos<strong>it</strong>ivismo è però dovutaaHenrideSaint-Simon,chelousòper<br />
la prima<br />
volta nel 1822.<br />
158 Risposta: C. Ènelle c<strong>it</strong>tà-Stato delle colonie<br />
greche di Asia Minore e Magna Grecia, che già<br />
dal VII secolo a.C., si ebbero le prime formulazioni<br />
di indagine razionale sui principi della natura, considerata<br />
come oggetto della ricerca da parte della<br />
ragione umana. Quindi, la D è errata, perché già la<br />
religione e la m<strong>it</strong>ologia si erano occupate della natura,<br />
ma non sul piano filosofico. La ricerca socratica<br />
circa la coscienza, rappresenterà una svolta successiva<br />
dell’indagine filosofica (B errata). La E è errata,<br />
sposta più in là l’origine della ricerca filosofica,<br />
quando essa aveva già avuto i suoi sviluppi.<br />
159 Risposta: E. Hegel concepisce la dialettica,<br />
cioè il movimento con il quale conosciamo il<br />
reale, come cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o da tre momenti o lati: tesi,<br />
ant<strong>it</strong>esi e sintesi. La tesi è detta anche lato astratto<br />
o intellettivo: l’intelletto astrae dal particolare dandoci<br />
l’universale, ma è solo un universale astratto,<br />
(risposte A e B errate). L’ant<strong>it</strong>esi è la negazione<br />
operata dalla Ragione (momento dialettico) nei confronti<br />
dei concetti determinati dell’intelletto. Con la<br />
sintesi, lato pos<strong>it</strong>ivamente razionale (errate le risposte<br />
C e D), la Ragione riconquista l’universale a un<br />
livello superiore rispetto a quello posto dall’intelletto.<br />
160 Risposta: A. Bacone (Londra 1561 – 1626) è<br />
stato un filosofo, pol<strong>it</strong>ico e giurista inglese. Per<br />
Bacone la scienza ha una util<strong>it</strong>à pratica. Essa può<br />
creare le condizioni di intervento sulla natura, se fusa<br />
con la tecnica. Egli auspica una trasformazione della<br />
v<strong>it</strong>a umana che porti all’abbondanza di beni e alla<br />
convivenza fraterna. Affinché la scienza assuma la<br />
funzione di consentire all’uomo di intervenire sulla<br />
natura, essa dovrà fornire le vere cause della natura.<br />
Solo conoscendo la natura si può agire su di essa.<br />
161 Risposta: D. ASpartatrailVIIIeilVIsec.a.C.<br />
vigeva un sistema pol<strong>it</strong>ico in cui dei pieni<br />
dir<strong>it</strong>ti godeva una minoranza, proprietaria di terre e<br />
beni, seguivano i perieci che si dedicavano al commercio<br />
e infine gli iloti ded<strong>it</strong>i all’agricoltura e privi<br />
di dir<strong>it</strong>ti.<br />
162 Risposta: B. In opposizione ai pos<strong>it</strong>ivisti, Dilthey<br />
distinse tra scienze della natura e scienze<br />
dello spir<strong>it</strong>o (risposta C errata). La loro differenza è<br />
sul piano gnoseologico ed è legata alla differenza<br />
dell’oggetto studiato: le scienze della natura hanno<br />
per oggetto il mondo dei fenomeni esterni all’uomo<br />
(risposta A errata), le scienze dello spir<strong>it</strong>o hanno per<br />
oggetto l’uomo nella sua dimensione storico e sociale<br />
(errata la risposta D). Dilthey raccolse nel concetto di<br />
‘‘spir<strong>it</strong>o’’ tutte le relazioni tra gli uomini e degli<br />
uomini con il mondo, inclusa la coscienza che gli<br />
uomini hanno di queste relazioni.<br />
163 Risposta: A. Il panteismo (dal greco pan =<br />
tutto, completo; theòs = dio/divino) letteralmente<br />
significa ‘‘tutto è dio/divino’’. Questa visione<br />
si fonda sulla convinzione che Dio sia coincidente<br />
con tutto l’esistente, l’intero universo o la natura. In<br />
senso lato, con panteismo si intende ogni dottrina<br />
filosofica che identifichi Dio con il mondo o con il<br />
principio che lo regge. Il panteismo sottointende<br />
l’immanenza di Dio nell’universo.<br />
164 Risposta: B. Con la religione, lo Spir<strong>it</strong>o giunge<br />
all’autocoscienza dell’assoluto, ma solo nella<br />
forma di rappresentazione. Lo Spir<strong>it</strong>o, attraverso la<br />
religione, rappresenta l’Assoluto come qualcosa di<br />
altro dalla coscienza che ha di esso: la religione<br />
naturale degli orientali rappresenta l’Assoluto nella<br />
forma di elementi, la religione dell’arte greca sotto<br />
sembianze umane e la religione rivelata attraverso i<br />
dogmi cristiani dell’incarnazione, del regno di Dio e<br />
della Trin<strong>it</strong>à. Per passare dalla rappresentazione al<br />
concetto dell’Assoluto, si dovrà attendere il Sapere<br />
assoluto, che supera la stessa religione.<br />
165 Risposta: B. Platone (Atene, 428 a.C./427 a.C.<br />
– 348 a.C./347 a.C.) non si lim<strong>it</strong>ò aelaborare<br />
teorie pol<strong>it</strong>iche congiunte al suo sistema filosofico.<br />
Egli cercò praticamente di realizzare uno Stato perfetto.<br />
Nel 390 a.C., Platone, su inv<strong>it</strong>o di Dione, andò<br />
a Siracusa, con l’intento di influenzare la pol<strong>it</strong>ica del<br />
tiranno Dionigi il Vecchio. Ma i rapporti tra il filosofo<br />
e Dionigi il Vecchio non ebbero sviluppi pos<strong>it</strong>ivi<br />
e Platone fu cacciato da Siracusa. In segu<strong>it</strong>o, il<br />
filosofo farà altri tentativi, che avranno comunque<br />
es<strong>it</strong>i sfavorevoli.<br />
16 6001 Quiz - Psicologia § Ulrico Hoepli Ed<strong>it</strong>ore S.p.A.