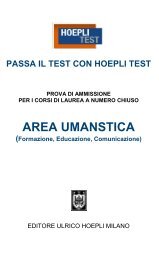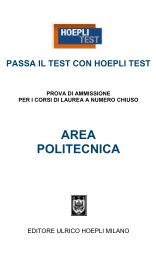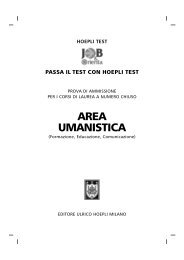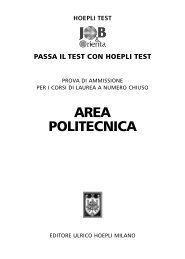Download Commenti (PDF) - HOEPLITest.it
Download Commenti (PDF) - HOEPLITest.it
Download Commenti (PDF) - HOEPLITest.it
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
FISICA - SOLUZIONI E COMMENTI «<br />
168 Risposta: D. La zavorra cadendo al suolo si<br />
muove di moto uniformemente accelerato<br />
(consideriamo il nostro sistema di riferimento con<br />
origine nel punto in cui viene rilasciato il peso, e asse<br />
y rivolto verso il basso), caratterizzato dalle seguenti<br />
equazioni: (<br />
s¼s 0þv 0 tþg t 2<br />
2<br />
v ¼ v0 þ g t<br />
Sost<strong>it</strong>uendo i dati si ottiene dalla prima equazione<br />
otteniamo: 80 ¼ 12 t þ 5 t 2 ! t ¼ 5; 4s (la veloc<strong>it</strong>à<br />
iniziale è indicata con segno negativo in quanto<br />
avente verso opposto all’accelerazione a cui è soggetto<br />
il peso).<br />
169 Risposta: E. Una trasformazione isoentropica<br />
in termodinamica denota un tipo di trasformazione<br />
che avviene a entropia costante. Viene denotata<br />
con questo nome una trasformazione adiabatica reversibile.<br />
La trasformazione isoentropica è un caso ideale, un<br />
caso lim<strong>it</strong>e. Nella realtà, e cioè per macchine che<br />
svolgono trasformazioni irreversibili, l’entropia tende<br />
ad aumentare per la presenza di irreversibil<strong>it</strong>à,<br />
derivanti da fenomeni dissipativi come l’attr<strong>it</strong>o, oppure<br />
legate alla presenza di reazioni chimiche presenti<br />
nel sistema.<br />
170 Risposta: A. Laforzaèattrattiva poiché idue<br />
campi sono orientati in una direzione di concatenamento,<br />
il campo è ortogonale a entrambi i fili.<br />
171 Risposta: E. La forza di Archimede (o spinta<br />
idrostatica) è defin<strong>it</strong>a come: FA ¼ flu gV,<br />
dove flu è la dens<strong>it</strong>à del fluido in cui il corpo viene<br />
immerso, g l’accelerazione di grav<strong>it</strong>à e V il volume di<br />
liquido spostato. Tale forza è linearmente dipendente<br />
dall’accelerazione di grav<strong>it</strong>à, che sulla terra è espressa<br />
da g, mentre sulla luna è circaunsesto:laspinta<br />
idrostatica sulla Luna sarà quindi un sesto rispetto a<br />
quella terrestre.<br />
172 Risposta: D. Il calore da somministrare corrisponde<br />
al prodotto tra massa del corpo e suo<br />
calore specifico e delta di temperatura che si vuole<br />
coprire: Q ¼ m c T ¼ 10 0; 2 50 ¼ 100 kcal.<br />
173 Risposta: B. Si definisce capac<strong>it</strong>à termica di un<br />
corpo (o più in generale di un qualunque sistema)<br />
il rapporto fra il calore scambiato tra il corpo e<br />
l’ambiente e la variazione di temperatura che ne<br />
consegue: C ¼ Q=T; se la quant<strong>it</strong>à di calore forn<strong>it</strong>a<br />
è la stessa per i due corpi, e questi hanno la medesima<br />
capac<strong>it</strong>à termica, ne consegue che la variazione di<br />
temperatura sarà uguale per entrambi.<br />
174 Risposta: B. Per definizione di newton esso<br />
imprime un’accelerazione di 1 m/s 2 aunamassa<br />
di 1 kg.<br />
175 Risposta: E. Il treno si muove verso ovest alla<br />
veloc<strong>it</strong>à di 36 km/h, ovvero 10 m/s; il bambino<br />
corre in direzione opposta a 3 m/s, per cui sommando<br />
le due veloc<strong>it</strong>à egli si muove verso ovest a 7 m/s. La<br />
veloc<strong>it</strong>à è percep<strong>it</strong>a dall’osservatore solidale alle<br />
rotaie (quindi fermo) come differenza tra le due<br />
velec<strong>it</strong>à, in quanto aventi verso opposto.<br />
176 Risposta: D. Calore iniziale = calore dei due<br />
masse – parte calore latente = 60 l 0,1 + 0 l 0–<br />
X l 80 l 0,1=6–Xl 8 = calore finale: la frazione X di<br />
ghiaccio che cambia di fase raffredda la temperatura<br />
fino alla temperatura di fusione.<br />
177 Risposta: C. In fisica l’elettronvolt (simbolo<br />
eV) è un’un<strong>it</strong>à di misura dell’energia, molto<br />
usata in amb<strong>it</strong>o atomico e subatomico, defin<strong>it</strong>o come<br />
l’energia cinetica acquistata da un elettrone quando è<br />
accelerato da una differenza di potenziale elettrico di<br />
1 volt nel vuoto. Sotto l’azione di 10 volt, l’energia<br />
acquis<strong>it</strong>a è quindi di 10 eV.<br />
178 Risposta: A. Il voltmetro è uno strumento per la<br />
misura della differenza di potenziale elettrico<br />
tra due punti di un circu<strong>it</strong>o. L’elettroscopio permette<br />
di riconoscere se un corpo è carico elettricamente,<br />
senza però quantificarne la carica elettrica, l’amperometro<br />
misura le correnti elettriche, il calorimetro è<br />
un dispos<strong>it</strong>ivo utilizzato per misurazioni sul calore e,<br />
infine, il galvanometro è uno strumento che traduce<br />
una corrente elettrica in una torsione meccanica (si<br />
usa spesso come rilevatore di corrente continua).<br />
179 Risposta: D. Si definisce vettore quell’ente<br />
matematico che, nello spazio ordinario, è caratterizzato<br />
da un numero reale, detto modulo, una<br />
direzione e un verso. La somma di due vettori a e b è<br />
defin<strong>it</strong>a come il vettore a + b, diagonale del parallelogramma<br />
formato dai vettori a e b; a + b appartiene<br />
allo stesso piano di a e b. Perchéla somma di due<br />
vettori sia nulla è necessario che essi siano opposti e<br />
abbiano lo stesso modulo.<br />
180 Risposta: A. Il campo elettrico è un campo di<br />
forze e si valuta osservando la forza che si<br />
misurerebbe su una carica un<strong>it</strong>aria ovvero con la<br />
variazione di potenziale nello spazio.<br />
181 Risposta: E. Un grave lasciato cadere da un<br />
altezza h in assenza di attr<strong>it</strong>o e sottoposto alla<br />
sola forza grav<strong>it</strong>azionale si muove con moto uniformemente<br />
accelerato e il moto è regolato dall’equazione:<br />
x(t) =x0 + v0t + at 2 /2, dove x(t) èla distanza<br />
percorsa dal grave, x0 la posizione del grave all’istante<br />
iniziale t0 = 0, t il tempo impiegato, v0 la<br />
veloc<strong>it</strong>à iniziale e a l’accelerazione cui è sottoposto<br />
il corpo (pari a g =9,8m/s 2 nel caso della caduta di<br />
un grave). Sost<strong>it</strong>uendo i valori nell’equazione, si ha<br />
x(t) =gt 2 /2 = (1/2) l 9,8 m/s 2 l (6 s) 2 =180m.<br />
12 6001 Quiz - Psicologia § Ulrico Hoepli Ed<strong>it</strong>ore S.p.A.