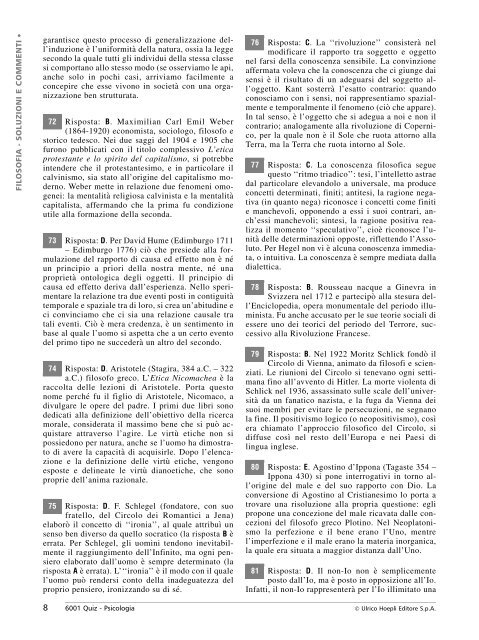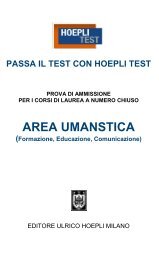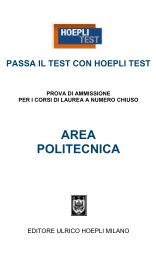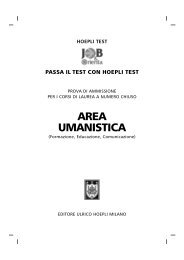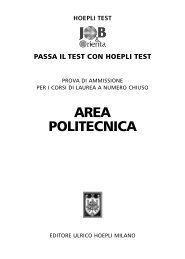Download Commenti (PDF) - HOEPLITest.it
Download Commenti (PDF) - HOEPLITest.it
Download Commenti (PDF) - HOEPLITest.it
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
FILOSOFIA - SOLUZIONI E COMMENTI «<br />
garantisce questo processo di generalizzazione dell’induzione<br />
è l’uniform<strong>it</strong>à della natura, ossia la legge<br />
secondo la quale tutti gli individui della stessa classe<br />
si comportano allo stesso modo (se osserviamo le api,<br />
anche solo in pochi casi, arriviamo facilmente a<br />
concepire che esse vivono in società con una organizzazione<br />
ben strutturata.<br />
72 Risposta: B. Maximilian Carl Emil Weber<br />
(1864-1920) economista, sociologo, filosofo e<br />
storico tedesco. Nei due saggi del 1904 e 1905 che<br />
furono pubblicati con il t<strong>it</strong>olo complessivo L’etica<br />
protestante e lo spir<strong>it</strong>o del cap<strong>it</strong>alismo, sipotrebbe<br />
intendere che il protestantesimo, e in particolare il<br />
calvinismo, sia stato all’origine del cap<strong>it</strong>alismo moderno.<br />
Weber mette in relazione due fenomeni omogenei:<br />
la mental<strong>it</strong>à religiosa calvinista e la mental<strong>it</strong>à<br />
cap<strong>it</strong>alista, affermando che la prima fu condizione<br />
utile alla formazione della seconda.<br />
73 Risposta: D. PerDavidHume(Edimburgo1711<br />
– Edimburgo 1776) ciò chepresiedeallaformulazione<br />
del rapporto di causa ed effetto non è né<br />
un principio a priori della nostra mente, né una<br />
proprietà ontologica degli oggetti. Il principio di<br />
causa ed effetto deriva dall’esperienza. Nello sperimentare<br />
la relazione tra due eventi posti in contigu<strong>it</strong>à<br />
temporaleespazialetradiloro,sicreaun’ab<strong>it</strong>udinee<br />
ci convinciamo che ci sia una relazione causale tra<br />
tali eventi. Ciò è mera credenza, è un sentimento in<br />
base al quale l’uomo si aspetta che a un certo evento<br />
del primo tipo ne succederà un altro del secondo.<br />
74 Risposta: D. Aristotele (Stagira, 384 a.C. – 322<br />
a.C.) filosofo greco. L’Etica Nicomachea è la<br />
raccolta delle lezioni di Aristotele. Porta questo<br />
nome perché fu il figlio di Aristotele, Nicomaco, a<br />
divulgare le opere del padre. I primi due libri sono<br />
dedicati alla definizione dell’obiettivo della ricerca<br />
morale, considerata il massimo bene che si può acquistare<br />
attraverso l’agire. Le virtù etiche non si<br />
possiedono per natura, anche se l’uomo ha dimostratodiaverelacapac<strong>it</strong>àdi<br />
acquisirle. Dopo l’elencazione<br />
e la definizione delle virtù etiche, vengono<br />
esposte e delineate le virtù dianoetiche, che sono<br />
proprie dell’anima razionale.<br />
75 Risposta: D. F. Schlegel (fondatore, con suo<br />
fratello, del Circolo dei Romantici a Jena)<br />
elaborò il concetto di ‘‘ironia’’, al quale attribuì un<br />
senso ben diverso da quello socratico (la risposta B è<br />
errata. Per Schlegel, gli uomini tendono inev<strong>it</strong>abilmente<br />
il raggiungimento dell’Infin<strong>it</strong>o, ma ogni pensiero<br />
elaborato dall’uomo è sempre determinato (la<br />
risposta A è errata). L’‘‘ironia’’ è il modo con il quale<br />
l’uomo può rendersi conto della inadeguatezza del<br />
proprio pensiero, ironizzando su di sé.<br />
76 Risposta: C. La ‘‘rivoluzione’’ consisterà nel<br />
modificare il rapporto tra soggetto e oggetto<br />
nel farsi della conoscenza sensibile. La convinzione<br />
affermata voleva che la conoscenza che ci giunge dai<br />
sensi è il risultato di un adeguarsi del soggetto all’oggetto.<br />
Kant sosterrà l’esatto contrario: quando<br />
conosciamo con i sensi, noi rappresentiamo spazialmente<br />
e temporalmente il fenomeno (ciò che appare).<br />
In tal senso, è l’oggetto che si adegua a noi e non il<br />
contrario; analogamente alla rivoluzione di Copernico,<br />
per la quale non è il Sole che ruota attorno alla<br />
Terra, ma la Terra che ruota intorno al Sole.<br />
77 Risposta: C. La conoscenza filosofica segue<br />
questo ‘‘r<strong>it</strong>mo triadico’’: tesi, l’intelletto astrae<br />
dal particolare elevandolo a universale, ma produce<br />
concetti determinati, fin<strong>it</strong>i; ant<strong>it</strong>esi, la ragione negativa<br />
(in quanto nega) riconosce i concetti come fin<strong>it</strong>i<br />
e manchevoli, opponendo a essi i suoi contrari, anch’essi<br />
manchevoli; sintesi, la ragione pos<strong>it</strong>iva realizza<br />
il momento ‘‘speculativo’’, cioè riconosce l’un<strong>it</strong>à<br />
delle determinazioni opposte, riflettendo l’Assoluto.<br />
Per Hegel non vi è alcuna conoscenza immediata,<br />
o intu<strong>it</strong>iva. La conoscenza è sempre mediata dalla<br />
dialettica.<br />
78 Risposta: B. Rousseau nacque a Ginevra in<br />
Svizzera nel 1712 e partecipò alla stesura dell’Enciclopedia,<br />
opera monumentale del periodo illuminista.<br />
Fu anche accusato per le sue teorie sociali di<br />
essere uno dei teorici del periodo del Terrore, successivo<br />
alla Rivoluzione Francese.<br />
79 Risposta: B. Nel 1922 Mor<strong>it</strong>z Schlick fondò il<br />
Circolo di Vienna, animato da filosofi e scienziati.<br />
Le riunioni del Circolo si tenevano ogni settimana<br />
fino all’avvento di H<strong>it</strong>ler. La morte violenta di<br />
Schlick nel 1936, assassinato sulle scale dell’univers<strong>it</strong>à<br />
da un fanatico nazista, e la fuga da Vienna dei<br />
suoi membri per ev<strong>it</strong>are le persecuzioni, ne segnano<br />
la fine. Il pos<strong>it</strong>ivismo logico (o neopos<strong>it</strong>ivismo), così<br />
era chiamato l’approccio filosofico del Circolo, si<br />
diffuse così nel resto dell’Europa e nei Paesi di<br />
lingua inglese.<br />
80 Risposta: E. Agostino d’Ippona (Tagaste 354 –<br />
Ippona 430) si pone interrogativi in torno all’origine<br />
del male e del suo rapporto con Dio. La<br />
conversione di Agostino al Cristianesimo lo porta a<br />
trovare una risoluzione alla propria questione: egli<br />
propone una concezione del male ricavata dalle concezioni<br />
del filosofo greco Plotino. Nel Neoplatonismo<br />
la perfezione e il bene erano l’Uno, mentre<br />
l’imperfezione e il male erano la materia inorganica,<br />
la quale era s<strong>it</strong>uata a maggior distanza dall’Uno.<br />
81 Risposta: D. Il non-Io non è semplicemente<br />
posto dall’Io, ma è posto in opposizione all’Io.<br />
Infatti, il non-Io rappresenterà per l’Io illim<strong>it</strong>ato una<br />
8 6001 Quiz - Psicologia § Ulrico Hoepli Ed<strong>it</strong>ore S.p.A.