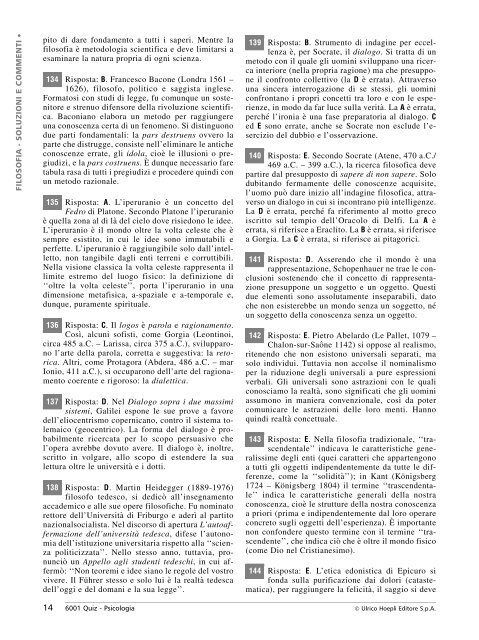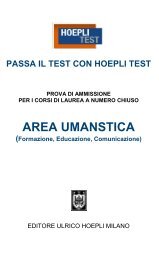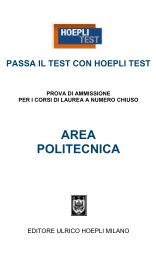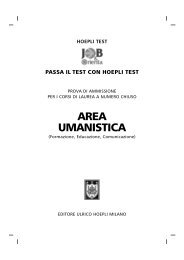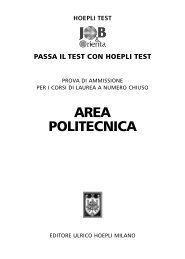Download Commenti (PDF) - HOEPLITest.it
Download Commenti (PDF) - HOEPLITest.it
Download Commenti (PDF) - HOEPLITest.it
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
FILOSOFIA - SOLUZIONI E COMMENTI «<br />
p<strong>it</strong>o di dare fondamento a tutti i saperi. Mentre la<br />
filosofia è metodologia scientifica e deve lim<strong>it</strong>arsi a<br />
esaminare la natura propria di ogni scienza.<br />
134 Risposta: B. Francesco Bacone (Londra 1561 –<br />
1626), filosofo, pol<strong>it</strong>ico e saggista inglese.<br />
Formatosi con studi di legge, fu comunque un sosten<strong>it</strong>ore<br />
e strenuo difensore della rivoluzione scientifica.<br />
Baconiano elabora un metodo per raggiungere<br />
una conoscenza certa di un fenomeno. Si distinguono<br />
due parti fondamentali: la pars destruens ovvero la<br />
parte che distrugge, consiste nell’eliminare le antiche<br />
conoscenze errate, gli idola, cioèle illusioni o pregiudizi,<br />
e la pars costruens. Èdunque necessario fare<br />
tabula rasa di tutti i pregiudizi e procedere quindi con<br />
un metodo razionale.<br />
135 Risposta: A. L’iperuranio è un concetto del<br />
Fedro di Platone. Secondo Platone l’iperuranio<br />
è quella zona al di là del cielo dove risiedono le idee.<br />
L’iperuranio è il mondo oltre la volta celeste che è<br />
sempre esist<strong>it</strong>o, in cui le idee sono immutabili e<br />
perfette. L’iperuranio è raggiungibile solo dall’intelletto,<br />
non tangibile dagli enti terreni e corruttibili.<br />
Nella visione classica la volta celeste rappresenta il<br />
lim<strong>it</strong>e estremo del luogo fisico: la definizione di<br />
‘‘oltre la volta celeste’’, porta l’iperuranio in una<br />
dimensione metafisica, a-spaziale e a-temporale e,<br />
dunque, puramente spir<strong>it</strong>uale.<br />
136 Risposta: C. Illogos è parola e ragionamento.<br />
Così, alcuni sofisti, come Gorgia (Leontinoi,<br />
circa 485 a.C. – Larissa, circa 375 a.C.), svilupparono<br />
l’arte della parola, corretta e suggestiva: la retorica.<br />
Altri, come Protagora (Abdera, 486 a.C. – mar<br />
Ionio, 411 a.C.), si occuparono dell’arte del ragionamento<br />
coerente e rigoroso: la dialettica.<br />
137 Risposta: D. NelDialogo sopra i due massimi<br />
sistemi, Galilei espone le sue prove a favore<br />
dell’eliocentrismo copernicano, contro il sistema tolemaico<br />
(geocentrico). La forma del dialogo è probabilmente<br />
ricercata per lo scopo persuasivo che<br />
l’opera avrebbe dovuto avere. Il dialogo è, inoltre,<br />
scr<strong>it</strong>to in volgare, allo scopo di estendere la sua<br />
lettura oltre le univers<strong>it</strong>à e i dotti.<br />
138 Risposta: D. Martin Heidegger (1889-1976)<br />
filosofo tedesco, si dedicò all’insegnamento<br />
accademico e alle sue opere filosofiche. Fu nominato<br />
rettore dell’Univers<strong>it</strong>à di Friburgo e aderì al part<strong>it</strong>o<br />
nazionalsocialista. Nel discorso di apertura L’autoaffermazione<br />
dell’univers<strong>it</strong>à tedesca, difese l’autonomia<br />
dell’ist<strong>it</strong>uzione univers<strong>it</strong>aria rispetto alla ‘‘scienza<br />
pol<strong>it</strong>icizzata’’. Nello stesso anno, tuttavia, pronunciò<br />
un Appello agli studenti tedeschi, incuiaffermò:<br />
‘‘Non teoremi e idee siano le regole del vostro<br />
vivere. Il Führer stesso e solo lui è la realtà tedesca<br />
dell’oggi e del domani e la sua legge’’.<br />
139 Risposta: B. Strumento di indagine per eccellenza<br />
è, per Socrate, il dialogo. Si tratta di un<br />
metodo con il quale gli uomini sviluppano una ricerca<br />
interiore (nella propria ragione) ma che presuppone<br />
il confronto collettivo (la D è errata). Attraverso<br />
una sincera interrogazione di se stessi, gli uomini<br />
confrontano i propri concetti tra loro e con le esperienze,<br />
in modo da far luce sulla ver<strong>it</strong>à. LaA è errata,<br />
perché l’ironia è una fase preparatoria al dialogo. C<br />
ed E sono errate, anche se Socrate non esclude l’esercizio<br />
del dubbio e l’osservazione.<br />
140 Risposta: E. Secondo Socrate (Atene, 470 a.C./<br />
469 a.C. – 399 a.C.), la ricerca filosofica deve<br />
partire dal presupposto di sapere di non sapere. Solo<br />
dub<strong>it</strong>ando fermamente delle conoscenze acquis<strong>it</strong>e,<br />
l’uomo può dare inizio all’indagine filosofica, attraverso<br />
un dialogo in cui si incontrano più intelligenze.<br />
La D è errata, perché fa riferimento al motto greco<br />
iscr<strong>it</strong>to sul tempio dell’Oracolo di Delfi. La A è<br />
errata, si riferisce a Eracl<strong>it</strong>o. La B è errata, si riferisce<br />
aGorgia.LaC è errata, si riferisce ai p<strong>it</strong>agorici.<br />
141 Risposta: D. Asserendo che il mondo è una<br />
rappresentazione, Schopenhauer ne trae le conclusioni<br />
sostenendo che il concetto di rappresentazione<br />
presuppone un soggetto e un oggetto. Questi<br />
due elementi sono assolutamente inseparabili, dato<br />
che non esisterebbe un mondo senza un soggetto, né<br />
un soggetto della conoscenza senza un oggetto.<br />
142 Risposta: E. Pietro Abelardo (Le Pallet, 1079 –<br />
Chalon-sur-Saône 1142) si oppose al realismo,<br />
r<strong>it</strong>enendo che non esistono universali separati, ma<br />
solo individui. Tuttavia non accolse il nominalismo<br />
per la riduzione degli universali a pure espressioni<br />
verbali. Gli universali sono astrazioni con le quali<br />
conosciamo la realtà, sono significati che gli uomini<br />
assumono in maniera convenzionale, così da poter<br />
comunicare le astrazioni delle loro menti. Hanno<br />
quindi realtà concettuale.<br />
143 Risposta: E. Nella filosofia tradizionale, ‘‘trascendentale’’<br />
indicava le caratteristiche generalissime<br />
degli enti (quei caratteri che appartengono<br />
a tutti gli oggetti indipendentemente da tutte le differenze,<br />
come la ‘‘solid<strong>it</strong>à’’); in Kant (Königsberg<br />
1724 – Königsberg 1804) il termine ‘‘trascendentale’’<br />
indica le caratteristiche generali della nostra<br />
conoscenza, cioè le strutture della nostra conoscenza<br />
a priori (prima e indipendentemente dal loro operare<br />
concreto sugli oggetti dell’esperienza). È importante<br />
non confondere questo termine con il termine ‘‘trascendente’’,<br />
che indica ciò che è oltre il mondo fisico<br />
(come Dio nel Cristianesimo).<br />
144 Risposta: E. L’etica edonistica di Epicuro si<br />
fonda sulla purificazione dai dolori (catastematica),<br />
per raggiungere la felic<strong>it</strong>à, ilsaggiosideve<br />
14 6001 Quiz - Psicologia § Ulrico Hoepli Ed<strong>it</strong>ore S.p.A.