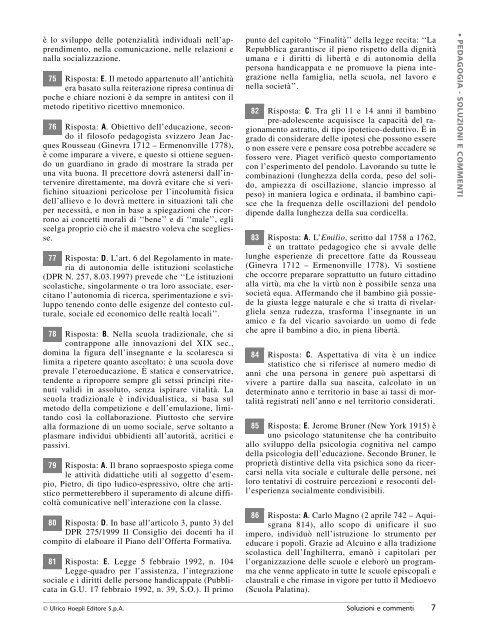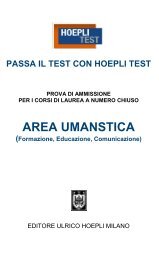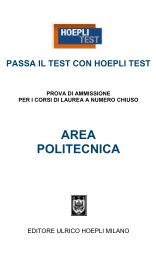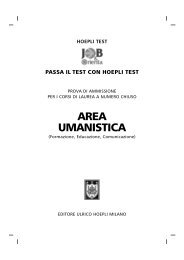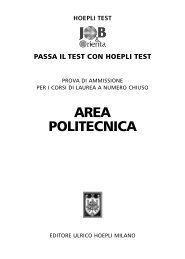Download Commenti (PDF) - HOEPLITest.it
Download Commenti (PDF) - HOEPLITest.it
Download Commenti (PDF) - HOEPLITest.it
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
è lo sviluppo delle potenzial<strong>it</strong>à individuali nell’apprendimento,<br />
nella comunicazione, nelle relazioni e<br />
nalla socializzazione.<br />
75 Risposta: E. Il metodo appartenuto all’antich<strong>it</strong>à<br />
era basato sulla re<strong>it</strong>erazione ripresa continua di<br />
poche e chiare nozioni è da sempre in ant<strong>it</strong>esi con il<br />
metodo ripet<strong>it</strong>ivo ricettivo mnemonico.<br />
76 Risposta: A. Obiettivo dell’educazione, secondo<br />
il filosofo pedagogista svizzero Jean Jacques<br />
Rousseau (Ginevra 1712 – Ermenonville 1778),<br />
è come imparare a vivere, e questo si ottiene seguendo<br />
un guardiano in grado di mostrare la strada per<br />
una v<strong>it</strong>a buona. Il precettore dovrà astenersi dall’intervenire<br />
direttamente, ma dovrà ev<strong>it</strong>are che si verifichino<br />
s<strong>it</strong>uazioni pericolose per l’incolum<strong>it</strong>à fisica<br />
dell’allievo e lo dovrà mettere in s<strong>it</strong>uazioni tali che<br />
per necess<strong>it</strong>à, e non in base a spiegazioni che ricorrono<br />
ai concetti morali di ‘‘bene’’ e di ‘‘male’’, egli<br />
scelga proprio ciò che il maestro voleva che scegliesse.<br />
77 Risposta: D. L’art. 6 del Regolamento in materia<br />
di autonomia delle ist<strong>it</strong>uzioni scolastiche<br />
(DPR N. 257, 8.03.1997) prevede che ‘‘Le ist<strong>it</strong>uzioni<br />
scolastiche, singolarmente o tra loro associate, eserc<strong>it</strong>ano<br />
l’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo<br />
tenendo conto delle esigenze del contesto culturale,<br />
sociale ed economico delle realtà locali’’.<br />
78 Risposta: B. Nella scuola tradizionale, che si<br />
contrappone alle innovazioni del XIX sec.,<br />
domina la figura dell’insegnante e la scolaresca si<br />
lim<strong>it</strong>a a ripetere quanto ascoltato: è una scuola dove<br />
prevale l’eteroeducazione. È statica e conservatrice,<br />
tendente a riproporre sempre glisetssiprincipir<strong>it</strong>enuti<br />
validi in assoluto, senza ispirare v<strong>it</strong>al<strong>it</strong>à. La<br />
scuola tradizionale è individualistica, si basa sul<br />
metodo della competizione e dell’emulazione, lim<strong>it</strong>ando<br />
così la collaborazione. Piuttosto che servire<br />
alla formazione di un uomo sociale, serve soltanto a<br />
plasmare individui ubbidienti all’autor<strong>it</strong>à, acr<strong>it</strong>ici e<br />
passivi.<br />
79 Risposta: A. Il brano sopraesposto spiega come<br />
le attiv<strong>it</strong>à didattiche utili al soggetto d’esempio,<br />
Pietro, di tipo ludico-espressivo, oltre che artistico<br />
permetterebbero il superamento di alcune difficoltà<br />
comunicative nell’interazione con la classe.<br />
80 Risposta: D. In base all’articolo 3, punto 3) del<br />
DPR 275/1999 Il Consiglio dei docenti ha il<br />
comp<strong>it</strong>o di elaboare il Piano dell’Offerta Formativa.<br />
81 Risposta: E. Legge 5 febbraio 1992, n. 104<br />
Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione<br />
sociale e i dir<strong>it</strong>ti delle persone handicappate (Pubblicata<br />
in G.U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.). Il primo<br />
punto del cap<strong>it</strong>olo ‘‘Final<strong>it</strong>à’’ della legge rec<strong>it</strong>a: ‘‘La<br />
Repubblica garantisce il pieno rispetto della dign<strong>it</strong>à<br />
umana e i dir<strong>it</strong>ti di libertà e di autonomia della<br />
persona handicappata e ne promuove la piena integrazione<br />
nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e<br />
nella società’’.<br />
82 Risposta: C. Tra gli 11 e 14 anni il bambino<br />
pre-adolescente acquisisce la capac<strong>it</strong>à del ragionamento<br />
astratto, di tipo ipotetico-deduttivo. È in<br />
grado di considerare delle ipotesi che possono essere<br />
o non essere vere e pensare cosa potrebbe accadere se<br />
fossero vere. Piaget verificò questo comportamento<br />
con l’esperimento del pendolo. Lavorando su tutte le<br />
combinazioni (lunghezza della corda, peso del solido,<br />
ampiezza di oscillazione, slancio impresso al<br />
peso) in maniera logica e ordinata, il bambino capisce<br />
che la frequenza delle oscillazioni del pendolo<br />
dipende dalla lunghezza della sua cordicella.<br />
83 Risposta: A. L’Emilio, scr<strong>it</strong>to dal 1758 a 1762,<br />
è un trattato pedagogico che si avvale delle<br />
lunghe esperienze di precettore fatte da Rousseau<br />
(Ginevra 1712 – Ermenonville 1778). Vi sostiene<br />
che occorre preparare soprattutto un futuro c<strong>it</strong>tadino<br />
alla virtù, machelavirtùnon è possibile senza una<br />
società equa. Affermando che il bambino già possiede<br />
la giusta legge naturale e che si tratta di rivelargliela<br />
senza rudezza, trasforma l’insegnante in un<br />
amico e fa del vicario savoiardo un uomo di fede<br />
cheapreilbambinoadio,inpienalibertà.<br />
84 Risposta: C. Aspettativa di v<strong>it</strong>a è un indice<br />
statistico che si riferisce al numero medio di<br />
anni che una persona in genere può aspettarsi di<br />
vivere a partire dalla sua nasc<strong>it</strong>a, calcolato in un<br />
determinato anno e terr<strong>it</strong>orio in base ai tassi di mortal<strong>it</strong>à<br />
registrati nell’anno e nel terr<strong>it</strong>orio considerati.<br />
85 Risposta: E. Jerome Bruner (New York 1915) è<br />
uno psicologo statun<strong>it</strong>ense che ha contribu<strong>it</strong>o<br />
allo sviluppo della psicologia cogn<strong>it</strong>iva nel campo<br />
della psicologia dell’educazione. Secondo Bruner, le<br />
proprietà distintive della v<strong>it</strong>a psichica sono da ricercarsi<br />
nella v<strong>it</strong>a sociale e culturale delle persone, nei<br />
loro tentativi di costruire percezioni e resoconti dell’esperienza<br />
socialmente condivisibili.<br />
86 Risposta: A. CarloMagno(2aprile742–Aquisgrana<br />
814), allo scopo di unificare il suo<br />
impero, individuò nell’istruzione lo strumento per<br />
educare i popoli. Grazie ad Alcuino e alla tradizione<br />
scolastica dell’Inghilterra, emanò i cap<strong>it</strong>olari per<br />
l’organizzazione delle scuole e eleborò un programma<br />
che venne applicato in tutte le scuole episcopali e<br />
claustrali e che rimase in vigore per tutto il Medioevo<br />
(Scuola Palatina).<br />
§ Ulrico Hoepli Ed<strong>it</strong>ore S.p.A. Soluzioni e commenti 7<br />
« PEDAGOGIA - SOLUZIONI E COMMENTI