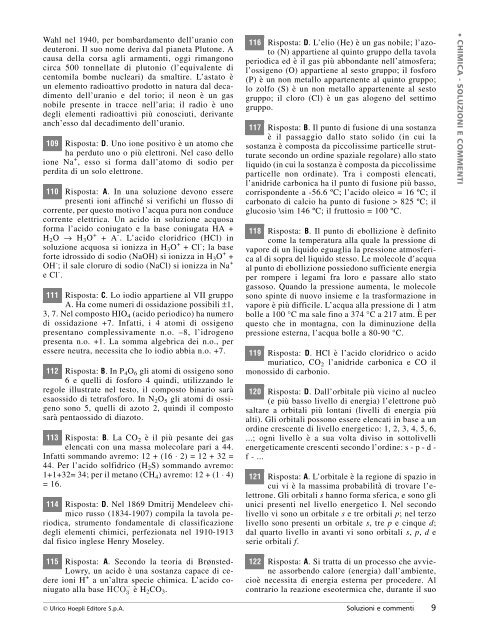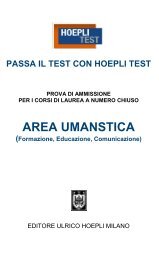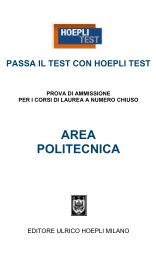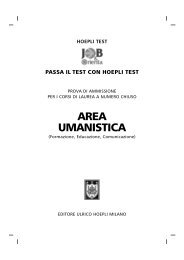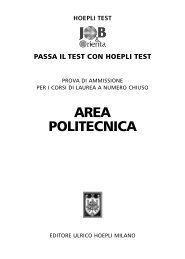Download Commenti (PDF) - HOEPLITest.it
Download Commenti (PDF) - HOEPLITest.it
Download Commenti (PDF) - HOEPLITest.it
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Wahl nel 1940, per bombardamento dell’uranio con<br />
deuteroni. Il suo nome deriva dal pianeta Plutone. A<br />
causa della corsa agli armamenti, oggi rimangono<br />
circa 500 tonnellate di plutonio (l’equivalente di<br />
centomila bombe nucleari) da smaltire. L’astato è<br />
un elemento radioattivo prodotto in natura dal decadimento<br />
dell’uranio e del torio; il neon è un gas<br />
nobile presente in tracce nell’aria; il radio è uno<br />
degli elementi radioattivi più conosciuti, derivante<br />
anch’esso dal decadimento dell’uranio.<br />
109 Risposta: D. Uno ione pos<strong>it</strong>ivo è un atomo che<br />
ha perduto uno o più elettroni. Nel caso dello<br />
ione Na + , esso si forma dall’atomo di sodio per<br />
perd<strong>it</strong>a di un solo elettrone.<br />
110 Risposta: A. In una soluzione devono essere<br />
presenti ioni affinché si verifichi un flusso di<br />
corrente, per questo motivo l’acqua pura non conduce<br />
corrente elettrica. Un acido in soluzione acquosa<br />
forma l’acido coniugato e la base coniugata HA +<br />
H2O D H3O + + A - . L’acido cloridrico (HCl) in<br />
soluzione acquosa si ionizza in H3O + +Cl - ;labase<br />
forte idrossido di sodio (NaOH) si ionizza in H3O + +<br />
OH - ;ilsaleclorurodisodio(NaCl)siionizzainNa +<br />
eCl - .<br />
111 Risposta: C. Lo iodio appartiene al VII gruppo<br />
A. Ha come numeri di ossidazione possibili g1,<br />
3, 7. Nel composto HIO4 (acido periodico) ha numero<br />
di ossidazione +7. Infatti, i 4 atomi di ossigeno<br />
presentano complessivamente n.o. –8, l’idrogeno<br />
presenta n.o. +1. La somma algebrica dei n.o., per<br />
essere neutra, necess<strong>it</strong>a che lo iodio abbia n.o. +7.<br />
112 Risposta: B. InP 4O 6 gli atomi di ossigeno sono<br />
6 e quelli di fosforo 4 quindi, utilizzando le<br />
regole illustrate nel testo, il composto binario sarà<br />
esaossido di tetrafosforo. In N2O5 gli atomi di ossigeno<br />
sono 5, quelli di azoto 2, quindi il composto<br />
sarà pentaossido di diazoto.<br />
113 Risposta: B. LaCO 2 è il più pesante dei gas<br />
elencati con una massa molecolare pari a 44.<br />
Infatti sommando avremo: 12 + (16 l 2) = 12 + 32 =<br />
44. Per l’acido solfidrico (H 2S) sommando avremo:<br />
1+1+32= 34; per il metano (CH 4) avremo: 12 + (1 l 4)<br />
=16.<br />
114 Risposta: D. Nel 1869 Dm<strong>it</strong>rij Mendeleev chimico<br />
russo (1834-1907) compila la tavola periodica,<br />
strumento fondamentale di classificazione<br />
degli elementi chimici, perfezionata nel 1910-1913<br />
dal fisico inglese Henry Moseley.<br />
115 Risposta: A. Secondo la teoria di Brønsted-<br />
Lowry, un acido è una sostanza capace di cedere<br />
ioni H + aun’altraspeciechimica.L’acidoconiugato<br />
alla base HCO 3 è H2CO3.<br />
116 Risposta: D. L’elio (He) è un gas nobile; l’azoto<br />
(N) appartiene al quinto gruppo della tavola<br />
periodica ed è il gas più abbondante nell’atmosfera;<br />
l’ossigeno (O) appartiene al sesto gruppo; il fosforo<br />
(P) è un non metallo appartenente al quinto gruppo;<br />
lo zolfo (S) è un non metallo appartenente al sesto<br />
gruppo; il cloro (Cl) è un gas alogeno del settimo<br />
gruppo.<br />
117 Risposta: B. Il punto di fusione di una sostanza<br />
è il passaggio dallo stato solido (in cui la<br />
sostanza è composta da piccolissime particelle strutturate<br />
secondo un ordine spaziale regolare) allo stato<br />
liquido (in cui la sostanza è composta da piccolissime<br />
particelle non ordinate). Tra i composti elencati,<br />
l’anidride carbonica ha il punto di fusione più basso,<br />
corrispondente a -56.6 ºC; l’acido oleico = 16 ºC; il<br />
carbonato di calcio ha punto di fusione > 825 ºC; il<br />
glucosio \sim 146 ºC; il fruttosio = 100 ºC.<br />
118 Risposta: B. Il punto di ebollizione è defin<strong>it</strong>o<br />
comelatemperaturaallaqualelapressionedi<br />
vapore di un liquido eguaglia la pressione atmosferica<br />
al di sopra del liquido stesso. Le molecole d’acqua<br />
al punto di ebollizione possiedono sufficiente energia<br />
per rompere i legami fra loro e passare allo stato<br />
gassoso. Quando la pressione aumenta, le molecole<br />
sonospintedinuovoinsiemeelatrasformazionein<br />
vapore è più difficile. L’acqua alla pressione di 1 atm<br />
bolle a 100 _C masalefinoa374_C a217atm.Èper<br />
questo che in montagna, con la diminuzione della<br />
pressione esterna, l’acqua bolle a 80-90 _C.<br />
119 Risposta: D. HClèl’acido cloridrico o acido<br />
muriatico, CO2 l’anidride carbonica e CO il<br />
monossido di carbonio.<br />
120 Risposta: D. Dall’orb<strong>it</strong>ale più vicino al nucleo<br />
(e più basso livello di energia) l’elettrone può<br />
saltare a orb<strong>it</strong>ali più lontani (livelli di energia più<br />
alti). Gli orb<strong>it</strong>ali possono essere elencati in base a un<br />
ordine crescente di livello energetico: 1, 2, 3, 4, 5, 6,<br />
...; ogni livello è a sua volta diviso in sottolivelli<br />
energeticamente crescenti secondo l’ordine: s - p - d -<br />
f - ...<br />
121 Risposta: A. L’orb<strong>it</strong>aleèla regione di spazio in<br />
cui vi è la massima probabil<strong>it</strong>à di trovare l’elettrone.<br />
Gli orb<strong>it</strong>ali s hanno forma sferica, e sono gli<br />
unici presenti nel livello energetico I. Nel secondo<br />
livello vi sono un orb<strong>it</strong>ale s e tre orb<strong>it</strong>ali p; nelterzo<br />
livello sono presenti un orb<strong>it</strong>ale s, trep e cinque d;<br />
dal quarto livello in avanti vi sono orb<strong>it</strong>ali s, p, d e<br />
serie orb<strong>it</strong>ali f.<br />
122 Risposta: A. Si tratta di un processo che avviene<br />
assorbendo calore (energia) dall’ambiente,<br />
cioè necess<strong>it</strong>a di energia esterna per procedere. Al<br />
contrario la reazione eseotermica che, durante il suo<br />
§ Ulrico Hoepli Ed<strong>it</strong>ore S.p.A. Soluzioni e commenti 9<br />
« CHIMICA - SOLUZIONI E COMMENTI