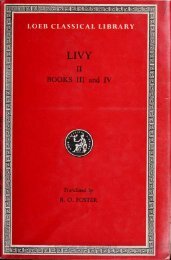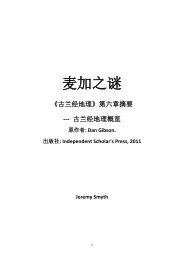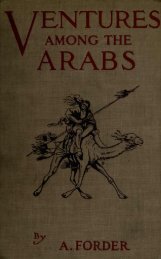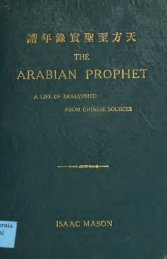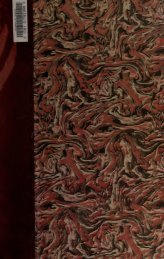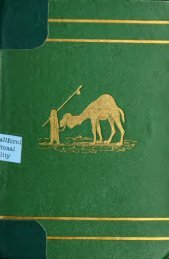- Page 1: _LI .ì..
- Page 6 and 7: Già pubblicati: Annali dell'Islam
- Page 8 and 9: Roma, 1912 — Tipografia dell'Unio
- Page 11: GIUSEPPE GABRIELI BIBLIOTECARIO DEL
- Page 15 and 16: PREFAZIONE L'abbondanza della mater
- Page 17 and 18: PREFAZIONE rire come un lavoro comp
- Page 19 and 20: PREFAZIONE * * * Debbo rinnovare i
- Page 21 and 22: PREFAZIONE grammatica e della prouu
- Page 23 and 24: INDICE ANALITICO DKLLA MATERIA CONT
- Page 25 and 26: ODICE ANALITICO §§ 68-173. 23. a.
- Page 27: Abd al-rahmàn al-Awsat b. 'Umar,
- Page 31 and 32: INDICE ANALITICO §§ 6ÌH1.771 23.
- Page 33 and 34: INDICE ANAUTICO §? ì^KMWS. 23. a.
- Page 35: INDICE ANALITICO § 849. 23. a. H.
- Page 38 and 39: 129, § 240, linea 7, cor;-, con al
- Page 40 and 41: inazdeisU. La correziuue è coai ge
- Page 42 and 43: ti CI 2»«o33S--«1iOdSS--**^oao-S
- Page 44 and 45: Basrah.l §1 1 2. ^ó. 3.. ria 23.
- Page 46 and 47: •e i> t^ ^«5* a.* ri- 23. a. H.
- Page 48 and 49: }f 9-7. 23. a. H. 23. a. H. Nota 3.
- Page 50 and 51: ss u-13. 23. a. H. 23. a. H. iil-A.
- Page 52 and 53: 23. a. H. PERSIA. - Presa dì Hamad
- Page 54 and 55: Il 30-ai. 23. a. H. 23- a. H. Iiisi
- Page 56 and 57: fi 23-28. 23. E. H. 23. «. H. al-A
- Page 58 and 59: E •2P, ^ó. £1. H. • 23. a. H.
- Page 60 and 61: 23. a. H. [PERSIA-FARIS. Prima inva
- Page 62 and 63: £ 3y Zio» 2i» 11* 23. a. H. invi
- Page 64 and 65: §} ;«, 34 28. a. H. 23. a. H. com
- Page 66 and 67: 9$ ^«>, 9«. 23. a. H. 23. a. H. N
- Page 68 and 69: H 37-aa. 23. a. H. 23. a. H I yotì
- Page 70 and 71: I ivj, 2ió. 3.. Il* 23. a. H. Ijj
- Page 72 and 73: iti 41-4-t. 23- 3* H. 23. a. H. Que
- Page 74 and 75: 23. a. H. [SIRIA-ASIA MI- NORE-ARME
- Page 76 and 77: a 55-09. 23. a. H. 23- a- H. I, Qay
- Page 78 and 79:
IS 62, Ga. '*' 23. a. H, ^3- » yf-
- Page 80 and 81:
23. a. H |ARABIA(Makkah $s m, 67. 2
- Page 82 and 83:
23. a. H. [ARABIA MADI NAH. - Intro
- Page 84 and 85:
23. a. H. [ARABIA-MADÌ- NAH. - Int
- Page 86 and 87:
« 71, 72 23.^ 23. a. H. roiigiurat
- Page 88 and 89:
i% 7a, 74. 23. a. H. 23. a. H. .seg
- Page 90 and 91:
23. a. H. [ARABIA MAOI- NAH. - Intr
- Page 92 and 93:
Umar.j K •j'j Ad. 3,. rl> 23. a.
- Page 94 and 95:
9$ 7«, 79. 23. a. H. 23. a. H. Ici
- Page 96 and 97:
§ 79. ^^* ^* H. 23. a. H. «metter
- Page 98 and 99:
Umar.] e ^1 ^ò> R> ria 23. a. H. ,
- Page 100 and 101:
§§ Hi-Hd. 23. a. n. 23 a- H. sud
- Page 102 and 103:
§f 8*«. 23. a. H. 23. a. H. ^ ^.^
- Page 104 and 105:
89 90-94. 23. a. H. 23. a. H. « Di
- Page 106 and 107:
23. a. H. Umar. §§ !H>-ioi. 23. a
- Page 108 and 109:
23- a- H. , §§ iin-108. 23. a. H.
- Page 110 and 111:
ioy-112. 23. a. H. 23. a. H. luodò
- Page 112 and 113:
23. a. H. 'Umar § 112. ^"* ^' "•
- Page 114 and 115:
23- a. H. NAH. Seppellì- | §§ 11
- Page 116 and 117:
{§ ia»-i32. 23. a. H. 23. a. H. D
- Page 118 and 119:
f$ 1S6-142. 23. a. H. 23. a. H. Hal
- Page 120 and 121:
23. a. H. ,ARABIA-MADI- NAH. - Ulti
- Page 122 and 123:
Q ti*? ^ò* 3.» il* 23. a. H. « n
- Page 124 and 125:
§ 117. 23. a. H. 23. a. ti. l^iiai
- Page 126 and 127:
j j^^-_ 2o. a., il. 23. a. H. contr
- Page 128 and 129:
. *An Zio» 3.* H» 23 3 ARAB I A H
- Page 130 and 131:
§ UH. 2^' ^' ^• 23. a. H. tinto
- Page 132 and 133:
§§ 149152. 23. a. H. 23. a. H. uu
- Page 134 and 135:
'^ "n AH. $§ 163, J64. 23. a. H. 2
- Page 136 and 137:
§ 166. 23. a. H. 23. a. H. ij chia
- Page 138 and 139:
§ 156. ^*^' S'* H. ,.„.^^'. f .!
- Page 140 and 141:
§ 15G. 23. a. H. 23. a. H. A-M ADI
- Page 142 and 143:
23. a. H. (SS iai-167. 23. a. H. §
- Page 144 and 145:
5§ 168-172. 23. a. H. 23. a. H. ^
- Page 146 and 147:
§§ 173, 173. 23. a. H. 23. a. H.
- Page 148 and 149:
§ \TX 23. a. H. 23- a. H. ,^ Qj^p
- Page 150 and 151:
55 176-178. 23. a. H. 23. a. H. way
- Page 152 and 153:
§§ 179, 180. 23. a. H. 23. a. H.
- Page 154 and 155:
§§ iaH87. 23. a. H. 23. a. H. È
- Page 156 and 157:
23. a. H. §g i
- Page 158 and 159:
23- a. H. personali.! §§ 197-202.
- Page 160 and 161:
23. a. H. [ARABIA. - Il liffo 'lima
- Page 162 and 163:
§§ 212-316. 23. a. H. 23. a. H. r
- Page 164 and 165:
s$ 2iT-2i;>. 23. a,. H. 23. a. H. <
- Page 166 and 167:
23. a. H [ARABIA. - Il liffo 'Umar
- Page 168 and 169:
ss 232-287. 23. a. H. 23. a. H. ^1,
- Page 170 and 171:
23. a. H. [ARABIA. - Il liHo Umar:
- Page 172 and 173:
§ -347. 23. a. H. 23. a. H. al-Azr
- Page 174 and 175:
ss 248, 249. 23. a. H. ^^^'^''' ^''
- Page 176 and 177:
23. a. H. [ARABIA. - Il Califfo Uma
- Page 178 and 179:
23. a. H [ARABIA. Il Califfo 'Umar
- Page 180 and 181:
23. a. H. lARABIA. - Il Ca- llffo U
- Page 182 and 183:
277, 278. 23. a. H. 23. a. H. ^a al
- Page 184 and 185:
§§ •280-284. 23. a. H. 23. a. H
- Page 186 and 187:
23. a. H. {ARABIA. Il liffo 'Umar:
- Page 188 and 189:
23. a. H. (ARABIA. - Il liffo Umar:
- Page 190 and 191:
23. a. H. personali. §§ 296-2t»8
- Page 192 and 193:
23. a. H. [ARABIA. Il liffo Umar: c
- Page 194 and 195:
§§ 3f)4-309. 23. a. H. 23- a- ^-
- Page 196 and 197:
23- a. H. §§ -òiósib. 23. a. H.
- Page 198 and 199:
$$ 316, 317. 23. a. H. 23. a. H. «
- Page 200 and 201:
23. a. H. [ARABIA. - Il liffo 'Umar
- Page 202 and 203:
23. a. H. jARABIA. - Il liffo Umar:
- Page 204 and 205:
[ARABIA. 23. a. H. - Il liffo Umar:
- Page 206 and 207:
23. a. H. ;ARABIA. • Il liffo Uma
- Page 208 and 209:
a 343.!U5. 23. a. H. 23. a. H. 176:
- Page 210 and 211:
23- a. H. (ARABIA-ASIAAN- ) §§ 3^
- Page 212 and 213:
§§ 354, 355. 23. a. H. 23- a- H.
- Page 214 and 215:
366. 23. a. H. 23. a. H. (pag- 75)
- Page 216 and 217:
9 355. 23. a. H. 23. a. H. (pag- f^
- Page 218 and 219:
§ ^ìH. 23. a. H. ^^ ^- ^- un 1)11
- Page 220 and 221:
§ 356. 23. a. H. 23. a. H. Uthman
- Page 222 and 223:
Ǥ 367, 868. 23. a. H. 23- a- W-
- Page 224 and 225:
§ 369. 23. a. H. 23. a. H. inoltre
- Page 226 and 227:
5§ avj-361. 23. a. H. 23. a. H. H
- Page 228 and 229:
§§ :wG-368. 23. a. H. ^^- '• ^-
- Page 230 and 231:
fs 3C9, 370. 23. a. H. 23. a. H. vo
- Page 232 and 233:
S§ 372, 873. 23. a. H. 23. a. H.)
- Page 234 and 235:
s§ 37t>379. 23. a. H. ^•^- *•
- Page 236 and 237:
§§ 37!», 380 23. a. H. 23. a. H.
- Page 238 and 239:
s 3ao. 23. a. H. 23. a. H. yon acqu
- Page 240 and 241:
23. a. H. ss 381, 382. 23. a. H. uj
- Page 242 and 243:
23. a. H. [NECROLOGIO. - Ghaylam b.
- Page 244 and 245:
23. a. H. [NECROLOGIO. - Ghaylam b.
- Page 246 and 247:
f§ 387-389. 23. a. H. 23. a. H. cr
- Page 248 and 249:
Sf 39fta95. 23. a. H. 23. a. H. abb
- Page 250 and 251:
§§ LÌ97-400. 23. a. H. 23. a. H.
- Page 252 and 253:
§§ 4U24U4. 23. a,. H. ^^- ^- ^-
- Page 254 and 255:
§§ 4U7-410. 23. a. H. . 23. a. H.
- Page 256 and 257:
ss 412416. 23. a. H. 23. a. H. Cfi-
- Page 258 and 259:
§§ U7, 418. 23. a. H. 23- a- H. v
- Page 260 and 261:
àn.l ^^- ^ *^- INECROLOGIO. - ~" '
- Page 262 and 263:
$§ 422, 428. 23. a. H. 23 a. H. al
- Page 264 and 265:
§§ 426, 42t;. 23. a. H. 23. a. H.
- Page 266 and 267:
5§ 127429. 23. a. H. 23- *• H. P
- Page 268 and 269:
INECROLOGIO. -* . §§ 42!», 4ao.
- Page 270 and 271:
23. a. H. [NECROLOGIO. - H 432, 433
- Page 272 and 273:
s§ 434, 435. 23. a. H. 23 a H INEC
- Page 274 and 275:
§ 135. 23. a. H. ... 23. a. H. Mil
- Page 276 and 277:
^ 4ittì-439. 23. a. H. 23. a. H. a
- Page 278 and 279:
§§ 4du, 441. 23. a. H. 23. a. H.
- Page 280 and 281:
55 443^6. 23. a. H. 23. a. H. abu M
- Page 282 and 283:
^3- a- n- §§ 447, 448. 23. a. H.
- Page 284 and 285:
§§ 448^50. 23. a. H. 23. a. H. Si
- Page 286 and 287:
§§ 450-462. 23. a. H. 23. a. H. r
- Page 288 and 289:
23. a. H. [NECROLOGIO. - Mutammim b
- Page 290 and 291:
23. a. H. (NECROLOGIO. - M u tam m
- Page 292 and 293:
23. a. H. (NECROLOGIO. - M u tam m
- Page 294 and 295:
§§ 464466. 23. a. H. 23. a. H. <
- Page 296 and 297:
fs 468471. 23. a. H. 23. a. H. 'Uma
- Page 298 and 299:
§§ 472, 473. 23. a. H. 23- a- H.
- Page 300 and 301:
§§ 47(j, 477. 23. a. H. 23. a. H.
- Page 302 and 303:
§§ 478, 47a. 23. a. H. 23. a. H.
- Page 304 and 305:
§ 480. 23. a. H. 23- a- H. [NECROL
- Page 306 and 307:
§ 481. 23. a,. H. 23- a- H. Di ess
- Page 308 and 309:
85 482-484. 23. a. H. 23. a. H. i,;
- Page 310 and 311:
ss 486488. 23. a. H. 23. a. H. sene
- Page 312 and 313:
58 491-494. ^"" ^* "• 23. a. H. ^
- Page 314 and 315:
23. a. H. Sé 5oo-»»2. 23. a. H.
- Page 316 and 317:
s§ 5(J8, 604. 23. a. H. 23. a. H f
- Page 318 and 319:
ss & 6-512. 23. a. H. 23. a. H. tom
- Page 320 and 321:
23. a. H. [NECROLOGIO. - M 615-517.
- Page 322 and 323:
23. a. H. I 518. 23. a. H. § 518.
- Page 324 and 325:
al-Khattàb.] §§ 513, 519. 23. a.
- Page 326 and 327:
H &19, 620. 23. a. H. 23. a. H. con
- Page 328 and 329:
I La 19 621, 622. 28. a. H. 23. a.
- Page 330 and 331:
§§ 6_'H, 624. 23. a. H. 23. a. H.
- Page 332 and 333:
ta. *"' §S vii, 6.Ì5. ^^- ^' "•
- Page 334 and 335:
sciate dal Profe- ta.] S§ 62«i, 6
- Page 336 and 337:
23. a. H. [La zakàt, la sa- d aq a
- Page 338 and 339:
sciate dal Profe ta.ì § r,28. 23.
- Page 340 and 341:
§§ 5-2ft, 630. 23. a. H. 23. a. H
- Page 342 and 343:
sciate del Profe- ta.! f 6ao. 23. a
- Page 344 and 345:
' ta. 55 530, r.Hi. 23. a. H. 23. a
- Page 346 and 347:
sciata dal Profe- ta. § .VM, 5H2.
- Page 348 and 349:
§§ b»2, 683. 23. a. H. 23. a. H.
- Page 350 and 351:
sciate dal Profe- ta. 23. a. H. M 6
- Page 352 and 353:
sciate dal Profe- U.] § 636. 2^' ^
- Page 354 and 355:
t«. ss ó;w., 537. 23. a. H. 23. a
- Page 356 and 357:
ff§ 6:w-542. 23. a. H. 23. a. H. j
- Page 358 and 359:
§§ 544-547. 23. a. H. 23. a. H.
- Page 360 and 361:
; 649. '^"' ^' "• 23. a . tali. C
- Page 363 and 364:
^O. 2i. U. e 549. 'Umar però aveva
- Page 365 and 366:
23. a. H. §§ 649, 550. ultimo tat
- Page 367 and 368:
23. a. H. j§ 650, 661. aralio, ma
- Page 369 and 370:
23. a. H. §§ 552, 558. e spesso a
- Page 371 and 372:
23. a. H. 653, 554. cazione della l
- Page 373 and 374:
23. a. H. zione, un privilegio rise
- Page 375 and 376:
23. a. H. 557, 658. come i teorici
- Page 377 and 378:
23. a. H. § 559. della fertile val
- Page 379:
f à * ;i :;^ ^ I r,,jrv^ J^ Ù-J>
- Page 382 and 383:
§§ 5tii, òtj2. 23. a. H. 23. a.
- Page 384 and 385:
23. a. H. '""scaM "delle "prò- I"'
- Page 386 and 387:
'Umar.ì s§ 6«4-5C9. 23. a. H. 23
- Page 388 and 389:
23. a. H. |Le condizioni fi- scali
- Page 390 and 391:
9§ 581, 582. 23. a. H. 23. a. H. 1
- Page 392 and 393:
§§ 586-Ò91. 23. a. H. 23. a. H.
- Page 394 and 395:
23. a. H. |Le condizioni fi- scali
- Page 396 and 397:
6 694. 23. a. H. 23. a. H. Tanto ne
- Page 399 and 400:
23. a. H. Il 694-697. mise in atto
- Page 401 and 402:
aii sDoi ordini iBaUiìzuri, 268).
- Page 403 and 404:
23. a. H. §§ (502.604. L' intromi
- Page 405 and 406:
23. a. H. §^606. — (Yazìd b. ab
- Page 407 and 408:
23. a. H. §§ 611. tìl->. § 611.
- Page 409 and 410:
23. a. H. g§ 6134J15. milizie un s
- Page 411 and 412:
Nota . - ^- *• "• §5 619^. \ed
- Page 413 and 414:
Cfi". anche id., 36, lin. 4-7, con
- Page 415 and 416:
23. a. H. g§ 681-633. Secondo alcu
- Page 417 and 418:
23. a. H. §§ 685-«38. ham e l'ob
- Page 419 and 420:
23. a. H. §§ ty(wi43. Questo itoc
- Page 421 and 422:
23. a. H. M7, r48. § 647. — (Cfi
- Page 423 and 424:
23. a. H. §§ 64*651. ghid), o da}
- Page 425 and 426:
23. a. H. §§ G57-tìtìO. § 657.
- Page 427 and 428:
23. a. H. 6664571. Avzàr b. Hura^'
- Page 429 and 430:
23. a. H. §S 673, 674. destinato a
- Page 431 and 432:
23. a. H. §§ 676, 677. La confusi
- Page 433 and 434:
23. a. H. I e79. tari di Roma e del
- Page 435 and 436:
23. a. H. §§ IW1-C88. tutti accet
- Page 437 and 438:
23. a. H. §§ «a'i-esT. (b) l'Say
- Page 439 and 440:
23. a. H. § lìf'i. lilevato il Be
- Page 441 and 442:
io. a. H. g ^g.} non ciistiane e no
- Page 443 and 444:
23. a. H. §§ tì94-«t»7. tiidii
- Page 445 and 446:
23. a. H. 698. islamico. Tali sono
- Page 447 and 448:
23. a. H. §§ 699-70*;. tivarla tu
- Page 449 and 450:
2o. E. U. I 710 La concessione di t
- Page 451 and 452:
23. a. H. §§ 711-716. 11 Becker [
- Page 453 and 454:
Cfi-. Maqrìzi Ivhitat, II. 136, li
- Page 455 and 456:
23. a.. H. t: 71!). § 719. — rma
- Page 457 and 458:
23. a. H. §§ 12-^l-M. § 722. —
- Page 459 and 460:
23. a. H. §§ 731-733. Se lo fa è
- Page 461 and 462:
23. a. H. § 738. bite fonti di ric
- Page 463 and 464:
23. a. H. g§ 734 735 mica con pret
- Page 465 and 466:
23. a. H. 735-737. ci spiega come e
- Page 467 and 468:
23. a. H. §§ 739-748. ibn abi Lay
- Page 469 and 470:
23. a. H. §§ 747-751. È chiaro c
- Page 471 and 472:
23. a. H. §§ 75(;.7ai. 38. liu. 4
- Page 473 and 474:
co. a. ri. g§ 7(i3.7(;5, si comper
- Page 475 and 476:
23. a. H. §§ 7ee-7«i». Esiste p
- Page 477 and 478:
23. a. H. §§ 770, 771. Ciò spieg
- Page 479 and 480:
23. a. H. §g 771 77. ebrei e le sc
- Page 481 and 482:
23. a. H. §§ 772, 773. bilonese,
- Page 483 and 484:
23. E. n. g 774 terzo, o un quarto,
- Page 485 and 486:
23. a. H. 776, 777. 24 e nota 1). L
- Page 487 and 488:
23. a. H. 5§ 778, 779. piante. La
- Page 489 and 490:
23. a. H. § 780. sborsata in danar
- Page 491 and 492:
23. a. H. §§ 781, 782! |irima. e
- Page 493 and 494:
23. a. H. §§ 782, 783. cose, di c
- Page 495:
«.il- t-' \
- Page 498 and 499:
23. a. H. [Le condizioni fi- scali
- Page 500 and 501:
23. a. H. [Le condizioni fi- scali
- Page 502 and 503:
' 792, 793. 23. a. H. 23. a. H. giz
- Page 504 and 505:
§§ 798, 794. 23. a. H. 23. a. H.
- Page 506 and 507:
23. a. H. ziono o ccrtn. Notevole
- Page 508 and 509:
23. a. H. |Le condizioni fi- scali
- Page 510 and 511:
f 810, 23. a. H. 23. a. H. senza re
- Page 512 and 513:
23. a. H. [Le condizioni fi- scali
- Page 514 and 515:
§ 812. ^"* ^' "• 23. a. H. saran
- Page 516 and 517:
§§ 813, 8ii. 23. a. H. 23. a. H.
- Page 518 and 519:
§§ 816, 816. 23. a. H. 23. a. H.
- Page 520 and 521:
« 8I1 23. a. H. 23. a. H. (^Yn sic
- Page 522 and 523:
23. a. H. § 818. 23. a. H. poi'aii
- Page 524 and 525:
§§ «19, tófJ. ^"' ^' "• 23. a
- Page 526 and 527:
della sua vita e del suo califfato.
- Page 528 and 529:
§ 821. 23. a. H. 23. a. H. ,|i non
- Page 530 and 531:
§§ H2J, USÒ. ""• ^' **• 23.
- Page 532 and 533:
della sua vita e del suo califfato.
- Page 534 and 535:
g§ 834, 825. 23. a. H. 23. a. H. i
- Page 536:
$§ 826, 826. 23. a. H. 23. a. H. i
- Page 540 and 541:
§ 827. ^^' ^* 23. a. H. qualche mo
- Page 542 and 543:
§§ 828, 829. 23. a. H. 23. a. H.
- Page 544 and 545:
§§ 829, 830. 23. a. n. 23. a. H.
- Page 546 and 547:
$ 830. 23. a. H. 23. a. H. opportun
- Page 548 and 549:
§§ 8i3o, 831. 23. a. H. 23. a. H.
- Page 550 and 551:
s§ ti3i, «32, 23. a. H. 23. a. H.
- Page 552 and 553:
§s 882, 833. 23. a. H. 23. a. H. c
- Page 554 and 555:
9§ 838, 834. 23. a. H. 23. a. H. R
- Page 556 and 557:
della sua vita e del suo califfato.
- Page 558 and 559:
§ H3t;. 23. a. H. 23. a. H. § 836
- Page 560 and 561:
§ 837. 23. a,. H. 23. a. H. ^ dell
- Page 562 and 563:
s 837. 23. a. H. 23. a. H. anche un
- Page 564 and 565:
23. a. H. delia sua vita e del suo
- Page 566 and 567:
§ 889. Ciò, 2l, H. 23. a. H. aiit
- Page 568 and 569:
$§ 840, 841. 23. a. H. 23. a. H. ,
- Page 570 and 571:
23. a. H. debbono essere accolte co
- Page 572 and 573:
H42, 343. 23. a. H. 23. a. H. grand
- Page 574 and 575:
della sua vita e del suocaliKato.
- Page 576 and 577:
5§ MG, 847. 23. a. H. 23. a. H. fa
- Page 578 and 579:
23. a. H III Califfo Umar: § 848.
- Page 580 and 581:
23. a. H. [ji queste tenebre senza
- Page 582 and 583:
§ 849. 23. a. H. 23- a- ^- [II Cal
- Page 589:
o cg fnCC o 1) E e «) r i/> > e ai