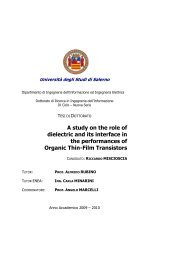- Page 1 and 2:
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
- Page 3 and 4:
canto dell’Inferno; nel 1896 Luig
- Page 5 and 6:
È il vate Carducci che, durante tu
- Page 7 and 8:
Benedetto Croce perentoriamente aff
- Page 9 and 10:
del secolo» estratto «dall’uso
- Page 11 and 12:
’U ’Nfiernu ***** Nel Medioevo
- Page 13 and 14:
Scervini ha colto in pieno che il r
- Page 15 and 16:
de mia cuntrariu, ccu la vucca anca
- Page 17 and 18:
E di virtuti nu mudiellu veru, chis
- Page 19 and 20:
si confondono con l’ambiente mime
- Page 21 and 22:
[...] L’autra è Didona (si ammaz
- Page 23 and 24:
mestizia profonda” in questo epis
- Page 25 and 26:
***** Il canto VIII può essere def
- Page 27 and 28:
Hau scilli ranni, faccia e cuollu u
- Page 29 and 30: dei diavoli sta per scoppiare e il
- Page 31 and 32: ***** Il canto XXVI è famoso per l
- Page 33 and 34: Il primo dei bambini si abbatte al
- Page 35 and 36: L’idea di peccati lievi, quotidia
- Page 37 and 38: L’espressione «alquanto surga»
- Page 39 and 40: ***** La lunga perifrasi del second
- Page 41 and 42: t’ ’u dicu e rispunnu è il seg
- Page 43 and 44: lontano i rintocchi dell’avemmari
- Page 45 and 46: nome di Guglielmo Aldobrandeschi po
- Page 47 and 48: : «O fratu, lu munnu è ciecu e tt
- Page 49 and 50: In questi versi Scervini, come Dant
- Page 51 and 52: «Tantu m’è biellu e ddurci s’
- Page 53 and 54: «Danti, pecchì Virgiliu se nn’
- Page 55 and 56: traduzioni dialettali si lasciano a
- Page 57 and 58: complessive cc. 229 non numerate (l
- Page 59 and 60: VARIANTI - ’U ’Nfiernu Nell’a
- Page 61 and 62: XXIII.98 a penninu] appenninu XXIV.
- Page 63 and 64: IX.88. è ’n cielu] e ncielu IX.1
- Page 65 and 66: ’U ’Nfiernu 64
- Page 67 and 68: CANTU I Smarrimento di Dante nella
- Page 69 and 70: ’Ngignatu appena a sàgliari chil
- Page 71 and 72: Fuozi pugheta, e dissi cumu ’u gi
- Page 73 and 74: Salute è dde l’Italia povarella,
- Page 75 and 76: CANTU II Invocazione alle Muse (1-9
- Page 77 and 78: Ca si a veniri sugnu obbedientu chi
- Page 79: Quannu fazzu rituornu avanti a Ddiu
- Page 83 and 84: CANTU III L’ingresso nell’Infer
- Page 85 and 86: Sunu mišcati all’angiuli chi gue
- Page 87 and 88: chi su’ ’ssi genti? E qualu è
- Page 89 and 90: Cumu cadinu ’i pampini all’autu
- Page 91 and 92: CANTU IV Risveglio di Dante (1-12)
- Page 93 and 94: Ppe ’ssu difiettu e nno ppe d’a
- Page 95 and 96: Tannu chilli gridaru ccu d’amuru:
- Page 97 and 98: Viddi Elettra e lli cumpagni errant
- Page 99 and 100: CANTU V Dante e Virgilio giungono n
- Page 101 and 102: Sieppi ch’eranu fatti ssi trummie
- Page 103 and 104: Rispusi: «Quannu a nnua vicinu sta
- Page 105 and 106: Puru na cosa ’e tia vuogliu sapir
- Page 107 and 108: CANTU VI I golosi riversi a terra,
- Page 109 and 110: stavanu stisi ’n terra tutti quan
- Page 111 and 112: Regna ppe lluongu tiempu lu dannatu
- Page 113 and 114: Rispusi: «Chini ha coru ed ha cusc
- Page 115 and 116: e nua scinnimmu intra la quarta gru
- Page 117 and 118: ’Nnitiernu fau ssi ’ntuppi disp
- Page 119 and 120: Mentri chi ’e tutti quanti è jje
- Page 121 and 122: CANTU VIII Misteriosi segnali lumin
- Page 123 and 124: Ed iu lli dissi: «Ccu chiantu e cc
- Page 125 and 126: Lu Mastru mi dicetti: «’U fuocu
- Page 127 and 128: Chiudirinu li porti, ’i disperati
- Page 129 and 130: Ed illu mi rispusi ccu cuntiegnu:
- Page 131 and 132:
«Vegna Medusa, e vua petrificati»
- Page 133 and 134:
«O cacciati da Ddiu, tutti difetta
- Page 135 and 136:
Su’ apparigliati, intra ’ssi va
- Page 137 and 138:
Alla dimmanna tua, nno ppe faguru,
- Page 139 and 140:
De ’ntuornu mi guardau, ccu n’a
- Page 141 and 142:
Iu dissi: «Si ripuosu e ssi putenz
- Page 143 and 144:
CANTU XI Sosta presso la tomba di p
- Page 145 and 146:
mperciò micidianti, mmurmurusi mal
- Page 147 and 148:
Nun ti arricuordi de chilli paroli,
- Page 149 and 150:
CANTU XII Il Minotauro (1-30) - Ori
- Page 151 and 152:
Mma puocu tiempu prima, amicu caru,
- Page 153 and 154:
Nua n’accostammu a chilli uorchi
- Page 155 and 156:
Mi mustrau n’urma chi stava dde b
- Page 157 and 158:
CANTU XIII La selva dei suicidi: Pi
- Page 159 and 160:
Mo simu struppi e prima eramu genti
- Page 161 and 162:
E nun parratti cchiù: «Mo chi sta
- Page 163 and 164:
D’arrieti ad illi la sirvia era c
- Page 165 and 166:
CANTU XIV La landa infuocata del te
- Page 167 and 168:
de cuntini cadìa llu ternu fuocu e
- Page 169 and 170:
Lu siettu, ’i cuosti, ’i llati
- Page 171 and 172:
Iu dissi: «O Mastru miu, dduvi si
- Page 173 and 174:
Mentri chi mi guardavanu allu scuru
- Page 175 and 176:
ca la sciorta n’onuru ti pripara;
- Page 177 and 178:
dintra ’ssa fezza chillu distingu
- Page 179 and 180:
ca si nun fussi ppe lla vampa arden
- Page 181 and 182:
Lassu sti luochi amari, hai de vula
- Page 183 and 184:
Alli fianchi tenìa nna corda strin
- Page 185 and 186:
CANTU XVII Terzo girone del settimo
- Page 187 and 188:
sbrigati priestu, e pensa a ritorna
- Page 189 and 190:
Lu luocu chi scinnimu è truoppu sg
- Page 191 and 192:
Scinni stancatu ’e fa llu gappuni
- Page 193 and 194:
Nua ccà scinnimmu de li cuosti ruo
- Page 195 and 196:
E nun ci sugnu iu sulu Bolognisu ch
- Page 197 and 198:
Li ripi eranu untati de ’na muffa
- Page 199 and 200:
CANTU XIX Terza bolgia dell’ottav
- Page 201 and 202:
«Tu chi stai capusutta - lli diciv
- Page 203 and 204:
Mma tannu, ’un sacciu chi pazzia
- Page 205 and 206:
CANTU XX Quarta bolgia: indovini e
- Page 207 and 208:
Vidi Tiresia, faccia de briganti, p
- Page 209 and 210:
De ccà passannu, la virgina cana,
- Page 211 and 212:
Vidi li tristi, chi l’acu lassaru
- Page 213 and 214:
Mentri chi attientu llà sutta guar
- Page 215 and 216:
Ccu quanta furia, ccu quanta timpes
- Page 217 and 218:
Ma si de jiri avanti assai vi giova
- Page 219 and 220:
CANTU XXII Nella quinta bolgia, cer
- Page 221 and 222:
O Russantinu, fallu vitti vitti, sc
- Page 223 and 224:
mma ppe dinaru lli dezi perdunu, e
- Page 225 and 226:
cumu natrella, chi si tuffa tutta i
- Page 227 and 228:
’N capu li mia capilli eranu azat
- Page 229 and 230:
De fori abbaglia, ch’ha d’uoru
- Page 231 and 232:
quannu ’u cuviernu nua teniamu
- Page 233 and 234:
CANTU XXIV Sgomento e conforto di D
- Page 235 and 236:
chi ’na costa è cchiù d’auta
- Page 237 and 238:
L’Africa nira ccu tanti amminazzi
- Page 239 and 240:
Ed iu allu Mastru: «Fa’ chi nun
- Page 241 and 242:
CANTU XXV Bestemmia di Vanni Fucci
- Page 243 and 244:
quannu gridaru tutti: «E vua chi s
- Page 245 and 246:
Cumu lucerta, quannu cchiù quadìa
- Page 247 and 248:
s’azau lla serpa e l’omu si cur
- Page 249 and 250:
CANTU XXVI Invettiva contro Firenze
- Page 251 and 252:
illu ccu ll’uocchi û llu potìa
- Page 253 and 254:
«O vua, chi siti dua dintra a ’n
- Page 255 and 256:
ed a llevanti votatu lu schinu, for
- Page 257 and 258:
Mma quannu trovau menzu d’allunga
- Page 259 and 260:
A Cisena, chi sta ’mmienzu allu c
- Page 261 and 262:
E cumu a Suliviestru ’e ’nu gru
- Page 263 and 264:
CANTU XXVIII Nona bolgia: i seminat
- Page 265 and 266:
Quannu passamu chista affritta stra
- Page 267 and 268:
Lu tradituru, ch’ha l’uocchi al
- Page 269 and 270:
Quannu ’mpedi allu pontu fa ferma
- Page 271 and 272:
Tannu rispusi: «Li tua penzamienti
- Page 273 and 274:
Chi trippa a trippa e chini spalli
- Page 275 and 276:
«Fuozi d’Arezzu, ed Arburu Senis
- Page 277 and 278:
CANTU XXX Decima bolgia: i falsari
- Page 279 and 280:
Lu sua gran fallu cummittìu cangia
- Page 281 and 282:
intra ’sta genta scongia lu trova
- Page 283 and 284:
L’autru rispusi: «Vucca verminus
- Page 285 and 286:
CANTU XXXI Similitudine tra la ling
- Page 287 and 288:
ccussì grupannu ’a neglia fitta
- Page 289 and 290:
Merati ’n cuollu, e tocca ccu ddi
- Page 291 and 292:
lejuni a mmilli, prisi ccu fermizza
- Page 293 and 294:
CANTU XXXII Nono cerchio: i tradito
- Page 295 and 296:
La faccia ugnunu avìa ’nsutta vo
- Page 297 and 298:
nun sacciu si ppe voglia o ppe furt
- Page 299 and 300:
Giuvannu Sordunieru si vidìa cchi
- Page 301 and 302:
CANTU XXXIII Il Conte Ugolino racco
- Page 303 and 304:
Ccu cani macri, lesti cumu acielli,
- Page 305 and 306:
Ccussì diciennu, ’e truvudu guar
- Page 307 and 308:
Rispusi: «Si n’ajutu t’haiu de
- Page 309 and 310:
CANTU XXXIV Quarta zona del nono ce
- Page 311 and 312:
parìa lla destra menza janca e gia
- Page 313 and 314:
Azai l’uocchi e crisi ca vidìa l
- Page 315 and 316:
Iu, ccu llu Mastru ’e ’ssu varc
- Page 318 and 319:
CANTU I Prologo e Invocazione alle
- Page 320 and 321:
viddi vicinu a mmia ’nu viecchiu
- Page 322 and 323:
Cumu nni ll’haiu cacciatu a tti c
- Page 324 and 325:
Doppu de ccà ppe vua nun ci è rri
- Page 326 and 327:
CANTU II L’alba del 10 Aprile del
- Page 328 and 329:
iu lu vasciavi e l’Angiulu scinn
- Page 330 and 331:
Una nni viddi veniri cchiù avanti,
- Page 332 and 333:
Stavamu tutti ’ncantati ed attien
- Page 334 and 335:
Iu mi votai de latu ccu pagura d’
- Page 336 and 337:
quannu a sinistra vidivi de genti
- Page 338 and 339:
Una d’illi ’ngignau: «Ccu qual
- Page 340 and 341:
cchiù trenta voti ’e d’ ’u t
- Page 342 and 343:
Vadu cchiù rrannu lu vignieru avar
- Page 344 and 345:
Quannu ’u Mastru si accorsi chi i
- Page 346 and 347:
Darriedi ugnunu ’e nua si votau s
- Page 348 and 349:
Già ’nchianava llu Mastru avanti
- Page 350 and 351:
Vienimi arriedi, e ’n ciò chi si
- Page 352 and 353:
Guarda si ’ncunu ’e nua ’n te
- Page 354 and 355:
Fuozi de Muntu Fieltru, iu su’ Bo
- Page 356 and 357:
«Quannu, piaciennu a Ddiu, tuorni
- Page 358 and 359:
Llà cci era l’Aretinu, chi abbra
- Page 360 and 361:
L’animi de stu riegnu hau perduna
- Page 362 and 363:
e tu, de capu ’mpedi, alla tunnar
- Page 364 and 365:
Fiurenza mia, tu pua stari cuntenta
- Page 366 and 367:
CANTU VlI Valletta dei principi neg
- Page 368 and 369:
Llà staiu ccu tanti guagliuni ’n
- Page 370 and 371:
Tra ’mparu ed irtu cci era nna vi
- Page 372 and 373:
Ottachiru appi nnumu, intra li fasc
- Page 374 and 375:
Vidìti ’u Rre chi fo dde giusta
- Page 376 and 377:
l’autri, tutti divoti, ccu ddurci
- Page 378 and 379:
Quannu ’nsiemu ni fummu arricosta
- Page 380 and 381:
Ccussì diciennu, mustrava dde fori
- Page 382 and 383:
Lu gridu, ch’ha lla vostra casa b
- Page 384 and 385:
’n suonnu suspisa mi parìa vidir
- Page 386 and 387:
nna donna vinni, e dissi: «Iu su
- Page 388 and 389:
Llà jimmu nua; lu scalunu primaru
- Page 390 and 391:
Iu stiezi attientu a chillu primu t
- Page 392 and 393:
prima d’esciari de chilla spaccaz
- Page 394 and 395:
Lu fumu de lu ’ncienzu si vidìa
- Page 396 and 397:
«Guarda de ccà, mma tardannu ’i
- Page 398 and 399:
e dduna peni a chini l’affigura,
- Page 400 and 401:
La nostra forza spissu n’abbannun
- Page 402 and 403:
Tata ’n Toscana lu sua cippu teni
- Page 404 and 405:
Ccussì passatti d’unu all’autr
- Page 406 and 407:
ppe cacciari n’amicu de doluru, m
- Page 408 and 409:
e spissu chini guarda, s’addolura
- Page 410 and 411:
E la distruzzioni a llumu chiaru fa
- Page 412 and 413:
Mi porta dduvi ’a trempa era tagl
- Page 414 and 415:
CANTU XIII Dante e Virgilio sono ne
- Page 416 and 417:
Lu Mastru dissi: «Ccà sunu ’n c
- Page 418 and 419:
Illu de la cornici jia de banna, pp
- Page 420 and 421:
quannu a Cuollu vidivi a nnu truppi
- Page 422 and 423:
CANTU XIV Colloquio di due anime fr
- Page 424 and 425:
de giustizia e virtù, senza riparu
- Page 426 and 427:
Mma pecchì lla tua menta luci ’e
- Page 428 and 429:
Li donni, i cavalieri, ’u buonu s
- Page 430 and 431:
Già s’era l’ariu de tuttu acqu
- Page 432 and 433:
Cumu quannu li raggi strillampanti
- Page 434 and 435:
diss’iu: «Cchiù parru e cchiù
- Page 436 and 437:
vuogliu minnitta de chillu malignu
- Page 438 and 439:
CANTU XVI Dante e Virgilio nel fumo
- Page 440 and 441:
45 Dimmi che fusti prima de moriri,
- Page 442 and 443:
Mma s’allu munnu vua cangiati via
- Page 444 and 445:
Sunu Curradu Palazzu, Girardu e Gui
- Page 446 and 447:
CANTU XVII Dante e Virgilio escono
- Page 448 and 449:
Ti ammazzasti ppe ’un perdari Lav
- Page 450 and 451:
Ed iu stiezi ’nu puocu a ’nterg
- Page 452 and 453:
Ppe ssi tri sciorti d’amuri ccà
- Page 454 and 455:
Illu rispusi: «Nversa a mmia ’nd
- Page 456 and 457:
Chi ’n cori havi cumu apa ’u pi
- Page 458 and 459:
«Maria cursi ccu pressa alla munta
- Page 460 and 461:
e lla genta, chi peni ’un suffere
- Page 462 and 463:
on priestu la persuna adderizzava;
- Page 464 and 465:
«Chid hai ca ’n terra cuntinu gu
- Page 466 and 467:
Dissi: «Li guaji mia vuogliu cunta
- Page 468:
Si vua sapiri la ragiuna mia, pensa
- Page 471 and 472:
Nua jiamu caminannu lienti lienti,
- Page 473 and 474:
Iu nascivi a Parigi ’e ’nu chia
- Page 475 and 476:
Ppecchì ’un parissi lu malu oper
- Page 477 and 478:
Quannu d’ ’u beni ’e d’ ’
- Page 479 and 480:
CANTU XXI Apparizione dell’ombra
- Page 481 and 482:
Mma dicimi, si ’u sai, ppecchì t
- Page 483 and 484:
’Mperò sentisti tremari e llu ri
- Page 485 and 486:
e «Ppe lla bona strata ch’hai de
- Page 487 and 488:
CANTU XXII Salita alla sesta cornic
- Page 489 and 490:
E, s’un avissi avutu lu picunu, d
- Page 491 and 492:
Ppe ttia fuozi pugheta e cristianu,
- Page 493 and 494:
Ccu Antifunu ed Euripudu accucchiat
- Page 495 and 496:
All’arburu illi dua s’avvicinar
- Page 497 and 498:
Cumu ’i penzusi viaggiaturi fanu,
- Page 499 and 500:
ma dimmi ’a verità, nun mi ’ng
- Page 501 and 502:
Fratu, cchi ti dicu iu? ’Nu tiemp
- Page 503 and 504:
CANTU XXIV Forese Donati parla dell
- Page 505 and 506:
Vidivi lu Marchisu, ch’appi spazz
- Page 507 and 508:
E cumu omu chi stancu caminannu las
- Page 509 and 510:
Genti avìa sutta ch’azava lli ma
- Page 511 and 512:
Cumu pujia de maju chi li juri, men
- Page 513 and 514:
Sicuru tannu ’a vucca vuozi ancar
- Page 515 and 516:
Mma cumu d’animalu cangia statu e
- Page 517 and 518:
Eramu juti all’urtima turtura, vo
- Page 519 and 520:
CANTU XXVI 12 Aprile 1300. Ultima c
- Page 521 and 522:
Mma ddocca spiccia st’accoglienza
- Page 523 and 524:
Peccammu, ciuoti nua, cuntra natura
- Page 525 and 526:
Ccussì l’antichi Guittonu avanta
- Page 527 and 528:
CANTU XXVII L’Angelo della castit
- Page 529 and 530:
ccussì lla capu mia s’arrimollat
- Page 531 and 532:
nua tutti i tria, ccussì parìamu
- Page 533 and 534:
e dissi: «’U fuocu ternu ccu l
- Page 535 and 536:
cumu si quietu punentu si sciogli p
- Page 537 and 538:
jiu ppe supra li juri russi e giall
- Page 539 and 540:
Ppecchì ’u strubbu chi sutta ’
- Page 541 and 542:
Chilli ch’anticamenti nni cuntaru
- Page 543 and 544:
Quandu ’nu lustru subitu scurrien
- Page 545 and 546:
Pua lli rrimiru, e cchiù maravigli
- Page 547 and 548:
mma lieji Zacchijelu ch’i dipingi
- Page 549 and 550:
l’autru mustrava ’na cuntraria
- Page 551 and 552:
de cussì dintra ’a divina carret
- Page 553 and 554:
supra lu carru alla sinistra banna
- Page 555 and 556:
«Vua sutta ’a luci terna vigilan
- Page 557 and 558:
Lu decretu de Ddiu sarìa spezzatu,
- Page 559 and 560:
ccussì pativi sutta chilla prisa,
- Page 561 and 562:
Li pinni ’n terra nun ddovìa cal
- Page 563 and 564:
La bella donna li vrazzi apiretti,
- Page 565 and 566:
o quantu mi paristi risbriannenti q
- Page 567 and 568:
votati a ddestra manu viddi chilli
- Page 569 and 570:
’ngroscanu i zicchi jocati ’e d
- Page 571 and 572:
Mma, ppe buonu ’e d’ ’u munnu
- Page 573 and 574:
Li primi avianu ’i corna cumu vua
- Page 575 and 576:
E cussì jia, ma criu ca ’nu spun
- Page 577 and 578:
Nota quantu ti dicu e statti accuor
- Page 579 and 580:
Ed iu rispusi ad illa: «’Un tieg
- Page 581:
. Si iu tenissi, o letturu, largu s
- Page 585 and 586:
Gerundino Antonio, La Divina Commed
- Page 587 and 588:
Alighieri Dante, La Divina Commedia
- Page 589 and 590:
Rizzo Tito Lucrezio, Un romantico e
- Page 591:
’U Prigatoriu 315 Cantu I 317 Can